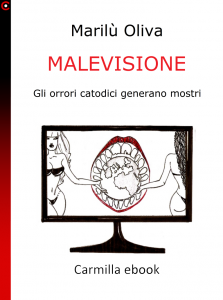di Alfio Neri
I Grundrisse di Karl Marx. Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica 150 anni dopo, a cura di Marcello Musto, prefazione di Eric Hobsbawm, Edizioni ETS, Pisa, 2015.
Da cinquant’anni mancava un’introduzione ai Grundrisse. Oggi finalmente abbiamo un testo che ci permette di affrontare i Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica. I Grundrisse sono un testo enormemente difficile sotto tutti punti di vista. Sono appunti non destinati alla pubblicazione che offrono problemi di lettura colossali. Tuttavia, dietro la loro forma contorta, essi percorrono vie analitiche molto originali non sempre sfruttate.
La storia dei Grundrisseè fortunosa. Rimasti nascosti per un secolo, pubblicati durante la Seconda Guerra Mondiale, divennero noti dopo la prima ristampa tedesca del 1953. Negli anni cinquanta non furono quasi letti e solo in seguito furono recepiti come possibile alternativa al dogmatismo dell’ortodossia sovietica. Assieme agli scritti di Gramsci e ai manoscritti economico-filosofici del 1844, i Grundrisse aprirono la via alla possibilità di un nuovo marxismo critico di cui vi era un enorme bisogno teorico.
Nonostante il loro importante apporto concettuale, i Grundrisse non furono recepiti subito. Una ragione stava nelle loro enormi difficoltà di comprensione. Il testo non era destinato alla pubblicazione e questo lo si vede ancora benissimo. Adesso, dopo cinquant’anni, finalmente abbiamo un’opera che ci permette un approccio critico. Di questo lavoro, così prezioso e così inattuale, dobbiamo ringraziare il curatore, Marcello Musto. La sua opera di analisi storico-filologico-concettuale è di un’utilità straordinaria.
Il lavoro si articola in tre parti: nella prima vi sono le interpretazioni critiche dei Grundrisse; nella seconda le vicende di Marx al tempo della loro stesura; nella terza c’è la storia straordinaria della loro diffusione e recezione.
I saggi della raccolta, che comprende i contributi di 32 autori, permettono di affrontare i testi marxiani a strati, procedendo per gradi. Il lavoro è pensato per affrontare percorsi concettuali differenti e per focalizzare tematiche analitiche differenziate. Per questi motivi, mi permetto di segnalare una serie di percorsi di lettura di questo libro. Ne rimangono comunque molti altri che, per brevità, non riporto ma che, non per questo, sono meno importanti.
La porta d’ingresso dei Grundrisseè l’ Introduzione del 1857. In questo scritto Marx afferma chiaramente che la filiera Produzione/Distribuzione/Scambio/Consumo va intesa come una totalità. Non esistono individui isolati che lavorano separatamente, così come non esistono individui separati che parlano fra loro lingue private. Analogamente il processo di produzione va inteso come una totalità organica e storico-sociale. Questi concetti sono resi (più) comprensibili dall’attento saggio di Musto Storia, produzione e metodo nella Introduzione del 18571.
Un intervento centrale è quello di Carver sull’alienazione2. Lo segnalo perché dimostra la continuità fra il concetto di alienazione presente nel giovane Marx e il concetto di sfruttamento del Marx maturo. La dimostrazione di questa continuità di temi, fa tramontare definitivamente l’interpretazione di Althusser imperniata sull’ipotesi di una cesura epistemologica fra il giovane Marx e il Marx maturo3.
Un altro contributo rilevante riguarda le Forme che precedono la produzione capitalistica. Questa sezione, in passato pubblicata separatamente dagli Editori Riuniti, è illuminata dal saggio di Ellen Meiksins Wood4. L’autrice evidenzia i contributi storiografici degli ultimi decenni, rileva come Marx, mentre sviluppa la sua analisi storico-sociale, diventi sempre meno determinista, dimostra in modo convincente che la sequenza Modo di Produzione Asiatico-Classico-Feudale-Capitalistico non ha alcun valore teleologico.
Il cuore incandescente del dibattito teorico è però incentrato sulla teoria del Valore. Questo concetto è analizzato, ricostruito e riconfrontato con la tarda modernità nell’importante saggio di Postone5, forse il più importante dell’intera raccolta. Si tratta di un saggio che, per quanto sembri un commento esegetico, in realtà è l’abbozzo di un orizzonte marxiano di superamento dell’ortodossia marxista.
In questo momento, questo libro è il miglior approccio possibile alla lettura dei Grundrisse6. I saggi guardano al futuro e non hanno un’ottica antiquaria o nostalgica. Capiamoci, il passato si è ormai dileguato. Quello che conta è guardare al futuro.
Nota: Sono liberamente scaricabili qui l’indice del libro, il retro di copertina, la premessa di M. Musto, l’introduzione di Eric Hobsbawm e il saggio di M. Musto Diffusione e recezione dei Grundrisse nel mondo.- Cfr. M. Musto, Storia, produzione e metodo nella Introduzione del 1857, pp. 58-97.
- Cfr. T. Carver, La concezione marxiana dell’alienazione nei Grundrisse, pp. 118-145.
- Althusser non ha letto sul serio i Grundrisse, cfr. 352, per questo non vi trova il concetto di alienazione, cfr. p. 355.
- Cfr. E.M. Wood, Il materialismo storico nelle Forme che precedono la produzione capitalistica, pp. 161-179.
- Cfr. M. Postone, Ripensare Il Capitale alla luce dei Grundrisse, pp. 217-241.
- Esistono diverse edizioni italiane dei Grundrisse. In genere le citazioni nel libro curato da Musto fanno riferimento all’ultima: K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Manifestolibri, Roma, 2012.
Recensione ripresa da http://www.carmillaonline.com/2016/01/07/leggere-i-grundrisse/