↧
QUANDO IMPERAVA SCELBA
↧
W. BENJAMIN SU KAFKA

Il monumento in memoria di W. Banjamin a Portbou
Kafka nelle mani di Charlie Chaplin
Walter Benjamin. Opere VIII. Frammenti e Paralipomena
Kafka e Chaplin, cos’hanno in comune? Un’intelligenza dei margini della vita, dove l’esclusione dal mondo, dalla storia squarcia il velo della dissimulazione e si apre alla cognizione del dolore come destino. Un paragone improbabile? Per Benjamin i mondi della rappresentazione hanno sottili fili che li legano; al di là delle differenze- tempi, luoghi, forme artistiche- esistono affinità misteriose che consentono accostamenti e prospettive ermeneutiche imprevedibili:
“la vera chiave per interpretare Kafka è nelle mani di Chaplin. Come Chaplin crea situazioni nelle quali il reietto e il diseredato, la sofferenza umana eterna, si incontrano in modo eccezionale con le circostanze più straordinarie del nostro esistere odierno, così anche in Kafka ogni circostanza è bifronte come Giano, del tutto immemorabile, senza storia, eppure della più recente attualità giornalistica”. Questo accostamento fulminante compare in una delle molte annotazioni raccolte nel volume VIII delle Opere di Benjamin, uscito recentemente da Einaudi (W. Benjamin, Opere complete Vol.VIII,. Frammenti e Paralipomena)
Entrare in questo volume è come entrare in un labirinto in cui tuttavia non prevale la geometria dei percorsi infiniti ma la meraviglia degli accostamenti imprevedibili.
Pur nell’estrema varietà degli argomenti trattati c’è un aspetto ricorrente, che costituisce uno dei fili intorno al quale si annoda questa scrittura erratica e apparentemente dispersa in mille direzioni: sono gli accostamenti tra le presenze del contemporaneo (materiali e immaginarie) e le linee speculative di un pensiero che si sente a casa nell’atemporale pur confrontandosi di continuo con il tempo. Un cortocircuito sempre attivo tra tensione metafisica e curiositas per i frammenti della Storia.
Se l’attitudine allo sguardo micrologico e alla scomposizione della scrittura è il tratto distintivo, soprattutto dell’ultimo Benjamin- si pensi a Strada a senso unico, al Passagenwerk e al lavoro su Baudelaire- nel regesto di lacerti critici che costituisce questo volume delle Opere essa raggiunge il suo culmine.
I curatori che ne hanno scelto e ordinato i materiali li hanno suddivisi in due grandi sezioni:‘Frammenti’ e ‘Paralipomena’.
Nell’insieme si tratta di appunti, brevi aforismi, annotazioni, schemi ma anche saggi più corposi rimasti inediti o superati dalle opere compiute pubblicate successivamente. In particolare i “Frammenti” sono testi “relativamente autonomi non riferibili ad alcuna delle opere concluse” come si legge nella Nota introduttiva al volume e sono suddivisi dai curatori in otto ambiti tematici. I ‘Paralipomena’”sono materiali privi di valore autonomo e preparatori ai testi conclusi”. Là dove era possibile i curatori hanno cercato di stabilire una datazione, seguendo il criterio cronologico a cui si ispira l’edizione italiana delle Opere.
Edizione che fu avviata, lo ricordiamo, nel 1982 da Giorgio Agamben e che ebbe il merito di portare in primo piano gli aspetti genetici dell’opera benjaminiana assai più illuminanti delle partizioni tematiche seguite prevalentemente nell’edizione originale tedesca. Nel caso dell’opera benjaminiana più che in altri il desiderio di sistemazione dei posteri non rende giustizia all’obbiettiva complessità della tessitura testuale.
Il criterio cronologico adottato da Agamben ha consentito quindi di seguire le trasformazioni del suo pensiero e di individuarne le direttrici fondamentali nell’ottica delle influenze, degli incontri intellettuali, delle amicizie e della geografia dei suoi spostamenti europei.
Non si è trattato di una semplice scelta filologica, ammesso che le scelte della filologia possano dirsi ‘semplici’, ossia indifferenti alla costruzione dei significati. Si è trattato di aderire a uno stile di lavoro dell’autore, di seguirne il percorso e la progressione, di ricercare le coerenze sistematiche non nell’organizzazione esteriore degli argomenti ma nelle connessioni profonde del suo pensiero.
Dopo l’uscita dei primi cinque volumi,- l’ultimo dei quali apparve nel 1993- l’edizione Agamben si interruppe per incomprensioni con l’editore. Fu proseguita anni dopo dai curatori dell’edizione tedesca affiancati da Enrico Ganni. Il criterio cronologico voluto da Agamben fu mantenuto e a oggi sono usciti nove volumi.
![]()
![]()
L’appunto citato poc’anzi in cui il cinema di Chaplin fornisce, secondo Benjamin, la chiave per penetrare nell’universo di Kafka, è un esempio di come l’immagine si fissi in figura, vale a dire in Denkbild, in figura di pensiero. Se la storia viene spogliata di ciò che sembra essere la sua caratteristica fondamentale, il movimento e la trasformazione, essa consegna all’osservatore una serie di istantanee in cui il passato e il presente, la mobilità perenne del tempo si ferma in una paradossale fissità: è quella che in un passo del Passagenwerk Benjamin ha chiamato la “dialettica dell’immobilità”: “Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone: ogni ora è l’ora di una determinata conoscibilità. In quest’ora, la verità è carica di tempo fino a frantumarsi…Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione. In altre parole: immagine è la dialettica nell’immobilità.” (GS, V,I, pp. 577-578, cit. in W. Benjamin, Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato, Neri Pozza, Milano 2012, p. 14).
Questa idea per cui l’immagine sovverte gli schemi consueti della temporalità si manifesta nei frammenti dedicati alla critica letteraria, probabilmente fra le pagine più rivelatrici del metodo di Benjamin. Qui è in discussione la figura del critico, la sua relazione con il testo, la storicità del suo sguardo e di quello dell’opera a cui si rivolge. Gli schemi della storiografia sociologica e in particolare di quella marxista si scontrano con l’esigenza di autonomia dell’opera stessa. Che non è distanza dal mondo o essenza ineffabile ma la necessità intrinseca di negarsi ad un giudizio che ha di mira il solo contenuto oggettivo dell’opera, vale a dire “ solo quanto vi viene espresso”. Il vero critico è colui che sa “guardare dentro l’opera”, che ne osserva la stratigrafia e sa cogliere sotto la superfice mobile degli oggetti e degli eventi rappresentati ciò che si sottrae al tempo e alla contingenza, ossia il contenuto di verità.
In un lungo frammento dedicato alla “Falsa critica”, risalente al 1930-31 Benjamin stigmatizza la miopia di chi non vede i rapporti che si celano nella costruzione testuale: “Imparare a guardare dentro l’opera significa avere maggiore contezza di come contenuto oggettivo e contenuto di verità si intreccino all’interno dell’opera stessa” (…) “E questa, purtroppo, è la situazione in cui viene a trovarsi quasi tutto ciò che da noi è noto come critica marxista. Si arriva quasi sempre a un fitto tracciato di linee all’interno delle opere, là dove a tratti viene alla luce il contenuto, se non addirittura la tendenza sociale. Tutto questo, però, non conduce dentro l’opera, ma porta unicamente a delle semplici affermazioni sull’opera stessa”.
Lo sguardo rivolto verso ciò che nell’opera è celato, ossia verso il suo nucleo di verità rende necessaria un’ “estetica deduttiva”, ossia una definizione trascendente in cui si fissa un significato dell’esperienza artistica che è insieme originario ed escatologico.
Ma proprio in quanto veicolo di un contenuto di verità l’opera perde paradossalmente il suo connotato estetico, l’arte come artificio funzionale alla mediazione di un contenuto scompare per fare posto a una relazione diretta tra il singolo fenomeno artistico e un’ idea in senso platonico. “L’arte- scrive Benjamin in un altro frammento dello stesso periodo- è solo un momento di passaggio delle grandi opere. Sono divenute qualcos’altro (nella fase del loro divenire) e diventeranno qualcos’altro (nella fase della critica)” .
Critica, opera e divenire sono categorie protoromantiche: il Benjamin di questi anni, che progettava un saggio sulla critica letteraria, attinge al lessico di Friedrich Schlegel e alla sua idea di una critica infinita e immanente all’opera. Non dunque la critica nel senso abituale di giudizio estetico ma come ciò che rende cosciente l’opera a se stessa e ne potenzia il significato, vale a dire ne stimola la relazione tra il contingente (il suo contenuto materiale, la sua relazione col tempo storico) e l’infinito, l’ideale, ciò che trascende il tempo della storia. La definizione che ne dà è “critica magica”
Altrettanto centrale è l’idea di sopravvivenza dell’opera, che Benjamin inizia a formulare negli appunti degli stessi anni, e che troveranno un momento di aggregazione più stabile nel saggio su “Storia della letteratura e scienza della letteratura del 1931”. “La teoria della sopravvivenza delle opere è mossa dal pensiero dominante che questa sopravvivenza smascheri come pura illusione l’idea dell’«arte» intesa come disciplina a se stante”.
L’arte non è uno spazio di costruzione estetica autonomo rispetto alla storia ma il luogo in cui “le macerie generate dal tempo” offrono al critico i materiali su cui esercitare la sua opera di smontaggio e ricomposizione.
![]()
Hanna Arendt chiamò Benjamin un “pescatore di perle”; ebbene fra le molte perle di questo volume spicca la riflessione sul kitsch e sulla sua relazione con l’arte popolare che Benjamin consegna ad un lungo frammento risalente verosimilmente al 1929. “Arte popolare e kitsch devono essere considerati una volta per tutte come un unico grande movimento che fa passare di mano in mano determinati contenuti come se fossero staffette alle spalle di ciò che viene chiamata la grande arte.”
In questi territori della sensibilità e dell’immaginario collettivi, che la concezione dell’arte esclude ancora oggi dal suo ambito, si realizzano evocazioni e appartenenze ancestrali.
“Tutta l’arte popolare attira e chiama a sé l’uomo: gli si rivolge in modo tale da costringerlo a rispondere. O meglio, a rispondere con domande del tipo: «Dove? E quando è stato?» In lui affiora l’idea che quel preciso spazio e luogo e che quel dato momento, quella posizione solare debbano già essere esistiti una volta nella sua vita. La situazione che viene così riattualizzata, di sentirsi come avvolti in un vecchio cappotto- è la più potente attrattiva che evoca il ritornello della canzonetta in cui è possibile cogliere, come riflesso nell’opera, un tratto fondamentale di tutta l’arte popolare”.
Arte popolare e kitsch agiscono sugli strati profondi e inconsci del nostro io, là dove emerge il primitivo, la fantasia che riveste il reale di un’aura onirica “…che illuminando in un baleno l’oscurità dell’io e del carattere e facendo spazio all’interpolazione dei tratti più sorprendenti, più oscuri e più chiari, agisce anche contro il nostro destino (…) ci ritroviamo ad essere dominati dalla convinzione di avere vissuto infinitamente di più di quanto ci sia dato sapere”.
L’effetto di tali forme artistiche minori è una scissione tra la parte razionale del nostro io, che si fonda sull’oggettivazione del mondo e sulla relazione soggetto- oggetto, e il senso di originaria appartenenza a un tutto in cui un’altra parte di noi tende a rifluire.
“Ciò che si è vissuto in modo inconsapevole ha un suono particolare con il quale ci addentriamo nel mondo dei primitivi, nei loro arredi, nei loro ornamenti, nei loro canti, nelle loro immagini. Un suono particolare- ovvero un suono che ci tocca in modo completamente diverso rispetto alla grande arte. Davanti a un dipinto di Tiziano o di Monet non sentiamo mai la tentazione di caricare l’orologio e di definire l’ora in base alla posizione del sole riflessa nel quadro che ci sta davanti. Ma con le illustrazioni riportate nei libri per bambini, con le pitture di Utrillo che, in questo senso, comunque, riprendono perfettamente il primitivo, tutto questo può capitarci facilmente”.
In questo territorio di confine tra il sonno e la veglia, in cui la fantasia non si interroga su se stessa ma si abbandona all’attrazione dell’originario, a dominare è uno stato di reminiscenza, che non è l’anamnesi platonica ma piuttosto un sentimento di déjà vu, che “si trasforma così in una forza dal potere magico al cui servizio si pone l’arte popolare (e il kitsch nondimeno)”.
![Memorial di Walter Benjamin a Portbou]()
Memorial di Walter Benjamin a Portbou
Le reminiscenze fuori controllo che ci vengono incontro da un remoto passato Benjamin le chiama “maschere del destino”. E sono loro, come le maschere dei primitivi, a prendere il sopravvento sui nostri fragili progetti di senso.
Grande arte e kitsch, Arte con la a maiuscola e arte popolare rappresentano dunque una contrapposizione che supera il perimetro estetico. Non è una questione di bello o brutto, di stile o di gusto. Qui si evidenzia una polarità tra la moderna idea di soggetto, quello cartesiano, e poi illuministico e kantiano, quello che pretende di controllare razionalmente il mondo, e assegna all’arte la funzione di idealizzare l’umano nella compostezza formale dello stile, e una dimensione dell’io governata dalle potenze mitiche, dai disegni del destino, dall’inconscio collettivo.
Questo percorso argomentativo, che conserva intatta la sua presa analitica anche se applicato alle molte espressioni della cultura pop dei nostri anni, si conclude con un implicito riferimento all’idea stessa della critica: mentre “l’arte ci insegna a vedere dentro alle cose, l’arte popolare e il kitsch ci permettono di vedere a partire da dentro alle cose”.
Come aveva dimostrato nella sua evidenza icastica la mostra Walter Benjamin Archives allestita nel 2011 al Musée d’art et d’histoire du Judaïsme di Parigi la misura più consona al saggismo benjaminiano è la forma minima, l’elenco, la citazione, l’appunto, la stessa materialità della grafia minuscola, quasi una sfida alla decrittazione, il montaggio dell’eterogeneo, la ricerca delle sinestesie concettuali.
Il volume VIII delle Opere offre al lettore una visione ravvicinata e particolarmente significativa del laboratorio filosofico del pensatore berlinese, se ne vedono gli attrezzi, si capisce da dove provengano i materiali, le mappe e le carte da cui hanno preso inizio i diversi progetti di costruzione. Una specie di immenso cantiere in cui è facile immaginarlo mentre si aggira come il mago descritto da Adorno con cappello a punta e bacchetta magica.
Una versione più breve è apparsa su Alias Domenica de il manifesto
“la vera chiave per interpretare Kafka è nelle mani di Chaplin. Come Chaplin crea situazioni nelle quali il reietto e il diseredato, la sofferenza umana eterna, si incontrano in modo eccezionale con le circostanze più straordinarie del nostro esistere odierno, così anche in Kafka ogni circostanza è bifronte come Giano, del tutto immemorabile, senza storia, eppure della più recente attualità giornalistica”. Questo accostamento fulminante compare in una delle molte annotazioni raccolte nel volume VIII delle Opere di Benjamin, uscito recentemente da Einaudi (W. Benjamin, Opere complete Vol.VIII,. Frammenti e Paralipomena)
Entrare in questo volume è come entrare in un labirinto in cui tuttavia non prevale la geometria dei percorsi infiniti ma la meraviglia degli accostamenti imprevedibili.
Pur nell’estrema varietà degli argomenti trattati c’è un aspetto ricorrente, che costituisce uno dei fili intorno al quale si annoda questa scrittura erratica e apparentemente dispersa in mille direzioni: sono gli accostamenti tra le presenze del contemporaneo (materiali e immaginarie) e le linee speculative di un pensiero che si sente a casa nell’atemporale pur confrontandosi di continuo con il tempo. Un cortocircuito sempre attivo tra tensione metafisica e curiositas per i frammenti della Storia.
Judith Butler talking about Walter Benjamin's notion of the gesture in Franz Kafka's parables
Se l’attitudine allo sguardo micrologico e alla scomposizione della scrittura è il tratto distintivo, soprattutto dell’ultimo Benjamin- si pensi a Strada a senso unico, al Passagenwerk e al lavoro su Baudelaire- nel regesto di lacerti critici che costituisce questo volume delle Opere essa raggiunge il suo culmine.
I curatori che ne hanno scelto e ordinato i materiali li hanno suddivisi in due grandi sezioni:‘Frammenti’ e ‘Paralipomena’.
Nell’insieme si tratta di appunti, brevi aforismi, annotazioni, schemi ma anche saggi più corposi rimasti inediti o superati dalle opere compiute pubblicate successivamente. In particolare i “Frammenti” sono testi “relativamente autonomi non riferibili ad alcuna delle opere concluse” come si legge nella Nota introduttiva al volume e sono suddivisi dai curatori in otto ambiti tematici. I ‘Paralipomena’”sono materiali privi di valore autonomo e preparatori ai testi conclusi”. Là dove era possibile i curatori hanno cercato di stabilire una datazione, seguendo il criterio cronologico a cui si ispira l’edizione italiana delle Opere.
Edizione che fu avviata, lo ricordiamo, nel 1982 da Giorgio Agamben e che ebbe il merito di portare in primo piano gli aspetti genetici dell’opera benjaminiana assai più illuminanti delle partizioni tematiche seguite prevalentemente nell’edizione originale tedesca. Nel caso dell’opera benjaminiana più che in altri il desiderio di sistemazione dei posteri non rende giustizia all’obbiettiva complessità della tessitura testuale.
Il criterio cronologico adottato da Agamben ha consentito quindi di seguire le trasformazioni del suo pensiero e di individuarne le direttrici fondamentali nell’ottica delle influenze, degli incontri intellettuali, delle amicizie e della geografia dei suoi spostamenti europei.
Non si è trattato di una semplice scelta filologica, ammesso che le scelte della filologia possano dirsi ‘semplici’, ossia indifferenti alla costruzione dei significati. Si è trattato di aderire a uno stile di lavoro dell’autore, di seguirne il percorso e la progressione, di ricercare le coerenze sistematiche non nell’organizzazione esteriore degli argomenti ma nelle connessioni profonde del suo pensiero.
Dopo l’uscita dei primi cinque volumi,- l’ultimo dei quali apparve nel 1993- l’edizione Agamben si interruppe per incomprensioni con l’editore. Fu proseguita anni dopo dai curatori dell’edizione tedesca affiancati da Enrico Ganni. Il criterio cronologico voluto da Agamben fu mantenuto e a oggi sono usciti nove volumi.
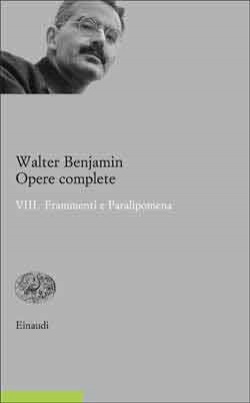
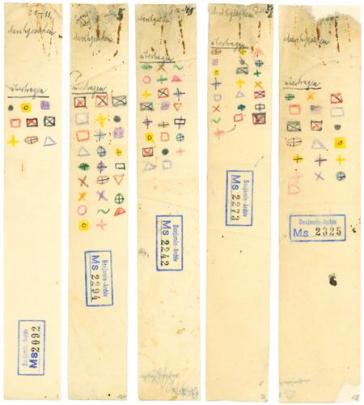
L’appunto citato poc’anzi in cui il cinema di Chaplin fornisce, secondo Benjamin, la chiave per penetrare nell’universo di Kafka, è un esempio di come l’immagine si fissi in figura, vale a dire in Denkbild, in figura di pensiero. Se la storia viene spogliata di ciò che sembra essere la sua caratteristica fondamentale, il movimento e la trasformazione, essa consegna all’osservatore una serie di istantanee in cui il passato e il presente, la mobilità perenne del tempo si ferma in una paradossale fissità: è quella che in un passo del Passagenwerk Benjamin ha chiamato la “dialettica dell’immobilità”: “Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone: ogni ora è l’ora di una determinata conoscibilità. In quest’ora, la verità è carica di tempo fino a frantumarsi…Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione. In altre parole: immagine è la dialettica nell’immobilità.” (GS, V,I, pp. 577-578, cit. in W. Benjamin, Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato, Neri Pozza, Milano 2012, p. 14).
Questa idea per cui l’immagine sovverte gli schemi consueti della temporalità si manifesta nei frammenti dedicati alla critica letteraria, probabilmente fra le pagine più rivelatrici del metodo di Benjamin. Qui è in discussione la figura del critico, la sua relazione con il testo, la storicità del suo sguardo e di quello dell’opera a cui si rivolge. Gli schemi della storiografia sociologica e in particolare di quella marxista si scontrano con l’esigenza di autonomia dell’opera stessa. Che non è distanza dal mondo o essenza ineffabile ma la necessità intrinseca di negarsi ad un giudizio che ha di mira il solo contenuto oggettivo dell’opera, vale a dire “ solo quanto vi viene espresso”. Il vero critico è colui che sa “guardare dentro l’opera”, che ne osserva la stratigrafia e sa cogliere sotto la superfice mobile degli oggetti e degli eventi rappresentati ciò che si sottrae al tempo e alla contingenza, ossia il contenuto di verità.
In un lungo frammento dedicato alla “Falsa critica”, risalente al 1930-31 Benjamin stigmatizza la miopia di chi non vede i rapporti che si celano nella costruzione testuale: “Imparare a guardare dentro l’opera significa avere maggiore contezza di come contenuto oggettivo e contenuto di verità si intreccino all’interno dell’opera stessa” (…) “E questa, purtroppo, è la situazione in cui viene a trovarsi quasi tutto ciò che da noi è noto come critica marxista. Si arriva quasi sempre a un fitto tracciato di linee all’interno delle opere, là dove a tratti viene alla luce il contenuto, se non addirittura la tendenza sociale. Tutto questo, però, non conduce dentro l’opera, ma porta unicamente a delle semplici affermazioni sull’opera stessa”.
Lo sguardo rivolto verso ciò che nell’opera è celato, ossia verso il suo nucleo di verità rende necessaria un’ “estetica deduttiva”, ossia una definizione trascendente in cui si fissa un significato dell’esperienza artistica che è insieme originario ed escatologico.
Ma proprio in quanto veicolo di un contenuto di verità l’opera perde paradossalmente il suo connotato estetico, l’arte come artificio funzionale alla mediazione di un contenuto scompare per fare posto a una relazione diretta tra il singolo fenomeno artistico e un’ idea in senso platonico. “L’arte- scrive Benjamin in un altro frammento dello stesso periodo- è solo un momento di passaggio delle grandi opere. Sono divenute qualcos’altro (nella fase del loro divenire) e diventeranno qualcos’altro (nella fase della critica)” .
Critica, opera e divenire sono categorie protoromantiche: il Benjamin di questi anni, che progettava un saggio sulla critica letteraria, attinge al lessico di Friedrich Schlegel e alla sua idea di una critica infinita e immanente all’opera. Non dunque la critica nel senso abituale di giudizio estetico ma come ciò che rende cosciente l’opera a se stessa e ne potenzia il significato, vale a dire ne stimola la relazione tra il contingente (il suo contenuto materiale, la sua relazione col tempo storico) e l’infinito, l’ideale, ciò che trascende il tempo della storia. La definizione che ne dà è “critica magica”
Altrettanto centrale è l’idea di sopravvivenza dell’opera, che Benjamin inizia a formulare negli appunti degli stessi anni, e che troveranno un momento di aggregazione più stabile nel saggio su “Storia della letteratura e scienza della letteratura del 1931”. “La teoria della sopravvivenza delle opere è mossa dal pensiero dominante che questa sopravvivenza smascheri come pura illusione l’idea dell’«arte» intesa come disciplina a se stante”.
L’arte non è uno spazio di costruzione estetica autonomo rispetto alla storia ma il luogo in cui “le macerie generate dal tempo” offrono al critico i materiali su cui esercitare la sua opera di smontaggio e ricomposizione.
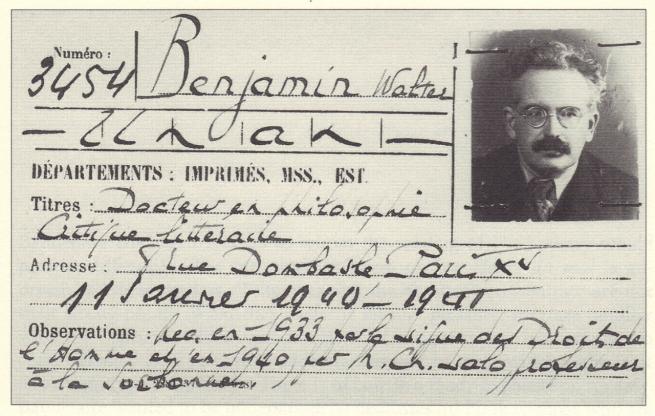
Hanna Arendt chiamò Benjamin un “pescatore di perle”; ebbene fra le molte perle di questo volume spicca la riflessione sul kitsch e sulla sua relazione con l’arte popolare che Benjamin consegna ad un lungo frammento risalente verosimilmente al 1929. “Arte popolare e kitsch devono essere considerati una volta per tutte come un unico grande movimento che fa passare di mano in mano determinati contenuti come se fossero staffette alle spalle di ciò che viene chiamata la grande arte.”
In questi territori della sensibilità e dell’immaginario collettivi, che la concezione dell’arte esclude ancora oggi dal suo ambito, si realizzano evocazioni e appartenenze ancestrali.
“Tutta l’arte popolare attira e chiama a sé l’uomo: gli si rivolge in modo tale da costringerlo a rispondere. O meglio, a rispondere con domande del tipo: «Dove? E quando è stato?» In lui affiora l’idea che quel preciso spazio e luogo e che quel dato momento, quella posizione solare debbano già essere esistiti una volta nella sua vita. La situazione che viene così riattualizzata, di sentirsi come avvolti in un vecchio cappotto- è la più potente attrattiva che evoca il ritornello della canzonetta in cui è possibile cogliere, come riflesso nell’opera, un tratto fondamentale di tutta l’arte popolare”.
Arte popolare e kitsch agiscono sugli strati profondi e inconsci del nostro io, là dove emerge il primitivo, la fantasia che riveste il reale di un’aura onirica “…che illuminando in un baleno l’oscurità dell’io e del carattere e facendo spazio all’interpolazione dei tratti più sorprendenti, più oscuri e più chiari, agisce anche contro il nostro destino (…) ci ritroviamo ad essere dominati dalla convinzione di avere vissuto infinitamente di più di quanto ci sia dato sapere”.
L’effetto di tali forme artistiche minori è una scissione tra la parte razionale del nostro io, che si fonda sull’oggettivazione del mondo e sulla relazione soggetto- oggetto, e il senso di originaria appartenenza a un tutto in cui un’altra parte di noi tende a rifluire.
“Ciò che si è vissuto in modo inconsapevole ha un suono particolare con il quale ci addentriamo nel mondo dei primitivi, nei loro arredi, nei loro ornamenti, nei loro canti, nelle loro immagini. Un suono particolare- ovvero un suono che ci tocca in modo completamente diverso rispetto alla grande arte. Davanti a un dipinto di Tiziano o di Monet non sentiamo mai la tentazione di caricare l’orologio e di definire l’ora in base alla posizione del sole riflessa nel quadro che ci sta davanti. Ma con le illustrazioni riportate nei libri per bambini, con le pitture di Utrillo che, in questo senso, comunque, riprendono perfettamente il primitivo, tutto questo può capitarci facilmente”.
In questo territorio di confine tra il sonno e la veglia, in cui la fantasia non si interroga su se stessa ma si abbandona all’attrazione dell’originario, a dominare è uno stato di reminiscenza, che non è l’anamnesi platonica ma piuttosto un sentimento di déjà vu, che “si trasforma così in una forza dal potere magico al cui servizio si pone l’arte popolare (e il kitsch nondimeno)”.

Memorial di Walter Benjamin a Portbou
Le reminiscenze fuori controllo che ci vengono incontro da un remoto passato Benjamin le chiama “maschere del destino”. E sono loro, come le maschere dei primitivi, a prendere il sopravvento sui nostri fragili progetti di senso.
Grande arte e kitsch, Arte con la a maiuscola e arte popolare rappresentano dunque una contrapposizione che supera il perimetro estetico. Non è una questione di bello o brutto, di stile o di gusto. Qui si evidenzia una polarità tra la moderna idea di soggetto, quello cartesiano, e poi illuministico e kantiano, quello che pretende di controllare razionalmente il mondo, e assegna all’arte la funzione di idealizzare l’umano nella compostezza formale dello stile, e una dimensione dell’io governata dalle potenze mitiche, dai disegni del destino, dall’inconscio collettivo.
Questo percorso argomentativo, che conserva intatta la sua presa analitica anche se applicato alle molte espressioni della cultura pop dei nostri anni, si conclude con un implicito riferimento all’idea stessa della critica: mentre “l’arte ci insegna a vedere dentro alle cose, l’arte popolare e il kitsch ci permettono di vedere a partire da dentro alle cose”.
Come aveva dimostrato nella sua evidenza icastica la mostra Walter Benjamin Archives allestita nel 2011 al Musée d’art et d’histoire du Judaïsme di Parigi la misura più consona al saggismo benjaminiano è la forma minima, l’elenco, la citazione, l’appunto, la stessa materialità della grafia minuscola, quasi una sfida alla decrittazione, il montaggio dell’eterogeneo, la ricerca delle sinestesie concettuali.
Il volume VIII delle Opere offre al lettore una visione ravvicinata e particolarmente significativa del laboratorio filosofico del pensatore berlinese, se ne vedono gli attrezzi, si capisce da dove provengano i materiali, le mappe e le carte da cui hanno preso inizio i diversi progetti di costruzione. Una specie di immenso cantiere in cui è facile immaginarlo mentre si aggira come il mago descritto da Adorno con cappello a punta e bacchetta magica.
Una versione più breve è apparsa su Alias Domenica de il manifesto
↧
↧
L' ALLEGRIA DI PASOLINI E IL SUO RAPPORTO COL MONDO CLASSICO
Pier Paolo Pasolini, Decameron
Pasolini senza apocalisse. Intervista a Massimo Fusillo
a cura di Giuseppe Girimonti Greco e Paolo Lago
Il tuo saggio La Grecia secondo Pasolini, uscito nel 1996, ormai quasi vent’anni fa (anche se una nuova edizione ampliata è del 2007), è pionieristico e innovativo nel senso che è il primo che analizza in modo sistematico l’importanza del mondo antico e delle letterature classiche – soprattutto la tragedia greca – nell’opera di Pasolini. Nell’introduzione scrivi che il mito antico e la tragedia greca rappresentano per Pasolini delle vere e proprie “ossessioni”. Vorresti brevemente parlarci di queste “ossessioni”?
Ossessione è una parola che ricorre spesso nella poesia di Pasolini, sempre con una connotazione fondamentalmente positiva e spesso autobiografica (e certo anche la sua sessualità aveva caratteri ossessivi); ed è anche la parola con cui traduce in Eschilo la furia delle Erinni o la follia di Oreste. Nella sua opera così multiforme ci sono sicuramente delle costanti che la unificano, e che possono considerarsi ossessioni: il Friuli, la passione di Cristo, il mito, il rito, il sacro; e tutte possono essere sussunte nel suo unico, ossessivo oggetto d’amore: la civiltà contadina, illimitata e transnazionale, di cui i ragazzi sottoproletari sono l’incarnazione più seduttiva
Sempre nell’introduzione a quel volume, metti l’accento sulla poliedricità espressiva e sull’eclettismo di Pasolini, un autore che, passando da un linguaggio all’altro (poesia, romanzo, cinema) fa ampiamente ricorso alla contaminazione, al pastiche, alla citazione, all’ibridazione stilistica fra alto e basso. Anche nell’approccio al mondo antico PPP si rivela un autore così disinvoltamente incline alla contaminazione intermediale, stilistica, linguistica, discorsiva?
Credo che la creatività intermediale sia oggi il tratto più significativo dell’opera di Pasolini. Quanto alla contaminazione stilistica, è un concetto che ritorna molto spesso nelle sue dichiarazioni teoriche, meno direi nella sua produzione. Certo, il lavoro sul dialetto, la sacralizzazione delle borgate tramite Bach in Accattone, o la sperimentazione estrema di Petrolio vanno in questa direzione. Nelle opere ispirate al mondo greco prevale il registro tragico: si può riscontrare qualche tocco di contaminazione nelle parti dedicate agli antefatti delle tragedie oggetto dei suoi film, in particolare di Edipo re. Le novità maggiori vengono comunque anche in questo caso da Petrolio, che attraverso il modello del Satyricon mira a una polifonia stilistica che contamina riso grottesco e saggismo giornalistico.
Come già accennato, il tuo saggio è del 1996; da allora non hai mai smesso di occuparti della figura e dell’opera di Pasolini, anche non in stretta correlazione col mondo classico. PPP, al giorno d’oggi, riscuote una fortuna enorme, non solo in Italia. Escono continuamente nuovi libri che ne analizzano l’opera e la vita. Focalizzandoci sulla peculiarità italiana, come è recepita, secondo te, la sua figura oggi, e che differenze noti rispetto alla sua ricezione in altri paesi?
In realtà dopo il saggio mi sono concentrato su Petrolio, ma da un po’ di tempo non mi occupo più di Pasolini, se non per partecipare a incontri pubblici e come membro della giuria del Premio per le tesi di laurea: me ne sono distanziato da vari punti di vista, come succede spesso con i propri oggetti di studio. Mi sembra che la ricezione italiana si concentri troppo sulle sue posizioni politiche e sulla sua biografia, mentre all’estero si studia di più la sua opera (soprattutto il cinema) e le sue strategie espressive, e soprattutto si cerca di mettere in dialogo Pasolini con alcuni nodi della cultura contemporanea.
In un volume che riunisce diversi interventi, L’eredità di Pier Paolo Pasolini, uscito qualche anno fa, a cura di Alessandro Guidi e Pierluigi Sassetti, Pasolini viene definito dallo stesso Sassetti – che utilizza un’espressione di Slavoj Žižek – “l’ovetto kinder della cultura italiana”, in quanto, a differenza di altre illustri icone, offre qualcosa in più, qualcosa di più accattivante. Infatti, nel calderone culturale, un po’ tutti, da destra a sinistra, tendono ad appropriarsi delle sue idee trasformando in bandiera il suo nome e in manifesto i suoi enunciati più noti. Cosa pensi di questo ‘uso’ della figura e delle idee di PPP?
Come sostiene Gianluigi Simonetti, Pasolini oggi è diventato anche un logo: un mezzo sicuro per ottenere successo e consenso. Ovviamente gli artisti sono spesso destinati ad essere usati in forme lontane, o anche opposte, da quelle che avevano pensato o teorizzato: è inevitabile, e di per sé non c’è niente di male. Ma certo alle volte è irritante trovare citato Pasolini a sproposito, solo per dare un’aura nobile a posizioni banali e a stereotipi, rovesciando proprio quella che è stata la sua funzione più vitale nella società italiana: creare conflitti, discussioni, spiazzare le attese, sovvertire le contrapposizioni facili, insomma «lo scandalo del contraddirmi».
Pasolini è stato spesso definito come un intellettuale profetico, un intellettuale apocalittico, “antimoderno”; di recente un bel libro di Pierpaolo Antonello, Dimenticare Pasolini, che hai recensito su Between, analizzando il problema della “santificazione” di Pasolini che è tutt’ora in corso, affronta il tema dell’ubi sunt e del diffuso lamento apocalittico sulla degenerazione della propria epoca da parte degli intellettuali. Qualcosa di simile fa un ancor più recente intervento di Gilda Policastro su doppiozero, intitolato Pasolini ti odio. Cosa ne pensi? Come, secondo te, Pasolini potrebbe essere ‘reinterpretato’ oggi?
Il pensiero politico di Pasolini mi sembra la parte più debole della sua opera, proprio perché presenta tutti gli eccessi di un certo atteggiamento apocalittico così diffuso ancor oggi nella cultura di sinistra. Un atteggiamento che si ripete ormai da troppo tempo, e che ha il suo archetipo millenario in Esiodo: mitizzare il passato e demonizzare il presente, quando il compito di un intellettuale dovrebbe essere cercare di capire il proprio tempo. Certo, Pasolini non era un primitivista: mirava al contrario a una sintesi fra antico e moderno, ed ha sicuramento analizzato con lucidità e compreso in anticipo alcuni problemi della società contemporanea (ecologia, periferie, degrado urbano). Ma quando Pasolini usa una parola così forte e così connotata come genocidio (una delle sue formule più citate) è sicuramente eccessivo: in effetti sappiamo bene che non c’è stato nessun genocidio culturale in Italia. Le culture locali non sono state distrutte, si sono trasformate e ibridate con la cultura dominante, creando fenomeni anche interessanti, come il glocal. Parlando di Sandro Penna negli Scritti corsari a un certo punto Pasolini si fa scappare che era meraviglioso un tempo credere che la forma della vita non sarebbe mai cambiata: e invece per fortuna cambia e continuerà a cambiare. Il libro di Antonello e l’intervento di Policastro mi hanno convinto: credo che Antonello abbia ragione, bisogna certo continuare a studiare e a fruire dell’opera multiforme di Pasolini, ma bisogna abbandonare il modello di intellettuale veggente da lui incarnato; un modello sempre più forte invece grazie alla santificazione tributatagli dalla stessa Italia che lo ha perseguitato in vita.
Le stesse oscure modalità dell’assassinio di Pasolini ne rendono la figura più misteriosa e ‘affascinante’, in un certo senso; riguardo a questo il mondo degli intellettuali si è un po’ diviso in due parti: ‘complottisti’ e non, nel senso che c’è chi pensa che Pasolini sia stato ucciso da poteri più o meno occulti e chi, invece, ritiene che le cose siano andate come racconta la ‘versione ufficiale’. Tu da che parte stai?
L’assassinio di Pasolini sembra destinato a restare uno dei misteri irrisolti della storia italiana, ed è difficile avere certezze a riguardo. L’unica tesi che mi sento di scartare è quella del suicidio sceneggiato e organizzato da tempo: quella di Zigaina. La tesi del complotto non mi ha mai molto convinto, benché fosse sostenuta con una passione alle volte contagiosa da Laura Betti, con cui ho collaborato e di cui sono stato amico. Mi è sempre sembrato un modo per nobilitare ed eroicizzare una morte per violenza omofoba come ne succedono tante, una morte che rientrava nei rischi che la vita sessuale di Pasolini comportava (e certo la coerenza con la sua opera spiega il fascino a cui accennavate). Sono d’accordo con quanto sostiene Emanuele Trevi in Qualcosa di scritto: sul delitto Mattei e su altre questioni scottanti Pasolini si rifaceva alle inchieste dell’Espresso, non aveva scoperto nessuna nuova verità che possa spiegare la sua morte; anche se poi non sono d’accordo su tutta l’interpretazione di Petrolio contenuta nel romanzo di Trevi, di cui mi sono trovato senza saperlo prima ad essere un personaggio (comunque un bel personaggio, devo dire). Credo che ormai si possa dare per certo che Pelosi non fosse solo, e devo ammettere che molte delle acquisizioni recenti vanno nella direzione del delitto politico, per cui, ripeto, non si possono avere certezze.
Hai visto Pasolini di Abel Ferrara?
Ovviamente sì. Mi sono piaciute le parti dedicate alla vita quotidiana di Pasolini: ad esempio le scene con la madre e con Laura Betti. William Dafoe è molto credibile e somigliante, anche se un po’ troppo anziano. Quello che non mi ha convinto è l’esperimento di ricostruire Petrolio e Porno-Teo-Kolossal: suona artificioso e direi totalmente fallito.
Un tuo pensiero per Pasolini, da dedicargli, oggi, a quarant’anni dal suo tragico omicidio?
Pasolini ha scritto frasi belle sull’allegria e sull’umorismo della vecchiaia, ormai sganciata dal tarlo del futuro. Le ha scritte cinquantenne, a un’età che oggi si considera ancora un po’ lontana dalla vecchiaia. Mi piace immaginarlo allegro 93enne, che si diverte a sfruttare le potenzialità di Internet… Renzo Paris conclude il suo Pasolini ragazzo a vita– una sorta di romanzo memoriale scritto per il quarantennale – con un sogno ispirato a Rimbaud, in cui rincontra Pasolini fra i pastori Masai in Kenya; all’Idroscalo sarebbe morta una controfigura, come il Cacarella di Affabulazione, mentre il vero Pasolini avrebbe trascorso metà della sua vita in giro per l’Africa, senza più il desiderio di scrivere o filmare, libero dalla sua opprimente figura pubblica.

↧
STORIA DEL "SALUTO ROMANO"
Pledge of Allegiance
Dopo il Kilt scozzese (inventato nel Settecento da un mercante di stoffe inglese), ora è la volta del saluto romano che sembra sia stato inventato negli USA nel 1892. Crolla un altro mito identitario. Forse è il caso di farlo sapere ad Alemanno.
Livia Capponi
Il gesto a noi noto come «saluto romano»
Il gesto a noi noto come «saluto romano», con il braccio destro teso alzato a circa 135 gradi dal corpo, e con le dita della mano unite, adottato dal regime fascista e poi dal nazismo, si presentava esplicitamente come un revival dell’eredità di Roma. Ma esisteva davvero quel gesto specifico di saluto nel mondo antico? La più comune forma di saluto nella Grecia classica era una semplice stretta di mano. A Roma i legionari battevano il palmo o il pugno sul petto, come è stato efficacemente rievocato dal cinema. I gladiatori si afferravano l’avambraccio destro al di sopra del polso. Sorprendentemente, esisteva anche un saluto militare simile a quello odierno, che a torto si credeva un’invenzione medievale.
I soldati romani, i barbari e gli imperatori raffigurati a Roma, sugli archi di Tito e di Costantino e sui fregi di argomento storico delle colonne di Traiano e di Marco Aurelio, si sbracciano in svariati gesti, il cui preciso significato non è sempre chiaro. In molti casi, sia i soldati che l’imperatore salutano alzando la mano aperta, come faremmo noi. Altre volte, l’imperatore alza leggermente anche il braccio, ma, come notano Andrea Giardina e André Vauchez nel libro Il mito di Roma (Laterza, 2008), è un gesto che spesso accompagna un augurio o un discorso rivolto ai legionari, con il palmo della mano verticale e le dita aperte.
Il grande fregio storico che avvolge a spirale, come la pellicola di un film, la colonna Traiana, innalzata per celebrare la conquista della Dacia da parte di Traiano fra il 101 e il 106 d.C., e studiato da Filippo Coarelli in La colonna Traiana (Colombo, 1999), mostra diverse scene di incontro fra l’imperatore, i soldati e i barbari. Nel fregio 65, l’imperatore a cavallo è salutato da alcuni barbari con le braccia stese o piegate in segno di sottomissione. Nel fregio 103, Traiano riceve una delegazione nemica: un Dace leva il braccio verso l’imperatore in segno di supplica. Nel fregio 75, Traiano arriva a un forte romano in Dacia, e viene salutato da un gruppo di legionari e ufficiali romani; il saluto non è sempre uguale ma con il braccio più o meno piegato, mai teso.
Nella monetazione e nella scultura romana ci sono molte scene di arringa, acclamazione, arrivo e partenza, dove il braccio alzato può esprimere benedizione, saluto o potere, e il più delle volte non è ricambiato. Un famoso esempio è l’Augusto di Prima Porta, raffigurato come un generale vittorioso che si rivolge alla folla, il braccio leggermente piegato in un movimento nobile e controllato, il corpo per niente sull’attenti ma, al contrario, bilanciato da una torsione contrapposta delle gambe divaricate e flesse, secondo i canoni derivati dalla Grecia classica.
La celebre statua bronzea nota come l’ Arringatore , dedicata al notabile etrusco Aulo Metello alla fine del II secolo a.C. e oggi a Firenze, presenta lo stesso gesto del braccio appena piegato con la mano alzata, nell’atto di chi chiede solennemente l’attenzione del pubblico prima di cominciare a parlare.
Secondo il libro di Martin M. Winkler The Roman Salute. Cinema, History, Ideology (Ohio state university press, 2009), l’archeologia, come pure tutta la letteratura latina, non ci mostra una sola immagine chiara del gesto specifico adottato dal fascismo. Winkler sostiene che il saluto romano fu associato all’antica Roma retrospettivamente e in tempi moderni. Un passaggio cruciale fu il dipinto di Jacques-Louis David Il giuramento degli Orazi , realizzato nel 1784 e oggi al Louvre.
Manifesto del Neoclassicismo, l’opera trae spunto da una leggenda romana, di cui parla Tito Livio, secondo cui, durante il regno di Tullo Ostilio (672-640 a.C.) per decidere l’esito della guerra tra Roma e Alba Longa, tre fratelli romani, gli Orazi, sfidarono a duello tre fratelli di Alba, i Curiazi. Dei Curiazi non sopravvisse nessuno, mentre uno degli Orazi riuscì a ritornare, decretando la vittoria dei Romani. La scena rappresenta il padre degli Orazi nell’atto di dare loro le spade, che innalza in un gesto di augurio.
Il gesto dei tre fratelli non è un saluto ma un giuramento di fedeltà a Roma, fatto in due casi con il braccio sinistro. L’atteggiamento dei corpi e i colori delle vesti simboleggiano i valori di libertà, uguaglianza e fraternità della Francia rivoluzionaria. Tuttavia, il dipinto può essere considerato un punto di svolta nel graduale processo che vide la reinvenzione del gesto, progressivamente percepito come un saluto più che un giuramento.
Un altro probabile precedente fu il saluto a braccio alzato alla bandiera, o Pledge of Allegiance , creato da Francis Bellamy nel 1892 e adottato nelle scuole degli Stati Uniti fino agli anni Trenta, e poi copiato dal fascismo. La controversa associazione, come ha messo in luce il ricercatore statunitense Rex Curry, ha poi fatto sì che il gesto fosse sostituito dalla mano sul cuore, per volere di Franklin Delano Roosevelt.
Ma a riportare davvero in vita i Romani per un pubblico di massa fu il cinema del primo Novecento, che reinventò i gesti, oltre che i costumi, degli antichi, prendendo spunto dal repertorio di convenzioni fissato dal teatro preesistente. Il film Cabiria di Giovanni Pastrone (1914), il più grande kolossal del cinema muto italiano, che vantava Gabriele d’Annunzio come sceneggiatore e autore delle didascalie, consacra il gesto come simbolo della romanità: difatti in chiave politica viene usato per la prima volta dai legionari fiumani dello stesso d’Annunzio nel 1919. In Scipione l’Africano di Carmine Gallone (1937) il saluto ricorre ossessivamente a richiamare l’associazione romanità-fascismo.
Il successivo cinema del dopoguerra ha ormai interiorizzato questa visione di Roma, e la popolarità dei grandi kolossal hollywoodiani di argomento religioso conferisce ulteriore credibilità ai dettagli in essi contenuti. Ben-Hur di William Wyler (1959) e Quo Vadis di Mervyn LeRoy (1951) fanno esplicito riferimento a Roma come metafora del fascismo, e agli Ebrei e ai Cristiani come simbolo della libertà degli Stati Uniti. Il saluto romano di Peter Ustinov nei panni di Nerone scimmiotta mostruosamente bene i grandi dittatori. Nei film più recenti, fino alla televisione di Star Trek , il saluto romano non è più esplicitamente associato al fascismo o al nazismo ma è comunque usato per evocare regimi autoritari.
L’assenza di prove inconfutabili sull’esistenza del saluto romano nel mondo antico è l’esempio di come una narrazione potente sia in grado di produrre una storia irreale e di farla accettare come una verità storica dal grande pubblico, incapace o disinteressato a cogliere il paradosso. Mistificare un fatto inventato spacciandolo come realmente accaduto, o riempire il passato di contenuti attuali, d’altra parte, è un vecchio trucco narrativo, quello, sì, utilizzato fin dai tempi dei Romani.
Il Corriere della sera – 17 gennaio 2016
↧
SANITA' DI CLASSE IN UN PAESE MARCIO
Un cittadino su sei rinuncia alle terapie. Colpa dei reparti chiusi, dei medici che mancano e dei ticket cresciuti del 20 per cento in pochi anni. Tutto questo per pagare superstipendi a manager (di nomina politica) inefficienti e spreconi, lucrare sugli appalti e le forniture, mantenere con l'avallo sindacale logiche corporative, fornire servizi gratuiti a chi non ne avrebbe diritto (evasori fiscali, falsi invalidi, ecc). Lo specchio insomma di un paese marcio tanto in alto (politici e imprenditori) quanto in basso.
Roberto Petrini
Costi molto alti gli italiani non si curano più
Gli italiani, che secondo un comune clichè sarebbero ipocondriaci e ansiosi, stanno cambiando atteggiamento e hanno cominciato a trascurare la propria salute. Colpa dei costi troppo alti dei ticket, dell’eccessiva distanza dei presidi sanitari e delle liste d’attesa. Esasperati dalla crisi e con sempre meno soldi in tasca rinunciano al dentista. Tra le fasce più povere della popolazione fino al 15 per cento degli italiani si priva delle cure.
A lanciare l’allarme non è un semplice centro di studi sociologici e di monitoraggio delle tendenze degli italiani, ma l’Ufficio parlamentare di bilancio, il ferreo presidio di ricerca che ha il compito di fare da cane da guardia ai conti pubblici sulla scorta delle regole europee. I dati riguardano il 2013, prima dell’esecutivo Renzi, e risentono soprattutto delle politiche di austerità messe in atto da Monti tra il 2011 e il 2012, ma suonano comunque come un monito rispetto ai potenziali effetti dei tagli al Fondo sanitario nazionale praticati con la nuova legge di Stabilità 2016.
Dalle statistiche fornite dall’Upb, e firmate Eurostat, si scopre che il 7,1 per cento degli italiani rinuncia a farsi visitare perché – queste le motivazioni addotte – il costo della prestazione è troppo alto, la lista d’attesa è troppo lunga oppure l’ospedale è troppo distante. Con il diminuire del reddito il disagio cresce: la rinuncia alla cura sale al 14,6 per cento nel caso in cui gli interpellati appartengano al 20 per cento più po-vero della popolazione italiana.
Non è sempre stato così. Prima della Grande crisi del 2007-2009 e della Grande austerità europea del 2011-2012, gli italiani che facevano a meno di curarsi erano in numero assai inferiore: nel 2004, ad esempio, solo il 3,6 per cento rinunciava per eccesso di costi e si arrivava al 5,2 per cento considerando anche gli altri elementi di disagio, come la distanza o la lista d’attesa. A preoccupare è anche il dato delle cure dentistiche: il 18,6 per cento, circa un quinto dei più poveri, ha dovuto scartare l’idea di farsi curare i denti.
Le spiegazioni che gli italiani danno del proprio comportamento sono realistiche? Purtroppo sì, e gli economisti dell’Upb confermano la correlazione tra tagli alla sanità e aumento dei tassi di trascuratezza nei confronti della salute. Già in termini generali la spesa corrente per la sanità non è alta come comunemente si crede: siamo a due terzi di quella tedesca, a tre quarti di quella francese e addirittura il 60 per cento di quella Usa.
Il rigore degli ultimi anni è stato pesante: la spesa sanitaria corrente, che tra il 2003 e il 2006 cresceva in media del 5,8 per cento, tra il 2007 e il 2010 è salita solo del 2,8 e addirittura nel periodo 2011-2014 è cresciuta a tasso “zero” (dati della Ragioneria generale dello Stato).
A fare le spese dei tagli e della caccia alle risorse ci sono proprio le voci che sembrano stare a monte del disagio denunciato dai cittadini. Ad esempio il numero dei posti letto negli ospedali è diminuito dal 4 per mille nel 2005 al 3,4 nel 2012 contro una media europea di 5,3 per mille. La riduzione delle degenze avrebbe dovuto essere compensata dai day hospital, ma – come segnala il rapporto Upb – è sempre di più la gente che si affida al pronto soccorso per superare file e risparmiare.
Contribuisce a limitare l’offerta anche la riduzione del personale: è stata dell’1,8 per cento tra il 2007 e il 2013 e di un ulteriore 0,6 nei primi mesi del 2014. Vale la pena citare le parole dell’Upb che sintetizzano il senso dello studio diffuso nei giorni scorsi: «Emergono alcuni segni di limitazione dell’accesso fisico (razionamento) ed economico (compartecipazioni) e tracce di una tensione nell’organizzazione dei servizi, legata alla limitatezza delle risorse finanziarie e umane, che potrebbero rivelarsi insostenibili se prolungate nel tempo». Linguaggio tecnico, ma inequivocabile.
Gli ampi passaggi dello studio degli uffici del Parlamento italiano, che riguardano i ticket, confermano la situazione di allarme. L’Upb spiega che per molte prestazioni l’aumento delle compartecipazioni ha «reso conveniente optare per il settore privato ». Del resto il rincaro c’è stato ed è evidente: i ticket sono aumentati del 33 per cento tra il 2010 e il 2014. Se si guarda alla sola spesa per ticket farmaceutici l’aumento è stato del 50 per cento, mentre sulla specialista ambulatoriale, a seguito del superticket da 10 euro per ricetta, è salito al 19 per cento nel biennio 2001-2012.
Tagliare ulteriormente e in modo indiscriminato può portare conseguenze disastrose, se non si interviene sull’obiettivo principale: gli sprechi che, come segnala opportunamente l’Ocse, non a caso citata nel rapporto Upb. Basta guardare alla spesa per beni e servizi, prodotti farmaceutici compresi, che è l’unica a continuare a correre. La spending review dovrà servire anche per reindirizzare verso i servizi quello che oggi ingrassa spesso rendita e malcostume.
La Repubblica – 19 gennaio 2016
↧
↧
POESIA D' ADDIO
Foto di Don Hong Oai
Ringrazio l'amica Stefi Rossetti per avermi fatto conoscere questa splendida fotografia insieme ai bellissimi versi che seguono. Con il suo permesso li faccio miei perchè anch' io sento il bisogno di dire addio a tante cose... - fv
1. Poesia d'addio
A est e a ovest delle mura di Luoyang
A lungo saluto il tempo che passa.
Prima se n'è andata la neve che pareva fiori,
Ora vengono i fiori che sembrano neve.
Fan Yun
↧
In memoria di Ettore Scola
Un fotogramma di C'eravamo tanto amati
di Oscar Iarussi
Ettore Scola o del comunismo ironico. L’ossimoro dice la singolarità del regista, fra i maggiori europei del secondo Novecento, tuttavia guardingo dal lasciarsi monumentare tant’è che poco più di due anni fa era a Venezia con un nuovo film, Che strano chiamarsi Federico!, memoir cinematografico e omaggio a Fellini, cui lo affratellò la passione per i disegni e i sogni in celluloide (li divise se mai l’“impegno” o la militanza che il Riminese sempre rifuggì). Originario della Campania irpina, egli era come Fellini un provinciale presto inurbatosi, adesivo a ogni piega manifesta o nascosta della Roma madre matrigna e, suvvia, un po’ mignotta. Ma rimase legatissimo al Sud e in particolare negli ultimi anni era “di casa” a Bari, sul palco del Petruzzelli come nelle aule dove incontrava gli studenti, grazie al Bif&st di cui aveva accettato la presidenza propostagli dal vecchio amico Felice Laudadio.
Scola nasce nello stesso 1931 in cui esordì nelle edicole la rivista umoristica “Marc’Aurelio” e proprio sulle colonne care ad Attalo, Zavattini, Fellini, Marchesi prenderà a sbeffeggiare il piccolo mondo moderno dell’Italia post-bellica in odore di boom. Sono esercizi di stile caustico in vista dell’esordio nella commedia di costume con Se permettete parliamo di donne, scritto con Maccari, amico di una vita al pari di Scarpelli.
E’ il 1964. Da allora, per un quarantennio e oltre, Scola è una presenza sul set e nella vita culturale italiana grazie a un’intelligenza sarcastica che non si compiace del cinismo. Il suo acume balzachiano per la vita è infatti temperato dal senso comunitario, dalla voglia di appartenere a una storia più larga e più umana del gruppetto che imbandisce calembour folgoranti ai tavoli di “Cesaretto” o di “Otello alla Concordia”, dove cenano molti cineasti e intellettuali “de sinistra”. Di quella cerchia Scola resta un campione, eppure si sottrae al sottile conformismo che aleggia fra piazza di Spagna e via delle Botteghe Oscure. Sarà merito – nomen omen? – del battesimo iliaco e del cognome scolastico, ma anche liberatorio dei fluidi impuri.
A Scola è riuscito il prodigio di essere divertente e pugnace, nostalgico e temerario, individualista e popolare, poetico e marxista. Commediare la lotta di classe – mica facile! “Volevamo cambiare il mondo e invece il mondo ha cambiato noi”: eccolo chinarsi su un terzetto di ex partigiani fino a cogliere l’essenza stessa del paese in C’eravamo tanto amati, struggente elegia del trasformismo. E c’è lo Scola militante, documentario, di Trevico-Torino… Viaggio nel Fiat-Nam, dell’addio collettivo a Enrico Berlinguer, di Lettere dalla Palestina.
A lungo sceneggiatore principe di pellicole come Un americano a Roma, Il sorpasso, I mostri, Anni ruggenti, Io la conoscevo bene, Scola deve a tale esperienza di umiltà al servizio altrui una dimensione autorale a tutto campo, ovvero una sorveglianza nella scrittura filmica che ormai è merce rara. Non per caso, i suoi titoli diventano proverbiali, scandiscono intere stagioni dal primo centro-sinistra al crollo del Muro di Berlino, si mutano in locuzioni, fanno storia: Brutti, sporchi e cattivi, Una giornata particolare, La terrazza, Ballando ballando, fino a Romanzo di un giovane povero che nel concorso veneziano del 1995 fruttò la Coppa Volpi alla protagonista Isabella Ferrari. Perciò i francesi, incalliti linguaioli, impazziscono per “Scolà”, mentre il Nostro con La famiglia nell’86 schiude una magistrale finestra sul “secolo breve”, invero infinitamente lungo, per mostrarci che il “dentro” e il “fuori” delle mura domestiche si parlano, si danno del tu, si sfottono e si corteggiano. Amore e storia, passione e visione, comunismo e ironia, Ettore e Scola.
Oscar Iarussi
Questo pezzo è uscito anche su La Gazzetta del Mezzogiorno
Ettore Scola o del comunismo ironico. L’ossimoro dice la singolarità del regista, fra i maggiori europei del secondo Novecento, tuttavia guardingo dal lasciarsi monumentare tant’è che poco più di due anni fa era a Venezia con un nuovo film, Che strano chiamarsi Federico!, memoir cinematografico e omaggio a Fellini, cui lo affratellò la passione per i disegni e i sogni in celluloide (li divise se mai l’“impegno” o la militanza che il Riminese sempre rifuggì). Originario della Campania irpina, egli era come Fellini un provinciale presto inurbatosi, adesivo a ogni piega manifesta o nascosta della Roma madre matrigna e, suvvia, un po’ mignotta. Ma rimase legatissimo al Sud e in particolare negli ultimi anni era “di casa” a Bari, sul palco del Petruzzelli come nelle aule dove incontrava gli studenti, grazie al Bif&st di cui aveva accettato la presidenza propostagli dal vecchio amico Felice Laudadio.
Scola nasce nello stesso 1931 in cui esordì nelle edicole la rivista umoristica “Marc’Aurelio” e proprio sulle colonne care ad Attalo, Zavattini, Fellini, Marchesi prenderà a sbeffeggiare il piccolo mondo moderno dell’Italia post-bellica in odore di boom. Sono esercizi di stile caustico in vista dell’esordio nella commedia di costume con Se permettete parliamo di donne, scritto con Maccari, amico di una vita al pari di Scarpelli.
E’ il 1964. Da allora, per un quarantennio e oltre, Scola è una presenza sul set e nella vita culturale italiana grazie a un’intelligenza sarcastica che non si compiace del cinismo. Il suo acume balzachiano per la vita è infatti temperato dal senso comunitario, dalla voglia di appartenere a una storia più larga e più umana del gruppetto che imbandisce calembour folgoranti ai tavoli di “Cesaretto” o di “Otello alla Concordia”, dove cenano molti cineasti e intellettuali “de sinistra”. Di quella cerchia Scola resta un campione, eppure si sottrae al sottile conformismo che aleggia fra piazza di Spagna e via delle Botteghe Oscure. Sarà merito – nomen omen? – del battesimo iliaco e del cognome scolastico, ma anche liberatorio dei fluidi impuri.
A Scola è riuscito il prodigio di essere divertente e pugnace, nostalgico e temerario, individualista e popolare, poetico e marxista. Commediare la lotta di classe – mica facile! “Volevamo cambiare il mondo e invece il mondo ha cambiato noi”: eccolo chinarsi su un terzetto di ex partigiani fino a cogliere l’essenza stessa del paese in C’eravamo tanto amati, struggente elegia del trasformismo. E c’è lo Scola militante, documentario, di Trevico-Torino… Viaggio nel Fiat-Nam, dell’addio collettivo a Enrico Berlinguer, di Lettere dalla Palestina.
A lungo sceneggiatore principe di pellicole come Un americano a Roma, Il sorpasso, I mostri, Anni ruggenti, Io la conoscevo bene, Scola deve a tale esperienza di umiltà al servizio altrui una dimensione autorale a tutto campo, ovvero una sorveglianza nella scrittura filmica che ormai è merce rara. Non per caso, i suoi titoli diventano proverbiali, scandiscono intere stagioni dal primo centro-sinistra al crollo del Muro di Berlino, si mutano in locuzioni, fanno storia: Brutti, sporchi e cattivi, Una giornata particolare, La terrazza, Ballando ballando, fino a Romanzo di un giovane povero che nel concorso veneziano del 1995 fruttò la Coppa Volpi alla protagonista Isabella Ferrari. Perciò i francesi, incalliti linguaioli, impazziscono per “Scolà”, mentre il Nostro con La famiglia nell’86 schiude una magistrale finestra sul “secolo breve”, invero infinitamente lungo, per mostrarci che il “dentro” e il “fuori” delle mura domestiche si parlano, si danno del tu, si sfottono e si corteggiano. Amore e storia, passione e visione, comunismo e ironia, Ettore e Scola.
Oscar Iarussi
↧
GESU' - SIDDHARTA
La scoperta dell’immagine del Gesù-Siddharta venerato per secoli da una comunità manichea nel sud della Cina apre nuovi studi e riflessioni sul rapporto tra filosofia orientale e occidentale.
Silvia Ronchey
Quando i buddisti eravamo noi
La figura solitaria dal viso assorto, i capelli neri raccolti sulla nuca, siede su un alto trono esagonale. La testa è circondata da un’aureola di luce inscritta nel contorno di una più ampia mandorla che si intravede sullo sfondo brunito del lungo rotolo di seta dipinta. Uno sfolgorio di rosso e oro accomuna i petali dell’immenso fiore di loto dischiuso sotto le sue gambe incrociate e il simbolo della croce che regge tra le dita sottili della mano sinistra, all’altezza del cuore, mentre le dita della destra compongono un esoterico gesto.
È il Buddha, ed è insieme il Cristo, e in entrambe le vesti è stato venerato per secoli dagli adepti della comunità manichea del sud della Cina per cui la sua immagine, conservata dall’inizio del Seicento nel tempio zen di Seiun-ji in Giappone, fu prodotta fra il XII e il XIII secolo.
«O vasto e gentile Gesù Buddha, ascolta le mie parole di dolore. Modesto e sempre desto Re della Mente, Anticipatore del Pensiero, guidami fuori da questo mare avvelenato, verso l’acqua fragrante dell’Emancipazione», si legge nel Rotolo innologico manicheo della British Library, la più antica attestazione liturgica del culto di Gesù in quanto Buddha tra i seguaci di Mani della Cina medievale.
Quest’immagine e queste parole provengono dalle pagine di un articolo pubblicato su una rivista scientifica svizzera da una studiosa ugroamericana di arte religiosa dell’Asia Centrale, Zsuzsanna Gulacsi, grande esperta di manicheismo. La sua argomentazione e la sua tesi finale – nella raffigurazione del “profeta” Gesù Buddha è in realtà esplicitata la dottrina della religione dualistica e connaturatamente sincretistica di Mani, cui vanno attribuiti sia il simbolo della Croce di Luce, materializzato nella statuetta, sia il principio della separazione tra luce e tenebra, simboleggiato dal gesto della mano destra – danno nuovo senso a dati già acquisiti ma non ancora elaborati dagli eruditi.
Al di là dello specialismo, l’emergere dal passato orientale del Gesù-Buddha- Mani di Seiun-ji, i suoi epiteti, la forza delle invocazioni parlano in modo immediato al presente occidentale, dove sempre di più il buddismo si radica nella prassi di una crescente élite di figli dell’esistenzialismo, nell’utopia di una non-religione dall’etica resistente alla secolarizzazione ma compatibile con gli approdi della filosofia e con le conquiste della psicologia.
A metà del Novecento il Siddharta di Hesse aveva spontaneamente orientato il suo revival nella cultura pop. Anticipata da pionieri del modernismo cattolico come Thomas Merton, l’accoglienza del buddismo in occidente aveva prodotto un’ibridazione confessionale in cui lo yoga e le tecniche ancestrali di meditazione proprie dell’esicasmo cristiano e del sufismo islamico, come già prima delle scuole platoniche e pitagoriche, erano sostanzialmente tollerate se non promosse dai residui esponenti delle religioni ufficiali.
«Perché non possiamo non dirci cristiani», si domandava Benedetto Croce all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, riflettendo sulle radici comuni dell’Europa. Con altrettanta onestà dovremmo oggi riflettere sul perché non possiamo non dirci buddisti. Più di una filosofia, meno di una religione, mai una dogmatica, il buddismo è oggi la dottrina più condivisa del mondo contemporaneo. Ne è pervasa, ben più che dal cristianesimo, la filosofia moderna. In genere si fa risalire il suo influsso nel pensiero, nella cultura e nel modo di sentire occidentali allo slancio degli studi di orientalistica che influenzarono il giovane Schopenhauer.
Ma quella conoscenza era già ben diffusa tra gli illuministi, per il tramite privilegiato delle missioni in Cina e in Giappone, ma anche in Tibet e Sri Lanka, degli avventurosi gesuiti che tra Cinque e Settecento avevano trasmesso accurati resoconti, in particolare, sul buddismo tibetano.
Di recente una studiosa americana, Alison Gopnik, ha cercato di dimostrare l’influenza diretta delle Notizie istoriche del Tibet del padre Desideri sulla composizione del Trattato sulla natura umana di Hume, avvenuta a stretto contatto con l’ambiente gesuita del Collège de La Flèche, nel nord della Francia. Ma già il Seicento spagnolo era impregnato di buddismo. Il suo riflesso più occidentale è ne La vida es sueño di Calderón de la Barca, attraverso cui la trama della vita del Tathagata si trasmetterà alla letteratura otto e novecentesca.
Ancora molto prima il buddismo era penetrato in occidente, ne aveva permeato la psiche collettiva, si era innestato nel suo Dna culturale, predisponendo subliminalmente il terreno alla definitiva svolta che non possiamo non considerare oggi compiuta. La Controriforma aveva dovuto prendere atto che a Bisanzio fin dall’XI secolo il Buddha era venerato dalla chiesa e nonostante lo scetticismo di Bellarmino nel 1583 il cardinal Baronio lo aveva incluso nel Martirologio Romano come santo «apud Indos Persis finitimos.
Il buddismo non aveva mai avuto una Scrittura. Ma la forza plasmatrice di Bisanzio, civiltà del libro, aveva trasformato la vita del Buddha in libro: la cosiddetta Storia di Barlaam e Ioasaf, composta nell’età di sincretismo e cosmopolitismo immediatamente successiva all’espansione militare e culturale araba e al cosiddetto iconoclasmo. È a partire da questo decalcarsi dell’impronta buddista nello stampo greco per il tramite dell’islam che quel Siddharta ante litteram si riprodurrà in progressione geometrica nella letteratura globale e Buddha estenderà la sua predicazione nell’occidente ancora del tutto cristiano.
Detti e fatti dell’interpretazione cristiana del principe Siddharta risuoneranno in ogni lingua europea con una diffusione non raggiunta da nessun’altra leggenda agiografica. Sedurrà l’Italia più mistica, si trasfonderà nel Trecento senese di Caterina, attraverso il Novellino si trasmetterà al Decameron di Boccaccio e di qui al teatro di Shakespeare. Aveva raggiunto, prima, la Provenza dei catari e degli albigesi, attraverso il latino ma con l’influenza del manicheismo orientale. È in effetti la pista manichea, desunta dai frammenti in turco uiguro e in neo-persiano portati alla luce dalle spedizioni archeologiche di inizio Novecento, quella che con più forza è emersa nel rompicapo degli eruditi sull’origine del Buddha cristiano. Ed ecco, il cerchio si chiude, riportandoci al rotolo di Seiun-ji.
Quest’immagine di perfetto sincretismo a sua volta permette un ulteriore passo indietro. Dal bacino del manicheismo emergeva, tra il IV e il V secolo, il massimo cervello cristiano di tutti i tempi, Agostino. Quella che aveva conosciuto in Mani era una dottrina gnostica già impregnata di un’idea di salvezza propriamente religiosa. Ma in realtà, nel seno della filosofia ellenistica in cui il flusso oriente-occidente era continuo, lungo la rotta della conquista di Alessandro, nello splendore dei regni indogreci, nelle predicazioni dei monaci greci buddisti che re Ashoka inviò ai monarchi affacciati sul Mediterraneo, o degli asceti erranti che giunsero fino alla corte di Augusto, lo stesso germoglio di ciò che chiamiamo buddhismo dovette essere rinvigorito dallo scambio, prima che con lagnosi, con il pensiero delle scuole elleniche.
Anche se la prima menzione del Buddha nella storia della letteratura europea si trova solo alla fine del II secolo, negli Stromata, i “Tappeti” letterari di Clemente di Alessandria, è congetturabile una coabitazione e contaminazione tra le dottrine del Gautama Sakyamuni e quelle, ancora recentemente evocate da Christopher Beckwith, dei filosofi scettici, o dello stoicismo antico.
Se non possiamo non dirci buddisti, cos’è allora che veramente noi occidentali chiamiamo buddismo? Non una dottrina, non una religione, non una filosofia, piuttosto la prensile erba di una conoscenza capace di allacciarsi e adattarsi e dare linfa a diverse religioni, dottrine, filosofie.
Il germe radicato nel nostro passato, ciclicamente reinterrato e rifiorito, di una verità universalmente diffusa perché straordinariamente persuasiva, indiscutibile e intuibile, in certi folgoranti attimi, anche a livello prerazionale: la percezione, continuamente rimossa, delle “cose come sono”, per usare l’espressione di Hervé Clerc; la stupefazione che sta all’origine di ogni visione filosofica; dove il riconoscimento dell’illusorietà dell’esistenza e dell’impermanenza dell’essere è in realtà il nucleo stesso di ciò che gli antichi greci, poco dopo la morte del Gautama storico, chiamarono per la prima volta filosofia.
La Repubblica – 16 gennaio 2016
↧
B. PASTERNAK, In ogni cosa ho voglia di arrivare sino alla sostanza
Pasternak con Olga e Irina
L' inverno di Paul Klee
In ogni cosa ho voglia di arrivare
sino alla sostanza.
Nel lavoro, cercando la mia strada,
nel tumulto del cuore.
Sino all’essenza dei giorni passati,
sino alla loro ragione,
sino ai motivi, sino alle radici,
sino al midollo.
Eternamente aggrappandomi al filo
dei destini, degli avvenimenti,
sentire, amare, vivere, pensare,
effettuare scoperte.
Oh, se mi fosse dato, se potessi
almeno in parte,
mi piacerebbe scrivere otto versi
sulle proprietà della passione.
Sulle trasgressioni, sui peccati,
sulle fughe, sugli inseguimenti,
sulle inavvertenze frettolose,
sui gomiti, sui palmi.
Dedurrei la sua legge,
il suo cominciamento,
dei suoi nomi verrei ripetendo
le lettere iniziali.
I miei versi sarebbero un giardino.
Con tutto il brivido delle nervature
vi fiorirebbero i tigli a spalliera,
in fila indiana, l’uno dietro l’altro.
Introdurrei nei versi la fragranza
delle rose, un àlito di menta,
ed il fieno tagliato, i prati, i biodi,
gli schianti della tempesta.
Così Chopin immise in altri tempi
un vivente prodigio
di ville, di avelli, di parchi, di selve
nei propri studi.
Giuoco e martirio
del trionfo raggiunto,
corda incoccata di un arco teso.
Boris Pasternak
sino alla loro ragione,
sino ai motivi, sino alle radici,
sino al midollo.
Eternamente aggrappandomi al filo
dei destini, degli avvenimenti,
sentire, amare, vivere, pensare,
effettuare scoperte.
Oh, se mi fosse dato, se potessi
almeno in parte,
mi piacerebbe scrivere otto versi
sulle proprietà della passione.
Sulle trasgressioni, sui peccati,
sulle fughe, sugli inseguimenti,
sulle inavvertenze frettolose,
sui gomiti, sui palmi.
Dedurrei la sua legge,
il suo cominciamento,
dei suoi nomi verrei ripetendo
le lettere iniziali.
I miei versi sarebbero un giardino.
Con tutto il brivido delle nervature
vi fiorirebbero i tigli a spalliera,
in fila indiana, l’uno dietro l’altro.
Introdurrei nei versi la fragranza
delle rose, un àlito di menta,
ed il fieno tagliato, i prati, i biodi,
gli schianti della tempesta.
Così Chopin immise in altri tempi
un vivente prodigio
di ville, di avelli, di parchi, di selve
nei propri studi.
Giuoco e martirio
del trionfo raggiunto,
corda incoccata di un arco teso.
Boris Pasternak
↧
↧
QUANDO LA MAFIA NON SI CHIAMAVA MAFIA...

La «Garduña» e le mafie. Ogni origine ha un mito
di Antonella FalcoLa Garduña è una leggendaria società segreta di matrice criminale che avrebbe svolto la sua attività in Spagna e nelle colonie spagnole del Sudamerica in un arco di tempo compreso fra la metà del XV e il XIX secolo. Proprio alla Garduña è dedicato un interessante saggio di Marta Maddalon e John Trumper dal titolo La costruzione del racconto: la “vera” invenzione della Garduña, uscito sul numero 69 de La ricerca folclorica.
John Trumper, studioso di glottologia e linguistica generale, ha pubblicato numerosi saggi di fonetica e fonologia, dialettologia romanza e italiana, sociolinguistica e linguistica applicata. Si è inoltre occupato di etnolinguistica e linguistica storica, di fonetica giudiziaria e di gerghi di mestiere. Marta Maddalon è studiosa di linguistica e sociolinguistica. I suoi interessi di ricerca riguardanti la sociolinguistica, l’etnolinguistica e lo studio della lingua e dei suoi dialetti l’hanno portata a pubblicare testi sull’analisi degli usi linguistici nell’Italia contemporanea e saggi sul fenomeno della rivendicazione identitaria mediata dalla lingua come nel recente Ventimila leghe. Immersione negli usi linguistici dei movimenti politici dell’Italia contemporanea (Aracne, 2013). Maddalon e Trumper non sono nuovi agli studi sulla lingua delle organizzazioni mafiose, infatti nel 2014, insieme al magistrato Nicola Gratteri e allo storico delle organizzazioni criminali (nonché uno dei massimi esperti di ‘ndrangheta a livello internazionale) Antonio Nicaso, hanno dato alle stampe il saggio Male lingue. Vecchi e nuovi codici delle mafie (Pellegrini Editore).
I due autori partono dalla constatazione che la storia della Garduña è presente «nelle leggende e nei canti popolari della Calabria»– constatazione suffragata da alcuni libri sia italiani che stranieri, anche molto recenti, quale ad esempio il volume Made Men di Antonio Nicaso e Marcel Danesi. Anche nel volume di Enzo Ciconte ‘Ndrangheta dall’unità ad oggi (del 1992, dunque meno recente dell’altro, uscito nel 2014) si fa riferimento ad una «nota associazione fondata a Toledo nel 1412, la Garduna» e ai cavalieri facenti parte di tale associazione, i quali «dalle loro terre, quelle della Catalogna, portarono nel Mezzogiorno d’Italia alcuni metodi in uso in quella consorteria. Si racconta che lavorarono per 29 anni, sottoterra, di nascosto da tutti, per approntare le regole sociali della nuova associazione che avevano in animo di costituire. La sede da loro prescelta fu l’isola della Favignana. Da lì, dopo un lavoro trentennale, decisero di dividere in tre tronconi l’associazione che, da quel momento, si insediò stabilmente nelle regioni meridionali, e si denominò mafia in Sicilia, camorra nel napoletano e ‘ndrangheta in Calabria. È un’antica leggenda, di cui non esistono molte tracce scritte, che si è tramandata oralmente…».
Si tratta per lo più di testi che descrivono dettagliatamente l’organizzazione della società (i livelli in cui si articolerebbe e i vari ruoli e denominazioni presenti al suo interno) e che oscillano tra la tentazione di dare consistenza realistica alla Garduña e l’ammissione del suo essere sostanzialmente una invenzione letteraria assunta però come mito di fondazione dalla mafia calabrese. Trattare il tema della Garduña e dimostrare la sua identità prettamente letteraria ha ovviamente comportato per gli autori del saggio uno studio attento della storia e della letteratura spagnola dal XV al XIX secolo.
In tutte le narrazioni sulla camorra fiorite dall’Ottocento in poi si fa riferimento molto spesso a un testo intitolato Misteri dell’Inquisizione ed altre società segrete di Spagna, per V. de Féréal, con note storiche ed una introduzione di Manuel de Cuendias e con estratti relativi a quest’opera di Edgardo Quinet. Prima versione italiana, Parigi, a spese dell’editore 1847. Sarebbe questa la traduzione italiana di un testo francese del 1845 poi tradotto anche in spagnolo. Questo testo sarebbe da considerarsi una «narrazione romanzesca», cosa tra l’altro espressamente dichiarata dagli autori, che a loro volta potrebbero celarsi dietro degli pseudonimi. Fra questi potrebbe trovarsi una nobildonna tedesca nota con il nome di Madame de Suberwick, la quale per scrivere il suo libro avrebbe viaggiato in Spagna travestita da uomo. Sempre a Madame de Suberwick sarebbe riconducibile un altro testo dal titolo tanto inquietante quanto satirico di Conseils de Satan aux Jésuites, la cui autrice è stavolta denominata Madame de Beelzebuth. Ma secondo gli studiosi spagnoli l’unico personaggio la cui reale esistenza sia storicamente provata è Cuendias, il quale avrebbe anche scritto un progetto di Costituzione progressista conservata nella Biblioteca Nazionale di Madrid. Sempre secondo gli studiosi cui Trumper e Maddalon fanno riferimento si tratterebbe comunque di personaggi – forse di un collettivo – accomunati da un atteggiamento strenuamente anticlericale.
«Quello che è ancora più certo» – scrivono Trumper e Maddalon – «è che rapporti diretti di derivazione, tra società segrete spagnole, vere o letterarie, e organizzazioni criminali storiche italiane non ve ne sono, affermazione che non nega o sottovaluta l’aspetto storico degli influssi dovuti al periodo del Viceregno nel Regno delle Due Sicilie. Vi è invece, come commentano da molto tempo gli storici che si sono occupati della storia dell’Inquisizione, la creazione di un Racconto intorno a questa istituzione, che va ben al di là della sua reale esistenza e del suo modo di operare. Ciò fece sì che nel XVI secolo, a fronte di una rivoluzione di tipo confessionale che viene assumendo una dimensione politica, l’Inquisizione, o meglio la sua immagine letteraria, divenne il simbolo del nemico della libertà politica, a rappresentare cioè i pericoli dell’innaturale alleanza tra il Trono e l’Altare».
L’Inquisizione viene così a incarnare un’entità reazionaria che si oppone al progresso e che «rappresenta l’eccessivo potere temporale della religione». Nel corso del XIX secolo essa diventa protagonista di numerose narrazioni romanzesche il cui scopo politico risulta ben evidente. Tale fenomeno interessa varie nazioni europee, tutte «accomunate da un contrasto politico che coinvolge spinte clericali e anticlericali».
La narrazione di un «perverso piano inquisitoriale» finisce per confluire anche nei codici ‘ndranghetisti: è quanto avviene nel cosiddetto Codice di Pellaro, un manoscritto sequestrato appunto nel territorio di Pellaro in data 22 marzo 1934 e intitolato Origine dei tre cavalieri di Spagna. In esso sono contenute le norme relative alla fondazione della Società di Malavita e quelle relative alla gerarchia che regola l’organizzazione degli affiliati. La parte iniziale di tale codice sembra essere molto simile a un romanzo di cappa e spada o di appendice. Ad ogni modo sembra fuori di dubbio che chi lo ha scritto abbia letto i Misteri. In questo tipo di racconti, inoltre, si evince sia in Spagna che in Francia la complessa organizzazione gerarchica delle associazioni criminali menzionate, di cui Maddalon e Trumper forniscono una dettagliata terminologia. Bisogna inoltre sottolineare come «le associazioni criminali protagoniste di questo filone letterario derivano, come nel caso spagnolo, da vicende reali».
Sebbene sia qualcosa di diverso, anche il banditismo, specie quello sociale, fornisce materiale per trasposizioni letterarie: «banditi e briganti sono molto radicati nella cultura popolare e celebrati in un filone musicale, talvolta di buon livello, che vede anche trasposizioni contemporanee».
Tra i rimandi letterari non si può tacere di quello relativo a Cervantes, chiamato in causa dagli autori (o dall’autore) dei Misteri, infatti «per dare spessore storico alla descrizione della Garduña, si ricorda che è precisamente in un delizioso racconto dell’autore del Don Chischiotte che si incontra Manipodio, il capo della società dei ladri di Siviglia».
Pertanto, i due autori del saggio si dicono convinti che «alla luce di questo rimando, la fonte di tale filone interpretativo per l’origine della camorra e per il Racconto dei Codici possa essere definitivamente identificata».
Tra gli autori ottocenteschi che sostengono la filiazione della criminalità del Meridione italiano dalle forme spagnole, Maddalon e Trumper citano Marc Monnier, Emanuele Mirabella e Abele De Blasio a cui aggiungono l’anonimo autore di un testo intitolato Natura e origine della misteriosa setta della camorra (nelle sue diverse sezioni e paranze, linguaggio convenzionale di essa usi e leggi). Uno dei capitoli è proprio incentrato sulla lingua e si intitola Lingua furfantina dei camorristi. È comunque interessante notare come tutti gli studi dell’epoca sull’argomento diano grande risalto agli aspetti linguistici. Degli altri autori citati il più noto risulta essere Monnier il quale è menzionato in molti testi sulle associazioni criminali meridionali, mentre, sempre basandoci sui testi, risulta completamente sconosciuto l’altro autore, Mirabella, il quale però «scrive l’opera più completa sul gergo criminale dei prigionieri e dei condannati al soggiorno obbligato». Mirabella inoltre ebbe modo di vivere per diversi anni a contatto dei prigionieri di Favignana in quanto medico della colonia penale.
Altro testo di una certa importanza risulta essere Usi e costumi dei camorristi di De Blasio, contenente «esempi di codici e dell’assetto dell’organizzazione camorristica» sia dentro che fuori dalle carceri, assetti che sono tra l’altro «perfettamente rispondenti a quelli ‘ndranghetisti».
Per quanto riguarda una filiazione diretta dalla Spagna, Monnier pur non trovando prove documentali sostiene che le «estorsioni» dei criminali meridionali erano già presenti fin dal tempo della dominazione spagnola. Sia pure in mancanza di «prove dirimenti» questi testi, come scrive Nappi nel suo saggio Il mito delle origini spagnole della camorra tra letteratura e storia, «accogliendo talvolta qualche variazione leggendaria sul tema delle origini ispaniche della camorra, chiameranno quasi sempre in causa la suddetta compagnia segreta variandone la dizione in Guarduña, Guarduna, Garduña o infine nel corretto Garduña».
Non ci sono dubbi circa il fatto che Monnier conosca i Misteri, libro che «fornisce lo spunto per i riferimenti, divenuti obbligatori, a Cervantes, e all’ormai inflazionata novella Rinconete y Cortadillo e a vari episodi del Don Chisciotte».
Anche De Blasio pur sostenendo di non occuparsi dell’etimologia della parola camorra fa notare come essa non sia che la Garduna «che fu introdotta in queste nostre provincie nell’epoca in cui il Regno di Napoli e Sicilia rimase soggetto […] allo scettro di Spagna e governato da Vicerè, che ridussero il popolo povero e servo».
Maddalon e Trumper ricordano come molti autori, antichi e moderni, citando Cervantes avvalorino la tesi secondo cui il noto scrittore spagnolo abbia, nel suo romanzo più famoso, descritto in modo quasi storico-antropologico una serie di comportamenti e di associazioni che dimostrerebbero l’esistenza di “sette” criminali, cosa appunto sostenuta nei Misteri. A proposito dell’episodio di Sancho governatore, ad esempio, si parla del “barato”, ossia l’usanza di pretendere il pizzo sul gioco. Sul termine “barato” si concentra il commento linguistico di Maddalon e Trumper presente nella seconda parte del saggio che stiamo esaminando. Prima di soffermarci su tale trattazione etnolinguistica è bene però ricordare, come fanno gli stessi autori, una altro passo di Cervantes utile ai fini dell’argomento affrontato. Si tratta di un episodio che si colloca nel XV capitolo ed è incentrato sull’incontro con il bandito Roque Guinart. Di costui parla in un suo commento Don Juan Antonio Pellicer, accademico della Reale Accademia di Storia, il quale coglie l’occasione «per parlare della presenza di bande di briganti che infestavano realmente la Sierra della Cabilla, in particolare una, denominata Beatos de Cabilla, i cui membri erano così chiamati in virtù del fatto che si limitavano a esigere solo una parte degli averi delle loro vittime, circoscrivendo quindi il danno e meritandosi per questo l’epiteto di “Beati”». È bene far notare che un certo Perot Rocaguinarda è esistito realmente, e aveva fama di bandito gentiluomo: su tale modello Cervantes avrebbe delineato il carattere del personaggio presente nel suo romanzo. Questa categoria di banditi che mescolavano crimini e azioni caritatevoli, religione ed empietà, era diffusa, a detta degli storici, in diversi paesi.
Agli occhi dei primi meridionalisti, quali Villari e Tranfaglia, la camorra – come anche la ‘ndrangheta e la mafia – assumerebbe il ruolo, contemporaneamente, di protettore e oppressore di una plebe povera e abbandonata a se stessa dal governo borbonico. Oltre a svolgere un ruolo “protettivo”, la camorra si farebbe anche «rappresentante dei loro interessi e della loro cultura», il che darebbe adito alla figura del bandito “buono” che incarnerebbe una forma di «giustizia alternativa». Secondo John Dickie, invece, la ‘ndrangheta sarebbe da intendere come una sorta di «filiale» della camorra di cui riprenderebbe il Racconto e la mitopoiesi. La sua origine sarebbe in tal caso spostata in un periodo più tardo, quello post-unitario e se ne rintraccerebbero con difficoltà «i precedenti storici e linguistici».
Maddalon e Trumper citano tra gli altri un saggio di Nicola Sales, pubblicato sulla rivista Limes nel novembre del 2014, un saggio che ha avuto ampia risonanza in quanto ha visto la partecipazione di Roberto Saviano. Ecco come Sales sintetizza la questione: «Dunque, tutte e tre le organizzazioni criminali nascono nello stesso periodo storico, all’inizio dell’Ottocento, a ridosso della fine del feudalesimo (nel 1860 a Napoli e nelle province continentali, nel 1812 in Sicilia), a imitazione delle associazioni politiche segrete in cui gli oppositori al regime assolutistico borbonico si erano organizzati. […] Le associazioni criminali, che poi chiameremo mafie, si organizzano sul modello politico delle sette segrete dei ceti aristocratici e borghesi».
Maddalon e Trumper, pur annotando le perplessità circa l’uso della parola “feudalesimo” nell’accezione utilizzata da Sales e sull’analisi politica da questi compiuta, si soffermano principalmente sull’attribuzione «di un ruolo primario all’influenza di sette segrete dei ceti aristocratici e borghesi», sostenendo che «la discussione sulla segretezza, in cui la lingua gioca una parte preponderante, non disgiunta dalla definizione di “setta”, spesso usata a sproposito, ha il demerito di allontanare da una corretta definizione dei fenomeni coinvolti, non ultimo quella del gergo».
Per quanto concerne i motivi per cui potrebbero trovarsi dei riscontri tra il Racconto dei codici ‘ndranghetisti (i cui primi esemplari risalgono, sia culturalmente che linguisticamente, alla permanenza nelle carceri oppure al soggiorno coatto) e gli antecedenti letterari, Maddalon e Trumper ricordano che sia i romanzi d’appendice, che quelli di cappa e spada, nonché gli strani testi di cui i due studiosi hanno dato conto nelle pagine iniziali del loro saggio, avevano una larga diffusione presso i ceti popolari e anche nelle carceri. Inoltre, i due linguisti fanno notare come sia prassi comune di molte società, non necessariamente vicine o collegate, trasfondere in ambito letterario, epico e/o musicale, le figure e le gesta dei banditi. Capita anzi, come nota Eric Hobsbawm nel suo Bandits, che le classi subalterne li eleggano a propri eroi. Il fatto poi che questi banditi riescano a coniugare la violenza con le spinte ribellistiche e l’atteggiamento solidale e soccorrevole nei confronti dei più deboli, concorrono a spiegare la creazione di una siffatta figura letteraria. Questi banditi inoltre facevano un largo uso di simboli religiosi ed erano molto superstiziosi. Tali comportamenti risultano diffusi su ampia scala, vale a dire si ritrovano in tutte le descrizioni della figura del bandito in qualsiasi Paese europeo, questo però non porta alla conclusione di un «rapporto diretto di derivazione nel caso della criminalità organizzata italiana» ma solo al fatto che esistono comportamenti pressoché universali di cui l’antropologia culturale fornisce ampio conto. Naturalmente il mito creatosi attorno ai briganti e ai banditi romantici serve a rafforzare l’aura di protettori della povera gente e difensori degli oppressi al punto da renderli protagonisti di racconti e di canti popolari. Questi fenomeni storicamente connotati si sono radicati nell’ambito della cultura popolare e poi sono passati nella letteratura “colta” già ai tempi di Cervantes. Quando si parla codici ‘ndranghetisti bisogna aver chiaro che essi sono una molteplicità di cose e vanno pertanto studiati con notevole rigore. Essi sono infatti, tra le altre cose, «una creazione letteraria, che attinge da fonti popolari ben radicate; sono l’invenzione di un Mito di fondazione, sono un modello per sancire un’appartenenza». Ma non sono solo questo. È bene ricordare che si tratta di «un’invenzione relativamente recente». Maddalon e Trumper riconoscono pertanto che «non è stato facile ricostruire la serie di incastri, di nomi e di nomi in codice (pseudonimi), degli scherzi e delle (mezze) verità; è stato come seguire le trame dei romanzi d’appendice, in cui ad ogni scoperta seguiva la sua negazione, ogni agnizione introduceva nuove scoperte, e così via puntata dopo puntata».
Nella seconda parte del loro saggio Maddalon e Trumper si soffermano innanzitutto sul fatto che indicare una data di nascita precisa, il 1427, per la Garduña – dalla quale poi sarebbero derivate la camorra napoletana e la ‘ndrangheta e i suoi codici – è cosa che lascia assai perplessi. Solitamente quando si parla della nascita di un fenomeno sociale si indica il periodo storico e non una data precisa, indicare quest’ultima implicherebbe infatti «un atto fondativo formale e registrato». Già questo avrebbe dovuto mettere in guardia i commentatori e portarli a diffidare del carattere “storico” del racconto, da intendersi piuttosto in maniera simbolica. Lo stesso discorso vale per la “Bella Società Riformata” – dove “riformata” significherebbe “confederata” – la quale, in base ad alcune fonti, sarebbe nata ufficialmente nel 1820. Luogo di nascita di questa «setta» sarebbe stato la chiesa napoletana di Santa Caterina a Formiello, dove gli esponenti della camorra dei dodici quartieri di Napoli stabilirono nell’ambito di una solenne cerimonia lo statuto della nuova associazione, stabilendo anche che il «capintesta» dovesse essere nativo del quartiere di Porta Capuana, cosa questa fatta ad imitazione delle usanze aristocratiche che per secoli avevano riservato la dignità di Presidente degli Eletti del Popolo (carica soppressa nell’aprile del 1800) al cosiddetto «Sedil Capuano». La Bella Società Riformata sarebbe stata sciolta il 25 maggio 1915, all’indomani dello scoppio della prima guerra mondiale, per volontà del capo camorrista Gaetano Del Giudice. Fu così che durante tutto il periodo fascista non si sentì più parlare di camorra: si continuò a delinquere ma senza avere alle spalle un’organizzazione.
Secondo Maddalon e Trumper l’idea di una associazione criminale organizzata come una setta o una società vera e propria, munita pertanto di statuto e cariche, risulta assai poco verosimile. Anche in questo caso viene da pensare a un Racconto creato a posteriori e poi tramandato.
Nelle opere letterarie e nelle cronache si trova notizia anche di un’altra organizzazione criminale nota come Germanìa: secondo Caro Baroja sarebbe esistita sia una Germanìa carceraria, «che era non solo un gergo ma anche un sistema», sia una Germanìa esterna alle carceri i cui metodi sarebbero stati gli stessi di quelli utilizzati per fondare la Garduña. Si trova un riferimento alla Germanìa anche nel Rinconete y Cortadillo di Cervantes.
Per quanto concerne l’ambito italiano i due studiosi precisano che il mondo carcerario pur non costituendo l’unica origine delle organizzazioni criminali, fornisce comunque ad esse alcune regole e caratteristiche, nonché una certa organizzazione e una certa simbologia.

Da un punto di vista più strettamente linguistico “Garduña” è termine che ricorre anche in un toponimo: Sierra de Garduña. Nel senso attinente all’organizzazione criminale, la parola viene citata e glossata originariamente proprio dagli autori che ne parlano nei loro testi. Garduña è termine connesso con la parola “garda” e in ultima istanza, attraverso vari passaggi, il suo significato è riconducibile a termini quali “ladra” e “meretrice”. Il termine non sembra essere presente al di fuori dei già citati Misteri e nelle riprese degli autori italiani. Tuttavia esiste un’opera letteraria non tradotta in italiano e pertanto poco nota, che si intitola La Garduña de Sevilla y anzuelo de las bolsas ed è stata scritta da Alonso De Castillo Solórzano nel 1642. L’espressione “anzuelo de las bolsas” sarebbe da tradurre come “gancio delle borse” e sarebbe l’attrezzo usato da una borsaiola, infatti, come si è ricordato poc’anzi, “garduña” significherebbe “ladra”. Tuttavia la novella – ascrivibile al genere, assai praticato in ambito narrativo, della fanciulla che con abilità e astuzia riesce a volgere al meglio la propria sfortuna – non avrebbe nulla a che fare con la camorra.
Un altro termine sul quale si soffermano Trumper e Maddalon è “barattolo”. A questo proposito i due studiosi precisano che mentre «il lessico dei dialetti siciliani è permeato di ispanismi […] nel caso della Calabria, al contrario, i casi sono decisamente pochi, dai nostri studi più recenti non più di una cinquantina». Per quanto riguarda l’ambito napoletano sono annoverate 85-90 basi ispaniche assolutamente certe. Dunque « mentre il siciliano è ancora permeato di ispanismi» napoletano e calabrese lo sono assai meno. Il termine “barattolo” indicherebbe la cassa comune della malavita e corrisponderebbe al termine ‘ndranghetista “baciletta”. «Il barattolo è organizzato dal “contarulo”» il quale aveva il compito di tenere il registro e segnare l’ammontare del barattolo. Secondo i due studiosi piuttosto che concentrarsi sul concetto di “frode” e di “maltolto” sarebbe preferibile concentrarsi sul “barattolo” inteso come “contenitore”. Il termine ha la sua prima attestazione in siciliano nel 1750, in napoletano nel 1840, ma è presente nel toscano già dalla fine del ‘500. In Calabria comparirebbe nel 1895, sebbene la primissima attestazione, secondo il Glossario Latino Italiano di Pietro Sella risalirebbe al 1449 e in generale sarebbe «riconducibile al Centro-Sud Italia». Nell’Ottocento gli studiosi siciliani ritenevano il termine come un arabismo giunto a noi attraverso lo spagnolo rigettando l’origine nord-italiana proposta da Battisti e Devoto.
Altro termine su cui si soffermano Maddalon e Trumper è “barratteria”. In molti passi della sua opera Monnier ipotizzava che la barratteria napoletana fosse di origine spagnola. Mortillaro e De Ritis mettono in relazione il termine con il racconto dell’Isola di Baratteria DI Sancho Pança in Cervantes, passo che anche Monnier cita e che è commentato da Nappi. Quella che viene ipotizzata è una deriva semantica che da “traffico commerciale” e ”cambio” conduce a “frode”. In Calabria il verbo “barattare” risulta attestato dal 1466 ma non il derivato sostantivo “barattaria”. In italiano il DEI attesta “baratteria” nel Trecento nell’uso dantesco di “frode da barattiere”, mentre la Tabula Amalfitana lo attesta nei secoli ‘300-‘400 nel significato di «frode a danno dei proprietari di nave o degli armatori, e nel Settecento la si ritrova nel senso di ‘rivendita’ o ‘rivenderia’ di cose scambiate con o senza frode a più basso prezzo». In Francia la voce “baraterie” risulta attestata già nel primo Trecento ma sembra che la primogenitura del termine spetti alla Provenza. L’accezione negativa di questa parole potrebbe, nel Meridione d’Italia e segnatamente in Calabria e Sicilia, dipendere da «un’influenza formale e semantica del bizantino». A proposito di questo termine Maddalon e Trumper giungono quindi alla seguente conclusione: «Più che un’origine spagnola, pensiamo, dunque, a un antico provenzalismo con sviluppi semantici particolari avvenuti nell’Italia meridionale».
L’ultimo termine su cui si sofferma l’indagine dei due studiosi è “frieno” da loro definito come «uno dei misteri ancora non completamente svelati nel lessico criminale». «La forma, ancor più del significato e dell’origine, resta problematica; il dittongo – ie – non corrisponde a nessun esito usuale o previsto. La voce non ricorre in Monnier ma è attestata almeno otto volte nell’opera di De Blasio, con il significato di ‘regola’ (singola) o ‘regolamento’; ‘statuto’ (insieme di regole) della società criminale organizzata, denominata poi Camorra». I dizionari siciliani e calabresi dell’Ottocento danno al termine “camorra” il significato di “cavezza”, “briglia” in riferimento agli equini oppure quello di “morso” e “freno del carro”, mentre i dizionari dialettali napoletani sia del Settecento che dell’Ottocento sembrano non avere questo lemma e registrano solo un generico “frino” per “freno”. Secondo Trumper e Maddalon la “camarra” attestata nell’estremo meridione d’Italia sarebbe da confrontare con il termine castigliano “gamarra” che significa “sottopancia di equino”, “cavezza”. Il “freno” inteso come singola regola o come regolamento e statuto sarebbe attestato solo in fonti circoscritte all’Ottocento e riguardanti Napoli e la camorra, «mentre nel Medio Evo vi sono fonti provenzali e catalane che danno estensioni semantiche di simile natura: ‘freno naturale’, ‘il regolamentarsi’ […] Supporre una qualunque origine tanto remota e varia è piuttosto inutile, per cui, il mistero permane».
Per quanto concerne la “Germanìa”, essa è probabilmente l’unica organizzazione spagnola, sia carceraria che esterna, ad aver avuto un’esistenza reale e non solo letteraria. Essa è da intendersi come «un fenomeno autenticamente spagnolo, che ha origine tra Quattro e Cinquecento». Dal punto di vista terminologico potrebbe trattarsi di un catalanismo con il significato di “confraternita” risalente al tardo Quattrocento e indicante gruppi rivoluzionari di Nobili Catalani di Valenzia, tuttavia, concludono i due autori del saggio «Questo nome non ha mai avuto diffusione fuori della penisola iberica e dei paesi di lingua spagnola».
Articolo tratto da http://www.nazioneindiana.com
↧
MACBETH AL CINEMA
“La vita non è che un ombra che cammina; un povero commediante che si pavoneggia e si agita, sulla scena del mondo, per la sua ora, e poi non se ne parla più; una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, che non significa nulla”.(Shakespeare)
Paolo D'Agostini
Alla corte di Shakespeare Fassbender e Cotillard diventano due giganti
Ispiratrice di un’interminabile galleria di interpretazioni teatrali, alimento per musica (Verdi, per esempio) e arti figurative, la tragedia di Shakespeare conta numerose rivisitazioni cinematografiche. Le più celebri quelle di Orson Welles e Akira Kurosawa ( Trono di sangue). I personaggi di Macbeth e di Lady Macbeth sono diventati un archetipo, un paradigma: dell’ambizione senza freni e della cieca smania di potere, dell’insinuarsi velenoso dell’invidia, del sospetto e della gelosia che armano l’insaziabile vendetta.
Ricordiamo. Macbeth signore di Glamis, combattente intrepido e leale quanto valoroso generale al servizio del re di Scozia Duncan, ha sconfitto sul campo di battaglia (scena potentissima, nel film di Justin Kurzel: cruenta e dominata dalla cupezza della brughiera che fa da grigio scenario, ma ben lontana dalla pacchiana dismisura ostentatamente ultrarealistica di tanti spettacoloni bellici in costume medievale) il traditore Macdonwald. Vittoria consegnata fedelmente nelle mani del re. Però turbata dalla profezia delle tre streghe che gli sono apparse sul campo di battaglia annunciando per lui un futuro da re ma per il suo compagno Banquo un destino da capostipite di una dinastia di re: Macbeth e sua moglie hanno appena perduto il loro unico figlio.
Sarà lei, in occasione del ricevimento offerto presso la loro residenza di Inverness a re Duncan – che annuncia il passaggio della corona a suo figlio Malcolm – a suggerire al marito un piano regicida. Che Macbeth esegue nella notte riuscendo a dirottare i sospetti proprio su Malcolm (che dopo averlo visto uccidere è fuggito), e ad essere incoronato erede di Duncan.
Da qui un’escalation di delirio omicida. Macbeth ordina l’uccisione di Banquo, e subito dopo viene perseguitato dal suo fantasma, e di suo figlio Fleance. Il prossimo nemico da neutralizzare è il dignitario Macduff, che ha iniziato a sospettare di lui. Macbeth fa sopprimere tutta la sua famiglia mentre Macduff ha raggiunto Malcolm in Inghilterra dove sta organizzando una spedizione contro Macbeth.
Un’ulteriore appendice di profezia delle tre streghe gli dice, in modo sibillino, che non avrà nulla da temere fino a quando la foresta non raggiungerà il castello reale di Dunsinane, e che egli non morirà per mano di un uomo nato da una donna. Solo più tardi il mistero si chiarirà. Quando l’assedio portato dall’esercito di Malcolm e Macduff, incendiando la foresta, otterrà che il vento sospinga fumo e fuoco verso Dunsinane. E quando Macbeth scoprirà che il rivale Macduff è nato da parto cesareo. Intanto però Lady Macbeth, schiacciata dalla colpa, abbandona il marito alla sua deriva di follia tirannica. Che non gli impedirà, malgrado il coraggio, di soccombere.
L’immagine che forse ci è stata tramandata più forte è quella dell’insopportabile peso della colpa che induce Lady Macbeth ad abbandonare suo marito dopo essere stata l’ispiratrice della sua perdizione. Ma la metafora sulla follia cui può portare la brama di potere ha trovato innumerevoli quanto infauste conferme nel corso della storia successiva. Giganteggiano le due performance principali di Michael Fassbender e di Marion Cotillard circondati da comprimari di classe. In un disegno che armonizza il devoto rispetto per un classico con la creatività di soluzioni adatte al mezzo di espressione.
La Repubblica – 7 gennaio 2016
↧
PAPA FRANCESCO E IL VANGELO DEL CONFLITTO
Papa Francesco letto da un laico
IL VANGELO DEL CONFLITTO
Alberto Asor Rosa
Nelle settimane passate è apparso in Italia un testo di Papa Bergoglio, che a me sembra di grande importanza. Si tratta dell’intervento da lui pronunciato a un Congresso internazionale di teologia (da lui stesso voluto e preparato), svoltosi a San Miguel in Argentina dal 2 al 6 settembre 1985, sul tema “Evangelizzazione della cultura e inculturazione del Vangelo”.
L’intervento, nella forma pubblicata da Civiltà cattolica, porta il titolo “Fede in Cristo e Umanesimo”. Ritengo però che il suo vero tema sia più esemplarmente testimoniato da quello del convegno.
Andrò per accenni, limitandomi a segnalare quello che, dal mio punto di vista, spicca per novità e intelligenza del discorso. In effetti, trovo, per cominciare dagli inizi, che ipotizzare questa doppia missione – che è anche un doppio movimento di andata e ritorno per ognuno dei due elementi che lo compongono, e cioè: “evangelizzazione della cultura” e “inculturazione del Vangelo”– significa offrire una visione nuova dei rapporti tra la “fede cristiana” e “il mondo”. Bergoglio, infatti, non dice: “questa” o “quella cultura”. Dice: “cultura”. A chiarimento della tesi scrive: «Stiamo rivendicando all’incontro tra fede e cultura, nel suo duplice aspetto di evangelizzazione della cultura e di inculturazione del Vangelo, “un momento sapienziale”, essenzialmente mediatore, che è garanzia sia dell’origine (movimento di creazione) sia della sua pienezza e fine (movimento di rivelazione)». «Un momento sapienziale, essenzialmente mediatore…»: se la traduzione dallo spagnolo in italiano non ha deformato qualche senso, questo vuol dire che tra “fede” e “cultura” si può stabilire un confronto, i cui momenti di reciprocità sono destinati a influenzare sia l’una sia l’altra parte, producendo, attraverso la “mediazione”, un accrescimento di sapere e di conoscenza per tutti.
Bergoglio chiama in causa una parola-concetto tipicamente laica o quanto meno mondana: “mediatore”, mediazione. Tale impressione però si accentua, in misura significativa, nella lettura di un brano seguente, che qui riporto per intero, perché lo trovo denso di parole-concetti sorprendenti: «La base di questo sforzo è sapere che nel compito di evangelizzare le culture e di inculturare il Vangelo è necessaria una santità che non teme il conflitto ed è capace di costanza e pazienza. Innanzi tutto, la santità implica che non si abbia paura del conflitto: implica parresia, come dice San Paolo. Affrontare il conflitto non per restarvi impigliati, ma per superarlo senza eluderlo. E questo coraggio ha un enorme nemico: la paura. Paura che, nei confronti degli estremismi di un segno o di un altro, può condurci al peggiore estremismo che si possa toccare: l’“estremismo di centro”».
In questo caso, la parola-concetto centrale è: “conflitto”. Si deve ammettere che siamo di fronte a una acquisizione inedita nel campo della cultura cristiano-cattolica. Il termine infatti ricorre nel pensiero e nelle problematiche del pensiero dialettico e sociologico europeo e americano degli ultimi due secoli: da Hegel a Marx, e poi Simmel, von Wiese, Dahrendorf… Nessun equivalente, almeno della stessa portata, nel pensiero cristiano-cattolico dello stesso periodo, e si capisce perché: la predicazione evangelica sembrerebbe escludere una virata di tale natura. Ma la sorpresa è destinata persino ad aumentare se si procede nell’analisi del ragionamento. «Affrontare il conflitto », scrive Bergoglio, «per superarlo », ma «senza eluderlo»; si misura con «un enorme nemico: la paura». Paura di che? Paura dei possibili estremismi, che dal conflitto possono scaturire. Ma tale paura, se incontrollata, è destinata a condurre «al peggiore estremismo che si possa toccare: l’“estremismo di centro”, che vanifica qualsiasi messaggio». L’“estremismo di centro”! In un paese come l’Italia, spesso arrivato a catastrofiche conclusioni proprio a causa di un sistematico e prevaricante “estremismo di centro”, tale messaggio dovrebbe risultare più comprensibile che altrove. Anche il riferimento alla parresia s’inserisce in questo contesto: solo chi parla alto e libero può vincere la paura.
Quali considerazioni si possono fare su posizioni, di questa natura? Su Bergoglio sono stati scritti molti articoli (bellissimi quelli di Eugenio Scalfari). Pochi, però, si sono soffermati sulla scaturigine storica delle sue prese di posizione, che è inequivocabilmente gesuitica. I gesuiti, nel corso della loro lunga storia, ne hanno combinate di tutti i colori, nella difesa perinde ac cadaver della Chiesa di Roma. E però… Molti anni or sono ho studiato a lungo la cultura gesuitica del Seicento in Italia. Mi risultò chiaro allora che carattere perspicuo della cultura gesuitica, nei momenti migliori, è sempre stato il tentativo «di operare la saldatura fra cultura laica e cultura ecclesiastica, fra tradizione e rinnovamento… »; e questo su base mondiale.
Se le cose stanno così, la domanda (provvisoriamente) finale di questa ricostruzione è: quale rapporto esiste fra la centralità della parola-concetto “conflitto” e la centralità della parola-concetto “misericordia”, alla quale Papa Francesco ha voluto dedicare il Giubileo? La risposta più semplice è: nessuno. “Misericordia” è parola evangelica, pochissimo usata in ambito laico, come pochissimo “conflitto” in ambito ecclesiale. Sono passati trent’anni dalla prima formulazione, padre Jorge Mario Bergoglio, divenuto Papa Francesco, ha ripensato radicalmente le sue posizioni, rientrando nell’ambito più tradizionale della cultura ecclesiastica. Come tutte le soluzioni troppo semplici, anche questa però si presta a un’obiezione di fondo. Una noticina al testo pubblicato da Civiltà cattolica informa infatti che il testo è stato ripresentato «in forma rivista dal Santo Padre ». Questo ci rende lecito pensare che nel pensiero di Papa Francesco “conflitto” e “misericordia” possano stare insieme. Cioè: il prodotto di una cultura laica può stare insieme con il prodotto tipico di una cultura evangelico- cristiana. Non può esserci “misericordia” se non c’è stato “conflitto”; il “conflitto” è buono, anzi, addirittura indispensabile, se è necessario per superare la paura, e superare la paura è necessario per arrivare alla “misericordia”. Sarebbe troppo pretendere che Bergoglio, divenuto Pontefice, dopo averci additato come il conflitto sia necessario per attivare la misericordia, ci additi come la misericordia sia necessaria per attivare il conflitto, motivo quest’ultimo inesauribile – e positivo, quando c’è – delle azioni umane. Però la connessione possibile – il prima e il dopo, insomma, che però è anche o può essere anche, un dopo e un prima – almeno a noi laici e non credenti, risulta – credo – ben chiara.
La Repubblica 20 gennaio 2016
↧
Preferisco... Wislawa Szymborska
Preferisco il cinema.
Preferisco i gatti.
Preferisco le querce sul fiume Warta.
Preferisco Dickens a Dostoevskij.
Preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l'umanità.
Preferisco avere sottomano ago e filo.
Preferisco il colore verde.
Preferisco non affermare che l'intelletto ha la colpa di tutto.
Preferisco le eccezioni.
Preferisco uscire prima.
Preferisco parlar d'altro coi medici.
Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio.
Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne.
Preferisco in amore gli anniversari non tondi, da festeggiare ogni giorno.
Preferisco i moralisti che non promettono nulla.
Preferisco una bontà avveduta a una credulona.
Preferisco la terra in borghese.
Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori.
Preferisco avere delle riserve.
Preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine.
Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine.
Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie.
Preferisco i cani con la coda non tagliata.
Preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri.
Preferisco i cassetti.
Preferisco molte cose che qui non ho menzionato
a molte pure qui non menzionate.
Preferisco gli zeri alla rinfusa che non allineati in una cifra.
Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale.
Preferisco toccar ferro.
Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando.
Preferisco considerare persino la possibilità
che l'essere abbia una sua ragione.
Wislawa Szymborska
↧
↧
LA FOLLIA DI NARCISO
L’epoca in cui viviamo ha esaltato la figura raccontata da Ovidio come emblema di un soggetto che basta a se stesso e che vorrebbe annullare la dipendenza dall’Altro. L’Io è diventato il nuovo idolo pagano altrettanto superstizioso di quelli che la ragione critica dell’illuminismo è riuscito a smascherare.
Massimo Recalcati
Caravaggio, seguendo il mito raccontato da Ovidio, ci presenta il giovane Narciso affacciato sulle acque che gli restituiscono — in una perfetta simmetria avvolta dal buio — la sua immagine adorata. La bellezza di Narciso contiene, si capisce, una trappola mortale: la fascinazione per se stessi può essere fatale. È quello che accade anche nel mito: nel tentativo di afferrare la propria immagine riflessa il giovane Narciso sprofonda nell’abisso delle acque perdendo la propria vita.
Freud aveva coniato da questo mito una figura fondamentale della clinica psicoanalitica: il narcisista è colui che perde la propria vita restando alienato nell’infatuazione esaltata ma sterile per la propria immagine. Nel mito di Ovidio Narciso è, infatti, colui che suscita ammirazione e amore, ma che non può, a sua volta, né provare, né ricambiare in nessuna forma. L’anestesia affettiva è un tratto anche clinico della personalità narcisistica che segnala la sua impossibilità di entrare in una forma di legame con l’altro in quanto tutta la sua libido appare sequestrata dal proprio Io.
Non a caso per Freud l’Io è il primo oggetto di investimento libidico, il suo “serbatoio” originario. Il che significa che l’essere umano non nasce predisposto all’altruismo, ma, casomai, al culto di se stesso. Il narcisismo definisce la tendenza egocentrica dell’uomo che contrasta radicalmente con la tesi aristotelica dell’uomo come animale sociale: il nostro Io è il primo grande e insidioso idolo alla cui potenza immaginaria la nostra vita si consacra.
Caravaggio, Narciso
L’illusione narcisistica vorrebbe cancellare il tabù della dipendenza dell’uomo dall’Altro. Il suo fantasma è partenogenetico, esclude ogni fecondazione dell’Altro. Il suo disegno è quello dell’auto-costituzione, dell’auto-fondazione, dell’auto-realizzazione. Mai nessun tempo come il nostro ha esaltato a dismisura la figura di Narciso come emblema di un soggetto che basta a se stesso, indipendente, autonomo. È una patologia non solo individuale.
Narciso può, come nel mito di Ovidio, innamorarsi solo di ciò che gli assomiglia, solo della propria immagine ideale; egli non conosce l’alterità, non conosce l’amore come esposizione assoluta verso il dissimile. Il fantasma di autoconsistenza che governa la vita di Narciso ispira da capo a piedi il mito neo-liberale del “farsi un nome da sé”. Esso domina le nostre vite come una vera e propria forma pagana di idolatria. L’ideale seduttivo dell’auto-generazione vorrebbe negare ogni debito, ogni provenienza dall’Altro nutrendo la credenza folle dell’Io che basta a se stesso.
Tuttavia, il mito di Narciso non si limita a mostrare la potenza seduttiva dell’illusione di farsi un nome da sé, ma ne evidenzia anche il rischio mortale. Narciso vorrebbe cancellare la distanza che lo separa da se stesso, reintegrare il suo doppio che vede riflesso, negare quella divisione che attraversa tutti noi impedendoci di credere troppo al nostro Io. Nessuno di noi, infatti — salvo i grandi paranoici — può pensare di coincidere perfettamente con l’Io che crede di essere.
Nel tentativo di realizzare questa coincidenza, Narciso perde la sua vita. Per questa ragione Lacan ha messo in evidenza il carattere profondamente suicidario del narcisismo umano: idolatrando la propria immagine, perseguendo il sogno onnipotente di cancellare l’alterità, il sogno di Narciso naufraga nell’abisso oscuro delle acque. Credere di essere un Io è, infatti, la malattia umana per eccellenza, la follia più grande, la forma più subdola e pericolosa di idolatria.
Se la modernità ha segnato il tempo della giusta emancipazione dell’Io dagli oscurantismi irrazionali della superstizione, se la voce di Kant ha definito la stagione dei lumi come l’uscita necessaria dell’uomo dal suo stato di minorità, l’epoca ipermoderna, quella in cui viviamo, non ha forse trasformato l’Io stesso in un nuovo idolo pagano, altrettanto superstizioso di quelli che la ragione critica dell’illuminismo ha smascherato nella loro impostura? Bisognerebbe forse rileggere in questa luce un testo di immutata attualità com’è la Dialettica dell’illuminismo di Adorno e Horkheimer per cogliere sino in fondo la portata di questo ribaltamento epocale: l’Io si emancipa dalle ombre della superstizione religiosa per trasformarsi esso stesso in un’ombra altrettanto inquietante.
Massimo Recalcati
Lacan lo diceva a suo modo: il problema non è più quello di distinguere la preda dall’ombra, di emanciparsi dall’ombra, ma di essere tutti noi prede della nostra stessa ombra. Narciso è l’ombra spessa di cui l’uomo ipermoderno è preda. La sua passione furiosa, la sua superbia capricciosa, vorrebbe annullare lo scarto che lo separa da se stesso negando ogni forma di dipendenza dall’Altro. Questa è la sua follia mortale che il nostro tempo ha elevato ad una sorta di nuovo comandamento sociale.
Senza dimenticare però che le forme forse più nocive del narcisismo sono quelle passive, della falsa umiltà, del rigetto dell’ambizione, della vita schiva, ma avvelenata. Si tratta, in realtà, solo del retro di una stessa medaglia: lo sguardo torvo del risentito — scolpito magistralmente da Nietzsche ne La genealogia della morale — odia la vita capace di realizzarsi invocando l’umiltà e il nascondimento solo come segni grigi della sua impotenza rabbiosa. In essa dimora più che mai lo spettro narcisistico che anima, al suo fondo, ogni forma di invidia umana.
La Repubblica – 17 gennaio 2016
↧
PER GRAMSCI
Ricorre oggi il 125 anniversario della nascita di Antonio Gramsci (22 gennaio 1891 - 27 aprile 1937). Noi l'abbiamo già ricordato la settimana scorsa a Marsala. Ma ci piace tornare a parlarne oggi con una sommaria sintesi di quanto detto sabato scorso.
A CIASCUNO IL SUO GRAMSCI
Francesco Virga
Dopo circa vent’anni di oblio, in Italia si torna a parlare e a scrivere su Antonio Gramsci.
Da un lato ci sarebbe da rallegrarsi perchè il silenzio è cessato. Dall’altro, se si entra nel merito, viene da piangere. Da ultimo persino uno scrittore che stimo, come Roberto Saviano, ha dato il suo contributo a questo gioco al massacro. Non parliamo poi di chi ricerca ancora Quaderni e manoscritti che non esistono, come se quelli esistenti non fossero sufficienti a definire un pensiero chiaro e limpido che niente e nessuno potrà mai oscurare.
Da un lato ci sarebbe da rallegrarsi perchè il silenzio è cessato. Dall’altro, se si entra nel merito, viene da piangere. Da ultimo persino uno scrittore che stimo, come Roberto Saviano, ha dato il suo contributo a questo gioco al massacro. Non parliamo poi di chi ricerca ancora Quaderni e manoscritti che non esistono, come se quelli esistenti non fossero sufficienti a definire un pensiero chiaro e limpido che niente e nessuno potrà mai oscurare.
Ho sempre considerato Gramsci un classico del 900. E mi vado sempre più convincendo che i classici sono i migliori antidoti nei confronti delle mode culturali. Cosicchè mentre queste ultime risultano ogni giorno più effimere, i primi durano e resistono al tempo anche quando sono investiti da pretestuose polemiche.
“Dire la verità è rivoluzionario”: in questo motto, che campeggiava nella testata di una delle riviste da lui create (L’Ordine Nuovo. Rassegna settimanale di cultura socialista), si potrebbe riassumere il complesso pensiero e la breve vita di Antonio Gramsci (1891-1937).
Fin da giovane, aveva mostrato di prediligere la verità su tutto. Basti rileggere gli articoli scritti negli anni della prima guerra mondiale. In uno, in particolare, credo che si trovi la chiave per comprenderli tutti:
“Noi siamo persuasi che i fatti dovevano rimanere tali anche in tempo di guerra, e che la storia e la cultura sono cose troppo da rispettare perché possano essere deformate e piegate dalle contingenti necessità del momento. La verità deve essere rispettata sempre, qualsiasi conseguenza essa possa apportare, e le proprie convinzioni, se sono fede viva, devono trovare in se stesse, nella propria logica, la giustificazione degli atti che si ritiene necessario siano compiuti. Sulla bugia, sulla falsificazione facilona non si costruiscono che castelli di vento,che altre bugie e altre falsificazioni possono far svanire.” ( La conferenza e la verità, in L’Avanti torinese del 19/2/1916, ora nel volume “ Sotto la Mole”, Einaudi 1960,p.43)
Queste affermazioni non sono l’ingenua manifestazione del pensiero di un giovane idealista. L’amore per la verità contrassegna l’intera opera gramsciana e ne costituisce uno dei suoi leit-motiv. Lo stesso scontro con Togliatti nel 1926 avverrà proprio su questo terreno. Infatti non condividendo le ragioni che spinsero quest’ultimo a censurare le sue critiche a Stalin, con spirito profetico, arriverà a predire il “suicidio” della rivoluzione d’ottobre. Gramsci, a differenza di Togliatti, non accetterà mai la necessità di sacrificare la verità sull’altare della rivoluzione. Basta rileggere le Letteree i Quaderni del carcere per convincersene:
“Io sono sempre stato dell’opinione che la verità abbia in sé la propria medicina”. ( L., p.783)
“Non bisogna concepire la discussione scientifica come un processo giudiziario, in cui c’è un imputato e un procuratore che, per obbligo d’ufficio deve dimostrare che l’imputato è colpevole e degno di essere tolto dalla circolazione. Nella discussione scientifica, poiché si suppone che l’interesse sia la ricerca della verità (…), si dimostra più avanzato chi si pone dal punto di vista che l’avversario può esprimere un’esigenza che deve essere incorporata(…) nella propria costruzione. Comprendere e valutare realisticamente la posizione e le ragioni dell’avversario(…) significa appunto essersi liberato dalla prigione delle ideologie ( nel senso deteriore di cieco fanatismo ideologico), cioè porsi da un punto di vista critico.” (Q, 1933)
“E’opinione molto diffusa (…) che sia essenziale dell’arte politica il mentire, ilsaper astutamente nascondere le proprie vere opinioni, i veri fini a cui si tende, il saper far credere il contrario di ciò che realmente si vuole, ecc. ecc. L’opinione è tanto radicata e diffusa che a dire la verità non si è creduti(…) nella politica di massa dire la verità è una necessità politica.” (Q.p. 222).
Quest’ultima nota, in particolare, per essere compresa in tutto il suo valore, va collegata alla sua concezione non elitaria della politica e di ogni attività intellettuale. Per Gramsci, infatti, la politica non doveva essere riservata agli addetti ai lavori. Dal suo punto di vista - così come “tutti gli uomini sono filosofi perché tutti pensano”- tutti possono e devono occuparsi di politica; tanto più se si crede nella possibilità di superare la secolare divisione del genere umano tra dirigenti e diretti.
In uno dei passi meno citati e frequentati dei Quaderni si trova scritto:
“Bisogna proprio dire che i primi ad essere dimenticati sono proprio i primi elementi, le cose più elementari (…) Primo elemento è che esistono davvero governati e governanti, dirigenti e diretti. Tutta la scienzae l’arte politica si basano su questo fatto (…) Nel formare i dirigenti è fondamentale la premessa: si vuole che ci siano sempre governati e governanti,oppure si vogliono creare le condizioni in cui la necessità dell’esistenza di questa divisione sparisca? Cioè si parte dalla premessa della perpetua divisione del genere umano o si crede che essa sia solo un fatto storico rispondente a certe condizioni? (…) per certi partiti è vero il paradosso che essi sono compiuti e formati quando non esistono più, cioè quando la loro esistenza è diventata storicamente inutile. Così, poichè ogni partito non è che una nomenclatura di classe, è evidente che per il partito che si propone di annullare le divisioni in classi, la sua perfezione e compiutezza consiste nel non esistere più.” (Q. pp.1752-1753)
Rileggendo oggi questo brano, scritto in carcere nel 1933, si comprende meglio perché la memoria di Gramsci è stata rimossa dall’orizzonte politico dell’Italia odierna. Con un ceto politico sempre più autoreferenziale e irresponsabile, interessato soltanto a difendere le proprie rendite di posizione, a prima vista sembra che non possa esserci più spazio per l’utopia gramsciana. D’altra parte è comprensibile il silenzio della “Casta” di fronte ad un Autore rivelatosi profetico in più di una circostanza. E’ molto più comodo per tutti oscurarlo e/o ricordarlo soltanto in modo rituale. Invece per me, pur riconoscendo che su alcuni punti è necessario andare oltre Gramsci, rimane valido il suo metodo di approccio critico e mai dogmatico ai problemi. E molte sue pagine mi appaiono ancora oggi di straordinaria attualità. Si rilegga,ad esempio, “La favola del castoro”, dedicata all’analisi dei dirigenti socialisti italiani del primo dopoguerra che, con la loro inettitudine, aprirono le porte al fascismo.
Sicuramente“la scissione tra i programmi sonori e i fatti miserabili” oggi è maggiore di ieri; per non parlaredel “distacco tra rappresentati e rappresentanti” e “la nessuna unione con la classe rappresentata” da parte di quella che oggi, non a caso, viene definita una “casta”.
francesco virga
francesco virga
↧
GRAMSCI IN LINGUA INGLESE

Per gli amici inglesi e americani:
Gramsci and Us
On this day in 1891 one of the most influential Marxists of the 21st Century, Antonio Gramsci, was born in the small town of Ales in Sardinia. Gramsci's work transformed how we think about a Marxist politics. Whereas the Russian Revolution occured in the "backward" Russia, and as such was as much a revolution against the "old regime" as against capital, Gramsci attempted to wrestle with the question of how we build a revolutionary movement in the developed areas of Western Europe. In particular it was his development of the concept of "hegemony" which was to prove the most influential. In this piece, from the great Stuart Hall and published in The Hard Road to Renewal, Hall attempts to expand these insights of Gramsci's to analyse the "regressive modernisation" of Thatcher. In an age where many are tackling the question of how to build a new left modernity, Gramsci and Hall are as relevant as ever.
![]()
This is not a comprehensive exposition of the ideas of Antonio Gramsci, nor a systematic account of the political situation in Britain today. It is an attempt to 'think aloud' about some of the perplexing dilemmas facing the Left, in the light of - from the perspective of - Gramsci's work. I do not claim that, in any simple way, Gramsci 'has the answers' or 'holds the key' to our present troubles. I do believe that we must 'think' our problems in a Gramscian way - which is different. We mustn't use Gramsci (as we have for so long abused Marx) like an Old Testament prophet who, at the correct moment, will offer us the consoling and appropriate quotation. We can't pluck up this 'Sardinian' from his specific and unique political formation, beam him down at the end of the 20th century, and ask him to solve our problems for us: especially since the whole thrust of his thinking was to refuse this easy transfer of generalisations from one conjuncture, nation or epoch to another.
The thing about Gramsci that really transformed my own way of thinking about politics is the question which arises from his Prison Notebooks. If you look at the classic texts of Marx and Lenin, you are led to expect a revolutionary epochal historical development emerging from the end of the First World War onwards. And indeed events did give considerable evidence that such a development was occurring. Gramsci belongs to this 'proletarian moment'. It occurred in Turin in the 1920s, and other places where people like Gramsci, in touch with the advance guard of the industrial working class — then at the very forefront of modern production — thought that, if only the managers and politicians would get out of the way, this class of proletarians could run the world, take over the factories, seize the whole machinery of society, materially transform it and manage it, economically, socially, culturally, technically. The truth about the 1920s is that the 'proletarian moment' very nearly came off. Just before and after the First World War, it really was touch and go as to whether, under the leadership of such a class, the world might not have been transformed - as Russia was in 1917 by the Soviet revolution. This was the moment of the proletarian perspective on history. What I have called Gramsci's question' in the Notebooks emerges in the aftermath of that moment, with the recognition that history was not going to go that way, especially in the advanced industrial capitalist societies of Western Europe. Gramsci had to confront the turning back, the failure, of that moment: the fact that such a moment, having passed, would never return in its old form. Gramsci, here, came face to face with the revolutionary character of history itself. When a conjuncture unrolls, there is no 'going back'. History shifts gears. The terrain changes. You are in a new moment. You have to attend, 'violently', with all the 'pessimism of the intellect' at your command, to the 'discipline of the conjuncture'.
In addition (and this is one of the main reasons why his thought is so pertinent to us today) he had to face the capacity of the Right - specifically, of European fascism - to hegemonise that defeat.
So here was a historic reversal of the revolutionary project, a new historical conjuncture, and a moment which the Right, rather than the Left, was able to dominate. This looks like a moment of total crisis for the Left, when all the reference points, the predictions, have been shot to bits. The political universe, as you have come to inhabit it, collapses.
I don't want to say that the Left in Britain is in exactly the same moment; but I do hope you recognise certain strikingly similar features, because it is the similarity between those two situations, that makes the question of the Prison Notebooks so seminal in helping us to understand what our condition is today. Gramsci gives us, not the tools with which to solve the puzzle, but the means with which to ask the right kinds of questions about the politics of the 1980s and 1990s. He does so by directing our attention unswervingly to what is specific and different about this moment. He always insists on this attention to difference. It's a lesson which the Left in Britain has yet to learn. We do tend to think that the Right is not only always with us, but is always exactly the same: the same people, with the same interests, thinking the same thoughts. We are living through the transformation of British Conservatism — its partial adaptation to the modern world, via the neo-liberal and monetarist 'revolutions'. Thatcherism has reconstructed Conservatism and the Conservative Party. The hard-faced, utilitarian, petty-bourgeois businessmen are now in charge, not the grouse-shooting, hunting and fishing classes. And yet, though those transformations are changing the political terrain of struggle before our very eyes, we think the differences don't have any real effect on anything. It still feels more 'left-wing' to say the old ruling-class politics goes on in the same old way.
Gramsci, on the other hand, knew that difference and specificity mattered. So, instead of asking 'what would Gramsci say about Thatcherism?' we should simply attend to this riveting of Gramsci to the notion of difference, to the specificity of a historical conjuncture: how different forces come together, conjuncturally, to create the new terrain, on which a different politics must form up. That is the intuition that Gramsci offers us about the nature of political life, from which we can take a lead.
I want to say what I think 'the lessons of Gramsci' are, in relation, first of all, to Thatcherism and the project of the New Right; and, second, in terms of the crisis of the Left. Here, I'm foregrounding only the sharp edge of what I understand by Thatcherism. I'm trying to address the opening, from the mid-1970s onwards, of a new political project on the Right. By a project, I don't mean (as Gramsci warned) a conspiracy. I mean the construction of a new agenda in British politics. Mrs Thatcher always aimed, not for a short electoral reversal, but for a long historical occupancy of power. That occupancy of power was not simply about commanding the apparatuses of the state. Indeed, the project was organised, in the early stages, in opposition to the state, which in the Thatcherite view had been deeply corrupted by the welfare state and by Keynesianism and had thus helped to 'corrupt' the British people. Thatcherism came into existence in contestation with the old Keynesian welfare state, with social democratic 'statism', which, in its view, had dominated the 1960s. Thatcherism's project was to transform the state in order to restructure society: to decentre, to displace, the whole post-war formation; to reverse the political culture which had formed the basis of the political settlement — the historic compromise between labour and capital — which had been in place from 1945 onwards.
The depth of the reversal aimed for was profound: a reversal of the ground-rules of that settlement, of the social alliances which underpinned it and the values which made it popular. I don't mean the attitudes and values of the people who write books. I mean the ideas of the people who simply, in ordinary everyday life, have to calculate how to survive, how to look after those who are closest to them.
That is what is meant by saying that Thatcherism aimed for a reversal in ordinary common sense. The 'common sense' of the English people had been constructed around the notion that the last war had erected a barrier between the bad old days of the 1930s and now: the welfare state had come to stay; we'd never go back to using the criterion of the market as a measure of people's needs, the needs of society. There would always have to be some additional, incremental, institutional force — the state, representing the general interest of society — to bring to bear against, to modify, the market. I'm perfectly well aware that socialism was not inaugurated in 1945. I'm talking about the taken-for-granted, popular base of welfare social democracy, which formed the real, concrete ground on which any socialism worth the name has to be built. Thatcherism was a project to engage, to contest, that project, and, wherever possible, to dismantle it, and to put something new in place. It entered the political field in an historic contest, not just for power, but for popular authority, for hegemony.
It is a project — this confuses the Left no end — which is, simultaneously, regressive and progressive. Regressive because, in certain crucial respects, it takes us backwards. You couldn't be going anywhere else but backwards to hold up before the British people, at the end of the 20th century, the idea that the best the future holds is for them to become, for a second time, 'Eminent Victorians'. It's deeply regressive, ancient and archaic.
But don't misunderstand it. It's also a project of 'modernisation'. It is a form of regressive modernisation. Because, at the same time, Thatcherism had its beady eye fixed on one of the most profound historical facts about the British social formation: that it never ever properly entered the era of modern bourgeois civilisation. It never made that transfer to modernity. It never institutionalised, in a proper sense, the civilisation and structures of advanced capitalism — what Gramsci called 'Fordism'. It never transformed its old industrial and political structures. It never became a second capitalist-industrial-revolution power, in the way that the US did, and, by another route, (the 'Prussian route), Germany and Japan did. Britain never undertook that deep transformation which, at the end of the 19th century, remade both capitalism and the working classes. Consequently, Mrs Thatcher knows that there is no serious political project in Britain today which is not also about constructing a politics and an image of what modernity would be like for our people. And Thatcherism, in its regressive way, drawing on the past, looking backwards to former glories rather than forwards to a new epoch, has inaugurated the project of reactionary modernisation.
There is nothing more crucial, in this respect, than Gramsci's recognition that every crisis is also a moment of reconstruction; that there is no destruction which is not, also, reconstruction; that, historically nothing is dismantled without also attempting to put something new in its place; that every form of power not only excludes but produces something. That is an entirely new conception of crisis and of power. When the Left talks about crisis, all we see is capitalism disintegrating, and us marching in and taking over. We don't understand that the disruption of the normal functioning of the old economic, social, cultural order, provides the opportunity to reorganise it in new ways, to restructure and refashion, to modernise and move ahead. If necessary, of course, at the cost of allowing vast numbers of people — in the North East, the North West, in Wales and Scotland, in the mining communities and the devastated industrial heartlands, in the inner cities and elsewhere - — to be consigned to the historical dustbin. That is the 'law' of capitalist modernisation: uneven development, organised disorganisation.
Face to face with this dangerous new political formation, the temptation is always, ideologically, to dismantle it, to force it to stand still, by asking the classic Marxist question: who does it really represent? Now, usually when the Left asks that old classic Marxist question in the old way, we are not really asking a question, we are making a statement. We already know the answer. Of course, the Right represents the occupancy, by capital, of the state, which is nothing but its instrument. Bourgeois writers produce bourgeois novels. The Conservative Party is the ruling class at prayer. Etc, etc ... This is Marxism as a theory of the obvious. The question delivers no new knowledge, only the answer we already knew. It's a kind of game, political theory as a Trivial Pursuit. In fact, the reason we need to ask the question is because we really don't know.
It really is puzzling to say, in any simple way, whom Thatcherism represents. Here is the perplexing phenomenon of a petty-bourgeois ideology which 'represents', and is helping to reconstruct, both national and international capital. In the course of 'representing' corporate capital, however, it wins the consent of very substantial sections of the subordinate and dominated classes. What is the nature of this ideology which can inscribe such a vast range of different positions and interests in it, and which seems to represent a little bit of everybody — including most of the readers of this essay! For, make no mistake, a tiny bit of all of us is also somewhere inside the Thatcherite project. Of course, we're all one hundred per cent committed. But every now and then — Saturday mornings, perhaps, just before the demonstration — we go to Sainsbury's and we're just a tiny bit of a Thatcherite subject. How do we make sense of an ideology which is not coherent, which speaks now, in one ear, with the voice of free-wheeling, utilitarian, market-man, and in the other ear, with the voice of respectable, bourgeois, patriarchal man? How do these two repertoires operate together? We are all perplexed by the contradictory nature of Thatcherism. In our intellectual way, we think that the world will collapse as the result of a logical contradiction: this is the illusion of the intellectual - that ideology must be coherent, every bit of it fitting together, like a philosophical investigation. When, in fact, the whole purpose of what Gramsci called an organic (i.e. historically effective) ideology is that it articulates into a configuration different subjects, different identities, different projects, different aspirations. It does not reflect, it constructs a 'unity' out of difference.
We've been in the grasp of the Thatcherite project, not since 1983 or 1979, as official doctrine has it, but since 1975. 1975 is the climacteric in British politics. First of all, the oil hike. Secondly, the onset of the capitalist crisis. Thirdly, the transformation of modern Conservatism by the accession of the Thatcherite leadership. That is the moment of reversal when, as Gramsci argued, national and international factors came together. It doesn't begin with Mrs Thatcher's electoral victory, as politics is not a matter of elections alone. It lands in 1975, right in the middle of Mr Callaghan's political solar plexus. It breaks Mr Callaghan — already a broken reed — in two. One half remains avuncular, paternalist, socially-conservative. The other half dances to a new tune. One of the siren voices, singing the new song in his ear, is his son-in-law, Peter Jay, one of the architects of monetarism, in his missionary role as economic editor at The Times. He first saw the new market forces, the new sovereign consumer, coming over the hill like the marines. And, hearkening to these intimations of the future, the old man opens his mouth; and what does he say? The kissing has to stop. The game is over. Social democracy is finished. The welfare state is gone forever. We can't afford it. We've been paying ourselves too much, giving ourselves a lot of phoney jobs, having too much of a swinging time.
You can just see the English psyche collapsing under the weight of the illicit pleasures it has been enjoying — the permissiveness, the consumption, the goodies. It's all false; tinsel and froth. The Arabs have blown it all away. And now we have got to advance in a different way. Mrs Thatcher speaks to this 'new course'. She speaks to something else, deep in the English psyche: its masochism. The need which the English seem to have to be ticked off by Nanny and sent to bed without a pudding. The calculus by which every good summer has to be paid for by twenty bad winters. The Dunkirk Spirit — the worse off we are, the better we behave. She didn't promise us the give-away society. She said, iron times; back to the wall; stiff upper lip; get moving; get to work; dig in. Stick by the old, tried verities, the wisdom of 'Old England'. The family has kept society together; live by it. Send the women back to the hearth. Get the men out on to the Northwest Frontier. Hard times — followed, much later, by a return to the Good Old Days. She asked you for a long leash — not one, but two and three terms. By the end, she said, I will be able to redefine the nation in such a way that you will all, once again, for the first time, since the Empire started to go down the tube, feel what it is like to be part of Great Britain Unlimited. You will be able, once again, to send our boys 'over there', to fly the flag, to welcome back the fleet. Britain will be Great again. People don't vote for Thatcherism, in my view, because they believe the small print. People in their right minds do not think that Britain is now a wonderfully booming, successful economy. But Thatcherism, as an ideology, addresses the fears, the anxieties, the lost identities, of a people. It invites us to think about politics in images. It is addressed to our collective fantasies, to Britain as an imagined community, to the social imaginary. Mrs Thatcher has totally dominated that idiom, while the Left forlornly tries to drag the conversation round to 'our policies'.
This is a momentous historical project, the regressive modernisation of Britain. To win over ordinary people to that, not because they're dupes, or stupid, or because they are blinded by false consciousness. Since, in fact, the political character of our ideas cannot be guaranteed by our class position or by the 'mode of production', it is possible for the Right to construct a politics which does speak to people's experience, which does insert itself into what Gramsci called the necessarily fragmentary contradictory nature of common sense, which does resonate with some of their ordinary aspirations, and which, in certain circumstances, can recoup them as subordinate subjects, into a historical project which hegemonises what we used — erroneously — to think of as their necessary class interests. Gramsci is one of the first modern Marxists to recognise that interests are not given but have to be politically and ideologically constructed.
Gramsci warns us in the Notebooks that a crisis is not an immediate event but a process: it can last for a long time, and can be very differently resolved: by restoration, by reconstruction or by passive transformism. Sometimes more stable, sometimes more unstable; but in a profound sense, British institutions, the British economy, British society and culture have been in a deep social crisis for most of the 20th century.
Gramsci warns us that organic crises of this order erupt, not only in the political domain and the traditional areas of industrial and economic life, not simply in the class struggle, in the old sense; but in a wide series of polemics, debates about fundamental sexual, moral and intellectual questions, in a crisis in the relations of political representation and the parties — on a whole range of issues which do not necessarily, in the first instance, appear to be articulated with politics, in the narrow sense, at all. That is what Gramsci calls the crisis of authority, which is nothing but the crisis of hegemony or general crisis of the state. We are exactly in that moment. We have been shaping up to such a 'crisis of authority' in English social life and culture since the mid 1960s. In the 1960s, the crisis of English society was signalled in a number of debates and struggles around new points of antagonism, which appeared at first to be far removed from the traditional heartland of British politics. The Left often waited patiently for the old rhythms of the class struggle to be resumed, when in fact it was the forms of 'the class struggle' itself which were being transformed. We can only understand this diversification of social struggles in the light of Gramsci's insistence that, in modern societies, hegemony must be constructed, contested and won on many different sites, as the structures of the modern state and society complexify and the points of social antagonism proliferate.
So one of the most important things that Gramsci has done for us is to give us a profoundly expanded conception of what politics itself is like, and thus also of power and authority. We cannot, after Gramsci, go back to the notion of mistaking electoral politics, or party politics in a narrow sense, or even the occupancy of state power, as constituting the ground of modern politics itself. Gramsci understands that politics is a much expanded field; that, especially in societies of our kind, the sites on which power is constituted will be enormously varied. We are living through the proliferation of the sites of power and antagonism in modern society. The transition to this new phase is decisive for Gramsci. It puts directly on the political agenda the questions of moral and intellectual leadership, the educative and formative role of the state, the 'trenches and fortifications' of civil society, the crucial issue of the consent of the masses and the creation of a new type or level of civilisation, a new culture. It draws the decisive line between the formula of 'Permanent Revolution' and the formula of 'civil hegemony'. It is the cutting-edge between the war of movement and the war of position": the point where Gramsci's world meets ours.
That does not mean, as some people read Gramsci, that therefore the state doesn't matter any more. The state is clearly absolutely central in articulating the different areas of contestation, the different points of antagonism, into a regime of rule. The moment when you can get sufficient power in the state to organise a central political project is decisive, for then you can use the state to plan, urge, incite, solicit and punish, to conform the different sites of power and consent into a single regime. That is the moment of 'authoritarian populism'— Thatcherism simultaneously 'above' (in the state) and 'below' (out there with the people).
Even then, Mrs Thatcher does not make the mistake of thinking that the capitalist state has a single and unified political character. She is perfectly well aware that, though the capitalist state is articulated to securing the long-term, historical conditions for capital accumulation and profitability, though it is the guardian of a certain kind of bourgeois, patriarchal civilisation and culture, it is, and continues to be, an arena of contestation.
Does this mean that Thatcherism is, after all, simply the 'expression' of the ruling class? Of course Gramsci always gives a central place to the questions of class, class alliances, class struggle. Where Gramsci departs from classical versions of Marxism is that he does not think that politics is an arena which simply reflects already unified collective political identities, already constituted forms of struggle. Politics for him is not a dependent sphere. It is where forces and relations, in the economy, in society, in culture, have to be actively worked on to produce particular forms of power, forms of domination. This is the production of politics — politics as a production. This conception of politics is fundamentally contingent, fundamentally open-ended. There is no law of history which can predict what must inevitably be the outcome of a political struggle. Politics depends on the relations of forces at any particular moment. Revolution' and the formula of 'civil hegemony'. It is the cutting-edge between the war of movement and the war of position": the point where Gramsci's world meets ours.
That does not mean, as some people read Gramsci, that therefore the state doesn't matter any more. The state is clearly absolutely central in articulating the different areas of contestation, the different points of antagonism, into a regime of rule. The moment when you can get sufficient power in the state to organise a central political project is decisive, for then you can use the state to plan, urge, incite, solicit and punish, to conform the different sites of power and consent into a single regime. That is the moment of 'authoritarian populism' - Thatcherism simultaneously 'above' (in the state) and 'below' (out there with the people).
Even then, Mrs Thatcher does not make the mistake of thinking that the capitalist state has a single and unified political character. She is perfectly well aware that, though the capitalist state is articulated to securing the long-term, historical conditions for capital accumulation and profitability, though it is the guardian of a certain kind of bourgeois, patriarchal civilisation and culture, it is, and continues to be, an arena of contestation. Does this mean that Thatcherism is, after all, simply the 'expression' of the ruling class? Of course Gramsci always gives a central place to the questions of class, class alliances, class struggle. Where Gramsci departs from classical versions of Marxism is that he does not think that politics is an arena which simply reflects already unified collective political identities, already constituted forms of struggle. Politics for him is not a dependent sphere. It is where forces and relations, in the economy, in society, in culture, have to be actively worked on to produce particular forms of power, forms of domination. This is the production of politics - politics as a production. This conception of politics is fundamentally contingent, fundamentally open-ended. There is no law of history which can predict what must inevitably be the outcome of a political struggle. Politics depends on the relations of forces at any particular moment. History is not waiting in the wings to catch up your mistakes into another inevitable success. You lose because you lose because you lose.
The 'good sense' of the people exists, but it is just the beginning, not the end, of politics. It doesn't guarantee anything. Actually, he said, 'new conceptions have an extremely unstable position among the popular masses'. There is no unitary subject of history. The subject is necessarily divided, an ensemble: one half Stone Age, the other containing 'principles of advanced science, prejudices from all past phases of history, intuitions of a future philosophy. Both of those things struggle inside the heads and hearts of the people to find a way of articulating themselves politically. Of course, it is possible to recruit them to very different political projects.
Especially today, we live in an era when the old political identities are collapsing. We cannot imagine socialism coming about any longer through the image of that single, singular subject we used to call Socialist Man. Socialist Man, with one mind, one set of interests, one project, is dead. And good riddance. Who needs 'him' now, with his investment in a particular historical period, with 'his' particular sense of masculinity, shoring 'his' identity up in a particular set of familial relations, a particular kind of sexual identity? Who needs 'him' as the singular identity through which the great diversity of human beings and ethnic cultures in our world must enter the 21st century? This 'he' is dead: finished. Gramsci looked at a world which was complexifying in front of his eyes. He saw the pluralisation of modern cultural identities, emerging between the lines of uneven historical development, and asked the question: what are the political forms through which a new cultural order could be constructed, out of this 'multiplicity of dispersed wills, these heterogeneous aims'. Given that that is what people are really like, given that there is no law that will make socialism come true, can we find forms of organisation, forms of identity, forms of allegiance, social conceptions, which can both connect with popular life and, in the same moment, transform and renovate it? Socialism will not be delivered to us through the trapdoor of history by some deux ex machina.
Gramsci always insisted that hegemony is not exclusively an ideological phenomenon. There can be no hegemony without the decisive nucleus of the economic. On the other hand, do not fall into the trap of the old mechanical economism and believe that, if you can only get hold of the economy, you can move the rest of life. The nature of power in the modern world is that it is also constructed in relation to political, moral, intellectual, cultural, ideological, sexual questions. The question of hegemony is always the question of a new cultural order. The question which faced Gramsci in relation to Italy faces us now in relation to Britain: what is the nature of this new civilisation? Hegemony is not a state of grace which is installed forever. It's not a formation which incorporates everybody. The notion of a 'historical bloc' is precisely different from that of a pacified, homogeneous, ruling class.
It entails a quite different conception of how social forces and movements, in their diversity, can be articulated into a set of strategic alliances. To construct a new cultural order, you need not to reflect an already-formed collective will, but to fashion a new one, to inaugurate a new historic project.
I've been talking about Gramsci in the light of, in the aftermath of, Thatcherism: using Gramsci to comprehend the nature and depth of the challenge to the Left which Thatcherism and the new Right represent in English life and politics. But I have, at the same moment, inevitably also been talking about the Left. Or rather, I've not been talking about the Left, because the Left, in its organised, labourist form, does not seem to have the slightest conception of what putting together a new historical project entails. It does not understand the necessarily contradictory nature of human subjects, of social identities. It does not understand politics as a production. It does not see that it is possible to connect with the ordinary feelings and experience which people have in their everyday lives, and yet to articulate them progressively to a more advanced, modern form of social consciousness. It is not actively looking for and working upon the enormous diversity of social forces in our society. It doesn't see that it is in the very nature of modern capitalist civilisation to proliferate the centres of power, and thus to draw more and more areas of life into social antagonism. It does not recognise that the identities which people carry in their heads - their subjectivities, their cultural life, their sexual life, their family life, their ethnic identities, their health - have become massively politicised.
I simply don't think, for example, that the current Labour leadership understands that its political fate depends on whether or not it can construct a politics, in the next 20 years, which is able to address itself, not to one, but to a diversity of different points of antagonism in society; unifying them, in their differences, within a common project. I don't think they have grasped that Labour's capacity to grow as a political force depends absolutely on its capacity to draw from the popular energies of very different movements; movements outside the party which it did not — could not — set in play, and which it cannot therefore administer. It retains an entirely bureaucratic conception of politics. If the word doesn't proceed out of the mouths of the Labour leadership, there must be something subversive about it. If politics energises people to develop new demands, that is a sure sign that the natives are getting restless. You must expel or depose a few. You must get back to that fiction, the 'traditional Labour voter: to that pacified, Fabian notion of politics, where the masses hijack the experts into power, and then the experts do something for the masses: later ... much later. The hydraulic conception of politics.
That bureaucratic conception of politics has nothing to do with the mobilisation of a variety of popular forces. It doesn't have any conception of how people become empowered by doing something: first of all about their immediate troubles; then, the power expands their political capacities and ambitions, so that they begin to think again about what it might be like to rule the world ... Their politics has ceased to have a connection with this most modern of all resolutions — the deepening of democratic life.
Without the deepening of popular participation in national-cultural life, ordinary people don't have any experience of actually running anything. We need to re-acquire the notion that politics is about expanding popular capacities, the capacities of ordinary people. And in order to do so, socialism itself has to speak to the people whom it wants to empower, in words that belong to them as late 20th century ordinary folks.
You'll have noticed that I'm not talking about whether the Labour Party has got its policy on this or that issue right. I'm talking about a whole conception of politics: the capacity to grasp in our political imagination the huge historical choices in front of the British people, today. I'm talking about new conceptions of the nation itself: whether you believe Britain can advance into the next century with a conception of what it is like to be 'English' which has been entirely constituted out of Britain's long, disastrous imperialist march across the earth. If you really think that, you haven't grasped the profound cultural transformation required to remake the English. That kind of cultural transformation is precisely what socialism is about today.
Now a political party of the Left, however much it is centred on government, on winning elections, has, in my view, exactly this kind of decision before it. The reason why I'm not optimistic about the 'mass party of the working class' ever understanding the nature of the historical choice confronting it is precisely because I suspect Labour does secretly still believe that there's a little bit of lee-way left in the old, economic-corporate, incremental, Keynesian game. It does think it could go back to a little smidgeon of Keynesianism here, a little bit more of the welfare state there, a little bit of the old Fabian thing ... Actually, though I don't have a cataclysmic vision of the future, I honestly believe that that option is now closed. It's exhausted. Nobody-believes in it any more. Its material conditions have disappeared. The ordinary British people won't vote for it because they know in their bones life is not like that any more. What Thatcherism, in its radical way, poses is not what we can get back to but along which route are we to go forward? In front of us is the historic choice: capitulate to the Thatcherite future, or find another way of imagining.
Don't worry about Mrs Thatcher herself; she will retire to Dulwich. But there are lots more third, fourth and fifth generation Thatcherites, dry as dust, sound to a man, waiting to take her place. They are convinced that socialism is about to be obliterated forever. They think we are dinosaurs. They think we belong to another era. As socialism slowly declines, a new era will dawn and these new kinds of possessive men will be in charge of it. They dream about real cultural power. And Labour, in its softly-softly, don't-rock-the-boat, hoping-the-electionpolls-will-go-up way, actually has in front of it only the choice between becoming historically irrelevant or beginning to sketch out an entirely new form of civilisation.
I don't say socialism, lest the word is so familiar to you that you think I mean just putting the same old programme we all know about back on the rails. I am talking about a renewal of the whole socialist project in the context of modern social and cultural life. I mean shifting the relations of forces — not so that Utopia comes the day after the next general election, but so that the tendencies begin to run another way. Who needs a socialist Heaven where everybody agrees with everybody else, where everybody's exactly the same? God forbid. I mean a place where we can begin the historic quarrel about what a new kind of civilisation must be. Is it possible that the immense new material, cultural and technological capacities, which far outstrip Marx's wildest dreams, which are now actually in our hands, are going to be politically hegemonised for the reactionary modernisation of Thatcherism? Or can we seize on those means of history-making, of making new human subjects, and shove it in the direction of a new culture? That's the choice before the Left.
'One should stress', Gramsci wrote, 'the significance which, in the modern world, political parties have in the elaboration and diffusion of conceptions of the world, because essentially what they do is to work out the ethics and the politics corresponding to these conceptions and act as it were as their historical "laboratory".'
Stuart Hall / 22 January 2016
Testo tratto da: http://www.versobooks.com/blogs/2448-stuart-hall-gramsci-and-us

This is not a comprehensive exposition of the ideas of Antonio Gramsci, nor a systematic account of the political situation in Britain today. It is an attempt to 'think aloud' about some of the perplexing dilemmas facing the Left, in the light of - from the perspective of - Gramsci's work. I do not claim that, in any simple way, Gramsci 'has the answers' or 'holds the key' to our present troubles. I do believe that we must 'think' our problems in a Gramscian way - which is different. We mustn't use Gramsci (as we have for so long abused Marx) like an Old Testament prophet who, at the correct moment, will offer us the consoling and appropriate quotation. We can't pluck up this 'Sardinian' from his specific and unique political formation, beam him down at the end of the 20th century, and ask him to solve our problems for us: especially since the whole thrust of his thinking was to refuse this easy transfer of generalisations from one conjuncture, nation or epoch to another.
The thing about Gramsci that really transformed my own way of thinking about politics is the question which arises from his Prison Notebooks. If you look at the classic texts of Marx and Lenin, you are led to expect a revolutionary epochal historical development emerging from the end of the First World War onwards. And indeed events did give considerable evidence that such a development was occurring. Gramsci belongs to this 'proletarian moment'. It occurred in Turin in the 1920s, and other places where people like Gramsci, in touch with the advance guard of the industrial working class — then at the very forefront of modern production — thought that, if only the managers and politicians would get out of the way, this class of proletarians could run the world, take over the factories, seize the whole machinery of society, materially transform it and manage it, economically, socially, culturally, technically. The truth about the 1920s is that the 'proletarian moment' very nearly came off. Just before and after the First World War, it really was touch and go as to whether, under the leadership of such a class, the world might not have been transformed - as Russia was in 1917 by the Soviet revolution. This was the moment of the proletarian perspective on history. What I have called Gramsci's question' in the Notebooks emerges in the aftermath of that moment, with the recognition that history was not going to go that way, especially in the advanced industrial capitalist societies of Western Europe. Gramsci had to confront the turning back, the failure, of that moment: the fact that such a moment, having passed, would never return in its old form. Gramsci, here, came face to face with the revolutionary character of history itself. When a conjuncture unrolls, there is no 'going back'. History shifts gears. The terrain changes. You are in a new moment. You have to attend, 'violently', with all the 'pessimism of the intellect' at your command, to the 'discipline of the conjuncture'.
In addition (and this is one of the main reasons why his thought is so pertinent to us today) he had to face the capacity of the Right - specifically, of European fascism - to hegemonise that defeat.
So here was a historic reversal of the revolutionary project, a new historical conjuncture, and a moment which the Right, rather than the Left, was able to dominate. This looks like a moment of total crisis for the Left, when all the reference points, the predictions, have been shot to bits. The political universe, as you have come to inhabit it, collapses.
I don't want to say that the Left in Britain is in exactly the same moment; but I do hope you recognise certain strikingly similar features, because it is the similarity between those two situations, that makes the question of the Prison Notebooks so seminal in helping us to understand what our condition is today. Gramsci gives us, not the tools with which to solve the puzzle, but the means with which to ask the right kinds of questions about the politics of the 1980s and 1990s. He does so by directing our attention unswervingly to what is specific and different about this moment. He always insists on this attention to difference. It's a lesson which the Left in Britain has yet to learn. We do tend to think that the Right is not only always with us, but is always exactly the same: the same people, with the same interests, thinking the same thoughts. We are living through the transformation of British Conservatism — its partial adaptation to the modern world, via the neo-liberal and monetarist 'revolutions'. Thatcherism has reconstructed Conservatism and the Conservative Party. The hard-faced, utilitarian, petty-bourgeois businessmen are now in charge, not the grouse-shooting, hunting and fishing classes. And yet, though those transformations are changing the political terrain of struggle before our very eyes, we think the differences don't have any real effect on anything. It still feels more 'left-wing' to say the old ruling-class politics goes on in the same old way.
Gramsci, on the other hand, knew that difference and specificity mattered. So, instead of asking 'what would Gramsci say about Thatcherism?' we should simply attend to this riveting of Gramsci to the notion of difference, to the specificity of a historical conjuncture: how different forces come together, conjuncturally, to create the new terrain, on which a different politics must form up. That is the intuition that Gramsci offers us about the nature of political life, from which we can take a lead.
I want to say what I think 'the lessons of Gramsci' are, in relation, first of all, to Thatcherism and the project of the New Right; and, second, in terms of the crisis of the Left. Here, I'm foregrounding only the sharp edge of what I understand by Thatcherism. I'm trying to address the opening, from the mid-1970s onwards, of a new political project on the Right. By a project, I don't mean (as Gramsci warned) a conspiracy. I mean the construction of a new agenda in British politics. Mrs Thatcher always aimed, not for a short electoral reversal, but for a long historical occupancy of power. That occupancy of power was not simply about commanding the apparatuses of the state. Indeed, the project was organised, in the early stages, in opposition to the state, which in the Thatcherite view had been deeply corrupted by the welfare state and by Keynesianism and had thus helped to 'corrupt' the British people. Thatcherism came into existence in contestation with the old Keynesian welfare state, with social democratic 'statism', which, in its view, had dominated the 1960s. Thatcherism's project was to transform the state in order to restructure society: to decentre, to displace, the whole post-war formation; to reverse the political culture which had formed the basis of the political settlement — the historic compromise between labour and capital — which had been in place from 1945 onwards.
The depth of the reversal aimed for was profound: a reversal of the ground-rules of that settlement, of the social alliances which underpinned it and the values which made it popular. I don't mean the attitudes and values of the people who write books. I mean the ideas of the people who simply, in ordinary everyday life, have to calculate how to survive, how to look after those who are closest to them.
That is what is meant by saying that Thatcherism aimed for a reversal in ordinary common sense. The 'common sense' of the English people had been constructed around the notion that the last war had erected a barrier between the bad old days of the 1930s and now: the welfare state had come to stay; we'd never go back to using the criterion of the market as a measure of people's needs, the needs of society. There would always have to be some additional, incremental, institutional force — the state, representing the general interest of society — to bring to bear against, to modify, the market. I'm perfectly well aware that socialism was not inaugurated in 1945. I'm talking about the taken-for-granted, popular base of welfare social democracy, which formed the real, concrete ground on which any socialism worth the name has to be built. Thatcherism was a project to engage, to contest, that project, and, wherever possible, to dismantle it, and to put something new in place. It entered the political field in an historic contest, not just for power, but for popular authority, for hegemony.
It is a project — this confuses the Left no end — which is, simultaneously, regressive and progressive. Regressive because, in certain crucial respects, it takes us backwards. You couldn't be going anywhere else but backwards to hold up before the British people, at the end of the 20th century, the idea that the best the future holds is for them to become, for a second time, 'Eminent Victorians'. It's deeply regressive, ancient and archaic.
But don't misunderstand it. It's also a project of 'modernisation'. It is a form of regressive modernisation. Because, at the same time, Thatcherism had its beady eye fixed on one of the most profound historical facts about the British social formation: that it never ever properly entered the era of modern bourgeois civilisation. It never made that transfer to modernity. It never institutionalised, in a proper sense, the civilisation and structures of advanced capitalism — what Gramsci called 'Fordism'. It never transformed its old industrial and political structures. It never became a second capitalist-industrial-revolution power, in the way that the US did, and, by another route, (the 'Prussian route), Germany and Japan did. Britain never undertook that deep transformation which, at the end of the 19th century, remade both capitalism and the working classes. Consequently, Mrs Thatcher knows that there is no serious political project in Britain today which is not also about constructing a politics and an image of what modernity would be like for our people. And Thatcherism, in its regressive way, drawing on the past, looking backwards to former glories rather than forwards to a new epoch, has inaugurated the project of reactionary modernisation.
There is nothing more crucial, in this respect, than Gramsci's recognition that every crisis is also a moment of reconstruction; that there is no destruction which is not, also, reconstruction; that, historically nothing is dismantled without also attempting to put something new in its place; that every form of power not only excludes but produces something. That is an entirely new conception of crisis and of power. When the Left talks about crisis, all we see is capitalism disintegrating, and us marching in and taking over. We don't understand that the disruption of the normal functioning of the old economic, social, cultural order, provides the opportunity to reorganise it in new ways, to restructure and refashion, to modernise and move ahead. If necessary, of course, at the cost of allowing vast numbers of people — in the North East, the North West, in Wales and Scotland, in the mining communities and the devastated industrial heartlands, in the inner cities and elsewhere - — to be consigned to the historical dustbin. That is the 'law' of capitalist modernisation: uneven development, organised disorganisation.
Face to face with this dangerous new political formation, the temptation is always, ideologically, to dismantle it, to force it to stand still, by asking the classic Marxist question: who does it really represent? Now, usually when the Left asks that old classic Marxist question in the old way, we are not really asking a question, we are making a statement. We already know the answer. Of course, the Right represents the occupancy, by capital, of the state, which is nothing but its instrument. Bourgeois writers produce bourgeois novels. The Conservative Party is the ruling class at prayer. Etc, etc ... This is Marxism as a theory of the obvious. The question delivers no new knowledge, only the answer we already knew. It's a kind of game, political theory as a Trivial Pursuit. In fact, the reason we need to ask the question is because we really don't know.
It really is puzzling to say, in any simple way, whom Thatcherism represents. Here is the perplexing phenomenon of a petty-bourgeois ideology which 'represents', and is helping to reconstruct, both national and international capital. In the course of 'representing' corporate capital, however, it wins the consent of very substantial sections of the subordinate and dominated classes. What is the nature of this ideology which can inscribe such a vast range of different positions and interests in it, and which seems to represent a little bit of everybody — including most of the readers of this essay! For, make no mistake, a tiny bit of all of us is also somewhere inside the Thatcherite project. Of course, we're all one hundred per cent committed. But every now and then — Saturday mornings, perhaps, just before the demonstration — we go to Sainsbury's and we're just a tiny bit of a Thatcherite subject. How do we make sense of an ideology which is not coherent, which speaks now, in one ear, with the voice of free-wheeling, utilitarian, market-man, and in the other ear, with the voice of respectable, bourgeois, patriarchal man? How do these two repertoires operate together? We are all perplexed by the contradictory nature of Thatcherism. In our intellectual way, we think that the world will collapse as the result of a logical contradiction: this is the illusion of the intellectual - that ideology must be coherent, every bit of it fitting together, like a philosophical investigation. When, in fact, the whole purpose of what Gramsci called an organic (i.e. historically effective) ideology is that it articulates into a configuration different subjects, different identities, different projects, different aspirations. It does not reflect, it constructs a 'unity' out of difference.
We've been in the grasp of the Thatcherite project, not since 1983 or 1979, as official doctrine has it, but since 1975. 1975 is the climacteric in British politics. First of all, the oil hike. Secondly, the onset of the capitalist crisis. Thirdly, the transformation of modern Conservatism by the accession of the Thatcherite leadership. That is the moment of reversal when, as Gramsci argued, national and international factors came together. It doesn't begin with Mrs Thatcher's electoral victory, as politics is not a matter of elections alone. It lands in 1975, right in the middle of Mr Callaghan's political solar plexus. It breaks Mr Callaghan — already a broken reed — in two. One half remains avuncular, paternalist, socially-conservative. The other half dances to a new tune. One of the siren voices, singing the new song in his ear, is his son-in-law, Peter Jay, one of the architects of monetarism, in his missionary role as economic editor at The Times. He first saw the new market forces, the new sovereign consumer, coming over the hill like the marines. And, hearkening to these intimations of the future, the old man opens his mouth; and what does he say? The kissing has to stop. The game is over. Social democracy is finished. The welfare state is gone forever. We can't afford it. We've been paying ourselves too much, giving ourselves a lot of phoney jobs, having too much of a swinging time.
You can just see the English psyche collapsing under the weight of the illicit pleasures it has been enjoying — the permissiveness, the consumption, the goodies. It's all false; tinsel and froth. The Arabs have blown it all away. And now we have got to advance in a different way. Mrs Thatcher speaks to this 'new course'. She speaks to something else, deep in the English psyche: its masochism. The need which the English seem to have to be ticked off by Nanny and sent to bed without a pudding. The calculus by which every good summer has to be paid for by twenty bad winters. The Dunkirk Spirit — the worse off we are, the better we behave. She didn't promise us the give-away society. She said, iron times; back to the wall; stiff upper lip; get moving; get to work; dig in. Stick by the old, tried verities, the wisdom of 'Old England'. The family has kept society together; live by it. Send the women back to the hearth. Get the men out on to the Northwest Frontier. Hard times — followed, much later, by a return to the Good Old Days. She asked you for a long leash — not one, but two and three terms. By the end, she said, I will be able to redefine the nation in such a way that you will all, once again, for the first time, since the Empire started to go down the tube, feel what it is like to be part of Great Britain Unlimited. You will be able, once again, to send our boys 'over there', to fly the flag, to welcome back the fleet. Britain will be Great again. People don't vote for Thatcherism, in my view, because they believe the small print. People in their right minds do not think that Britain is now a wonderfully booming, successful economy. But Thatcherism, as an ideology, addresses the fears, the anxieties, the lost identities, of a people. It invites us to think about politics in images. It is addressed to our collective fantasies, to Britain as an imagined community, to the social imaginary. Mrs Thatcher has totally dominated that idiom, while the Left forlornly tries to drag the conversation round to 'our policies'.
This is a momentous historical project, the regressive modernisation of Britain. To win over ordinary people to that, not because they're dupes, or stupid, or because they are blinded by false consciousness. Since, in fact, the political character of our ideas cannot be guaranteed by our class position or by the 'mode of production', it is possible for the Right to construct a politics which does speak to people's experience, which does insert itself into what Gramsci called the necessarily fragmentary contradictory nature of common sense, which does resonate with some of their ordinary aspirations, and which, in certain circumstances, can recoup them as subordinate subjects, into a historical project which hegemonises what we used — erroneously — to think of as their necessary class interests. Gramsci is one of the first modern Marxists to recognise that interests are not given but have to be politically and ideologically constructed.
Gramsci warns us in the Notebooks that a crisis is not an immediate event but a process: it can last for a long time, and can be very differently resolved: by restoration, by reconstruction or by passive transformism. Sometimes more stable, sometimes more unstable; but in a profound sense, British institutions, the British economy, British society and culture have been in a deep social crisis for most of the 20th century.
Gramsci warns us that organic crises of this order erupt, not only in the political domain and the traditional areas of industrial and economic life, not simply in the class struggle, in the old sense; but in a wide series of polemics, debates about fundamental sexual, moral and intellectual questions, in a crisis in the relations of political representation and the parties — on a whole range of issues which do not necessarily, in the first instance, appear to be articulated with politics, in the narrow sense, at all. That is what Gramsci calls the crisis of authority, which is nothing but the crisis of hegemony or general crisis of the state. We are exactly in that moment. We have been shaping up to such a 'crisis of authority' in English social life and culture since the mid 1960s. In the 1960s, the crisis of English society was signalled in a number of debates and struggles around new points of antagonism, which appeared at first to be far removed from the traditional heartland of British politics. The Left often waited patiently for the old rhythms of the class struggle to be resumed, when in fact it was the forms of 'the class struggle' itself which were being transformed. We can only understand this diversification of social struggles in the light of Gramsci's insistence that, in modern societies, hegemony must be constructed, contested and won on many different sites, as the structures of the modern state and society complexify and the points of social antagonism proliferate.
So one of the most important things that Gramsci has done for us is to give us a profoundly expanded conception of what politics itself is like, and thus also of power and authority. We cannot, after Gramsci, go back to the notion of mistaking electoral politics, or party politics in a narrow sense, or even the occupancy of state power, as constituting the ground of modern politics itself. Gramsci understands that politics is a much expanded field; that, especially in societies of our kind, the sites on which power is constituted will be enormously varied. We are living through the proliferation of the sites of power and antagonism in modern society. The transition to this new phase is decisive for Gramsci. It puts directly on the political agenda the questions of moral and intellectual leadership, the educative and formative role of the state, the 'trenches and fortifications' of civil society, the crucial issue of the consent of the masses and the creation of a new type or level of civilisation, a new culture. It draws the decisive line between the formula of 'Permanent Revolution' and the formula of 'civil hegemony'. It is the cutting-edge between the war of movement and the war of position": the point where Gramsci's world meets ours.
That does not mean, as some people read Gramsci, that therefore the state doesn't matter any more. The state is clearly absolutely central in articulating the different areas of contestation, the different points of antagonism, into a regime of rule. The moment when you can get sufficient power in the state to organise a central political project is decisive, for then you can use the state to plan, urge, incite, solicit and punish, to conform the different sites of power and consent into a single regime. That is the moment of 'authoritarian populism'— Thatcherism simultaneously 'above' (in the state) and 'below' (out there with the people).
Even then, Mrs Thatcher does not make the mistake of thinking that the capitalist state has a single and unified political character. She is perfectly well aware that, though the capitalist state is articulated to securing the long-term, historical conditions for capital accumulation and profitability, though it is the guardian of a certain kind of bourgeois, patriarchal civilisation and culture, it is, and continues to be, an arena of contestation.
Does this mean that Thatcherism is, after all, simply the 'expression' of the ruling class? Of course Gramsci always gives a central place to the questions of class, class alliances, class struggle. Where Gramsci departs from classical versions of Marxism is that he does not think that politics is an arena which simply reflects already unified collective political identities, already constituted forms of struggle. Politics for him is not a dependent sphere. It is where forces and relations, in the economy, in society, in culture, have to be actively worked on to produce particular forms of power, forms of domination. This is the production of politics — politics as a production. This conception of politics is fundamentally contingent, fundamentally open-ended. There is no law of history which can predict what must inevitably be the outcome of a political struggle. Politics depends on the relations of forces at any particular moment. Revolution' and the formula of 'civil hegemony'. It is the cutting-edge between the war of movement and the war of position": the point where Gramsci's world meets ours.
That does not mean, as some people read Gramsci, that therefore the state doesn't matter any more. The state is clearly absolutely central in articulating the different areas of contestation, the different points of antagonism, into a regime of rule. The moment when you can get sufficient power in the state to organise a central political project is decisive, for then you can use the state to plan, urge, incite, solicit and punish, to conform the different sites of power and consent into a single regime. That is the moment of 'authoritarian populism' - Thatcherism simultaneously 'above' (in the state) and 'below' (out there with the people).
Even then, Mrs Thatcher does not make the mistake of thinking that the capitalist state has a single and unified political character. She is perfectly well aware that, though the capitalist state is articulated to securing the long-term, historical conditions for capital accumulation and profitability, though it is the guardian of a certain kind of bourgeois, patriarchal civilisation and culture, it is, and continues to be, an arena of contestation. Does this mean that Thatcherism is, after all, simply the 'expression' of the ruling class? Of course Gramsci always gives a central place to the questions of class, class alliances, class struggle. Where Gramsci departs from classical versions of Marxism is that he does not think that politics is an arena which simply reflects already unified collective political identities, already constituted forms of struggle. Politics for him is not a dependent sphere. It is where forces and relations, in the economy, in society, in culture, have to be actively worked on to produce particular forms of power, forms of domination. This is the production of politics - politics as a production. This conception of politics is fundamentally contingent, fundamentally open-ended. There is no law of history which can predict what must inevitably be the outcome of a political struggle. Politics depends on the relations of forces at any particular moment. History is not waiting in the wings to catch up your mistakes into another inevitable success. You lose because you lose because you lose.
The 'good sense' of the people exists, but it is just the beginning, not the end, of politics. It doesn't guarantee anything. Actually, he said, 'new conceptions have an extremely unstable position among the popular masses'. There is no unitary subject of history. The subject is necessarily divided, an ensemble: one half Stone Age, the other containing 'principles of advanced science, prejudices from all past phases of history, intuitions of a future philosophy. Both of those things struggle inside the heads and hearts of the people to find a way of articulating themselves politically. Of course, it is possible to recruit them to very different political projects.
Especially today, we live in an era when the old political identities are collapsing. We cannot imagine socialism coming about any longer through the image of that single, singular subject we used to call Socialist Man. Socialist Man, with one mind, one set of interests, one project, is dead. And good riddance. Who needs 'him' now, with his investment in a particular historical period, with 'his' particular sense of masculinity, shoring 'his' identity up in a particular set of familial relations, a particular kind of sexual identity? Who needs 'him' as the singular identity through which the great diversity of human beings and ethnic cultures in our world must enter the 21st century? This 'he' is dead: finished. Gramsci looked at a world which was complexifying in front of his eyes. He saw the pluralisation of modern cultural identities, emerging between the lines of uneven historical development, and asked the question: what are the political forms through which a new cultural order could be constructed, out of this 'multiplicity of dispersed wills, these heterogeneous aims'. Given that that is what people are really like, given that there is no law that will make socialism come true, can we find forms of organisation, forms of identity, forms of allegiance, social conceptions, which can both connect with popular life and, in the same moment, transform and renovate it? Socialism will not be delivered to us through the trapdoor of history by some deux ex machina.
Gramsci always insisted that hegemony is not exclusively an ideological phenomenon. There can be no hegemony without the decisive nucleus of the economic. On the other hand, do not fall into the trap of the old mechanical economism and believe that, if you can only get hold of the economy, you can move the rest of life. The nature of power in the modern world is that it is also constructed in relation to political, moral, intellectual, cultural, ideological, sexual questions. The question of hegemony is always the question of a new cultural order. The question which faced Gramsci in relation to Italy faces us now in relation to Britain: what is the nature of this new civilisation? Hegemony is not a state of grace which is installed forever. It's not a formation which incorporates everybody. The notion of a 'historical bloc' is precisely different from that of a pacified, homogeneous, ruling class.
It entails a quite different conception of how social forces and movements, in their diversity, can be articulated into a set of strategic alliances. To construct a new cultural order, you need not to reflect an already-formed collective will, but to fashion a new one, to inaugurate a new historic project.
I've been talking about Gramsci in the light of, in the aftermath of, Thatcherism: using Gramsci to comprehend the nature and depth of the challenge to the Left which Thatcherism and the new Right represent in English life and politics. But I have, at the same moment, inevitably also been talking about the Left. Or rather, I've not been talking about the Left, because the Left, in its organised, labourist form, does not seem to have the slightest conception of what putting together a new historical project entails. It does not understand the necessarily contradictory nature of human subjects, of social identities. It does not understand politics as a production. It does not see that it is possible to connect with the ordinary feelings and experience which people have in their everyday lives, and yet to articulate them progressively to a more advanced, modern form of social consciousness. It is not actively looking for and working upon the enormous diversity of social forces in our society. It doesn't see that it is in the very nature of modern capitalist civilisation to proliferate the centres of power, and thus to draw more and more areas of life into social antagonism. It does not recognise that the identities which people carry in their heads - their subjectivities, their cultural life, their sexual life, their family life, their ethnic identities, their health - have become massively politicised.
I simply don't think, for example, that the current Labour leadership understands that its political fate depends on whether or not it can construct a politics, in the next 20 years, which is able to address itself, not to one, but to a diversity of different points of antagonism in society; unifying them, in their differences, within a common project. I don't think they have grasped that Labour's capacity to grow as a political force depends absolutely on its capacity to draw from the popular energies of very different movements; movements outside the party which it did not — could not — set in play, and which it cannot therefore administer. It retains an entirely bureaucratic conception of politics. If the word doesn't proceed out of the mouths of the Labour leadership, there must be something subversive about it. If politics energises people to develop new demands, that is a sure sign that the natives are getting restless. You must expel or depose a few. You must get back to that fiction, the 'traditional Labour voter: to that pacified, Fabian notion of politics, where the masses hijack the experts into power, and then the experts do something for the masses: later ... much later. The hydraulic conception of politics.
That bureaucratic conception of politics has nothing to do with the mobilisation of a variety of popular forces. It doesn't have any conception of how people become empowered by doing something: first of all about their immediate troubles; then, the power expands their political capacities and ambitions, so that they begin to think again about what it might be like to rule the world ... Their politics has ceased to have a connection with this most modern of all resolutions — the deepening of democratic life.
Without the deepening of popular participation in national-cultural life, ordinary people don't have any experience of actually running anything. We need to re-acquire the notion that politics is about expanding popular capacities, the capacities of ordinary people. And in order to do so, socialism itself has to speak to the people whom it wants to empower, in words that belong to them as late 20th century ordinary folks.
You'll have noticed that I'm not talking about whether the Labour Party has got its policy on this or that issue right. I'm talking about a whole conception of politics: the capacity to grasp in our political imagination the huge historical choices in front of the British people, today. I'm talking about new conceptions of the nation itself: whether you believe Britain can advance into the next century with a conception of what it is like to be 'English' which has been entirely constituted out of Britain's long, disastrous imperialist march across the earth. If you really think that, you haven't grasped the profound cultural transformation required to remake the English. That kind of cultural transformation is precisely what socialism is about today.
Now a political party of the Left, however much it is centred on government, on winning elections, has, in my view, exactly this kind of decision before it. The reason why I'm not optimistic about the 'mass party of the working class' ever understanding the nature of the historical choice confronting it is precisely because I suspect Labour does secretly still believe that there's a little bit of lee-way left in the old, economic-corporate, incremental, Keynesian game. It does think it could go back to a little smidgeon of Keynesianism here, a little bit more of the welfare state there, a little bit of the old Fabian thing ... Actually, though I don't have a cataclysmic vision of the future, I honestly believe that that option is now closed. It's exhausted. Nobody-believes in it any more. Its material conditions have disappeared. The ordinary British people won't vote for it because they know in their bones life is not like that any more. What Thatcherism, in its radical way, poses is not what we can get back to but along which route are we to go forward? In front of us is the historic choice: capitulate to the Thatcherite future, or find another way of imagining.
Don't worry about Mrs Thatcher herself; she will retire to Dulwich. But there are lots more third, fourth and fifth generation Thatcherites, dry as dust, sound to a man, waiting to take her place. They are convinced that socialism is about to be obliterated forever. They think we are dinosaurs. They think we belong to another era. As socialism slowly declines, a new era will dawn and these new kinds of possessive men will be in charge of it. They dream about real cultural power. And Labour, in its softly-softly, don't-rock-the-boat, hoping-the-electionpolls-will-go-up way, actually has in front of it only the choice between becoming historically irrelevant or beginning to sketch out an entirely new form of civilisation.
I don't say socialism, lest the word is so familiar to you that you think I mean just putting the same old programme we all know about back on the rails. I am talking about a renewal of the whole socialist project in the context of modern social and cultural life. I mean shifting the relations of forces — not so that Utopia comes the day after the next general election, but so that the tendencies begin to run another way. Who needs a socialist Heaven where everybody agrees with everybody else, where everybody's exactly the same? God forbid. I mean a place where we can begin the historic quarrel about what a new kind of civilisation must be. Is it possible that the immense new material, cultural and technological capacities, which far outstrip Marx's wildest dreams, which are now actually in our hands, are going to be politically hegemonised for the reactionary modernisation of Thatcherism? Or can we seize on those means of history-making, of making new human subjects, and shove it in the direction of a new culture? That's the choice before the Left.
'One should stress', Gramsci wrote, 'the significance which, in the modern world, political parties have in the elaboration and diffusion of conceptions of the world, because essentially what they do is to work out the ethics and the politics corresponding to these conceptions and act as it were as their historical "laboratory".'
Stuart Hall / 22 January 2016
Testo tratto da: http://www.versobooks.com/blogs/2448-stuart-hall-gramsci-and-us
↧
UNA NUOVA STORIA DELLE CITTA' MARINARE
Porto di Genova nel 1481
Un percorso di letture storiche lungo i mari dei commerci. Gli intrecci tra est e ovest grazie alla presenza delle città marinare.
Marina Montesano
Genova, Pisa, Venezia, rotte per la civiltà
In coincidenza con la lotta per le investiture, che nella seconda metà dell’XI secolo pose spesso in dubbio la legittimità dei poteri vescovili, i ceti dirigenti cittadini, fra i quali emergeva sempre più la piccola feudalità che si era inurbata, ma che non per questo aveva abbandonato i suoi possessi extraurbani e le sue attitudini guerriere, acquistarono crescente coscienza di sé e del proprio ruolo nelle città.
Un nuovo sistema di governo cittadino si sviluppò proprio tra il XI e il XII secolo, in significativa coincidenza con la maturazione dello sviluppo economico e commerciale delle città occidentali, specie di quelle affacciate sul mare. E proprio il Mediterraneo è centrale per comprendere la precocità di alcune fra queste autonomie, che andavano di pari passo con una rinnovata forza espansiva: commerciale quanto militare. È il caso di Pisa e Genova, che già prima della fine dell’XI secolo avevano, tra le poche in Italia, un governo consolare.
Furono queste città (e poco dopo Venezia: inizialmente legata troppo strettamente a Bisanzio e timorosa di una concorrenza) a imporre, in concomitanza con la prima crociata, dei veri e propri itinerari che si snodavano su un asse est-ovest e viceversa, che univa i loro porti a Costantinopoli e alle colonie mercantili che avevano fondato tanto nell’impero bizantino quanto sulla costa siro-libano-palestinese, con l’appoggio dei principi crociati.
I molti conflitti che scaturirono nel XII-XIII secolo tra loro ebbero sovente origine da tensioni nate «oltremare». Ad esempio l’inimicizia tra Genova e Pisa, poi divenuta proverbiale, non sussisteva nell’XI secolo, quando le due città collaboravano per liberare il Tirreno dai corsari musulmani provenienti dall’Africa e dalle Baleari. Ma cominciò a configurarsi quando si trattò di stabilire quale fra le due avrebbe dovuto stabilire la sua egemonia sulle grandi isole di Corsica e di Sardegna; e continuò poi sia in Costantinopoli, sia in Acri e in Tiro (i due massimi porti del regno crociato), dove i quartieri veneziano, pisano e genovese erano contigui.
Un’idea del protocolonialismo
Fra le tre potenze, è stata Venezia a esercitare la parte del leone nel panorama storiografico: la sua longevità, la sua stessa urbanistica, così unica, l’hanno resa meglio nota e più studiata. Gli studi specialistici sulle due città del Tirreno non sono certo mancati, ma a latitare sono state piuttosto le opere di sintesi, in grado di comunicare ai lettori quadri generali senza rinunciare alla correttezza e all’aggiornamento dei metodi e dell’informazione. Vengono a colmare questo vuoto due libri agili, eppure molto ricchi: Antonio Musarra, Genova e il mare nel Medioevo (il Mulino, pp. 204, euro 14) e Michael Mitterauer – John Morrissey, Pisa nel Medioevo. Potenza sul mare e motore di cultura (Viella, pp. 300, euro 25).
Mitterauer e Morrissey strutturano il lavoro in tre parti ben definite: si inizia con l’ascesa di Pisa, si dedica la parte più ampia alla costruzione della rete commerciale e a quello che i due definiscono «protocolonialismo» (sulla linea inaugurata decenni fa dall’indimenticato Joshua Prawer), fino alla crisi del Duecento; l’ultima parte, come il titolo promette, è dedicato a Pisa come centro culturale, per il quale si prende a paradigma il capolavoro di Piazza dei Miracoli e il suo significato dal punto di vista artistico, nonché politico.
Liguri e mappe atlantiche
Antonio Musarra traccia un quadro più articolato della fortuna marittima dei genovesi sul mare; non ci si deve dimenticare infatti che anche Genova ha conosciuto una straordinaria longevità che cronologicamente va ben oltre la mera «età comunale». Si parte allora dalle prime attestazioni per giungere fino all’apparizione dei liguri sulle rotte atlantiche. Tuttavia, rispetto a opere simili, e anche rispetto al testo di Mitterauer e Morrissey, Musarra dedica spazio ai quadri istituzionali e di governo. Può sembrare ovvio, ma così non è: sino a ora la storiografia ha preso in considerazione la Genova sui mari o la Genova-città; il dialogo tra le due parti potrebbe dare, come sembra già mostrare questo libro, risultati interessanti.
Come abbiamo detto, la storia di Genova quale potenza imprenditoriale e marittima va ben oltre i limiti del Medioevo; lo spiega bene il catalogo Tutti i genovesi del mondo. La grande espansione commerciale (secoli XI-XVI), a cura di Giustina Olgiati (Brigati, pp. 204), che illustra una mostra appena tenutasi all’Archivio di Stato di Genova. La presenza genovese riguarda il Mediterraneo occidentale (dalle isole del Tirreno, al nord-Africa, alla Francia, alla Spagna), quello orientale (Bisanzio, il Mar Nero, il Vicino Oriente) e poi oltre: la Cina da una parte, l’Atlantico dall’altra. Senza trascurare la cartografia, i culti, e tutto ciò che viaggia insieme agli uomini e alle merci.
Se i confini della presenza genovese sono oceanici, è vero che il Mediterraneo resta centrale, anche culturalmente, per comprenderne l’esperienza. È vero inoltre che siamo abituati a parlare di rapporti intermediterranei soprattutto per certi temi e certe epoche. Ad esempio, è ancora largamente diffuso lo stereotipo che vuole la conquista ottomana del Mediterraneo orientale come spartiacque tra un prima florido e un poi problematico, mentre è vero il contrario: quella conquista avviò una nuova fase di rapporti a 360 gradi. È ciò che si evince molto bene da un’altra ottima uscita: Incontri di civiltà nel Mediterraneo. L’impero ottomano e l’Italia del Rinascimento. Storia, arte e architettura, a cura di Alireza Naser Eslami (Olschki, pp. 180 euro 25).
Pisa nel Medioevo
Un cocktail di culture
Si tratta di una raccolta di saggi che partono dall’incontro-scontro militare (Giovanni Ricci e Franco Cardini) e dai rapporti commerciali (Gabriella Airaldi) per dedicare poi un ampio spazio al fenomeno artistico latu sensu. Per questo è di grande aiuto la qualità delle immagini, molte, belle, inserite nel testo, che una volta tanto rendono giustizia alle meraviglie prodotte dall’incontro culturale tra Oriente da Occidente: bastino i tappeti turchi raffigurati nelle tele italiane del Rinascimento, di cui si occupa Giovanni Curatola, oppure le architetture genovesi e veneziane a Istanbul, illustrate da Aygül Agir: la torre (detta dei «genovesi») e le mura esterne a Galata; lo Han di Rüstem Pasha che ingloba la chiesa di San Michele, e poi tanti altri.
È una storia, quella degli incontri di civiltà nel Mediterraneo, che tutti questi libri ci invitano a scoprire nella storia; o, perché no, nelle molteplici attestazioni materiali (documentarie, artistiche, urbanistiche) che fortunatamente sono ancora sotto i nostri occhi. Purché le si voglia vedere, senza paraocchi e soprattutto senza farsi incantare dalle sirene dei fautori dello «scontro di civiltà».
Il Manifesto – 13 gennaio 2016
↧
↧
SULLA TESI DI LAUREA DI ANDREA ZANZOTTO
La Padova University Press ha da poco pubblicato, in edizione anastatica con un’ introduzione di Emanuele Zinato, la tesi di laurea di Andrea Zanzotto, L’arte di Grazia Deledda. La tesi è stata discussa il 30 ottobre 1942 – in pieno conflitto mondiale. Il relatore, Natale Busetto, era un docente dagli interessi storico-filologici molto tradizionali. Zanzotto invece critica duramente i crociani, coinvolge precocemente Freud, compara il caso italiano con modelli europei, si appassiona a temi che diverranno a lui cari, come perifericità e infanzia. Questa è l’introduzione di Emanuele Zinato
Tra periferie e modernità: il laureando Andrea Zanzotto
di Emanuele Zinato
I. Nei suoi anni universitari a Padova, alla fine dei quali nel 1942 redigerà questa sorprendente tesi di laurea, Andrea Zanzotto scopre Rimbaud, legge per la prima volta Hölderlin, lavora come supplente tra Valdobbiadene e Treviso e scrive alcune poesie “a macchina su minuscoli fogli di carta trasparente”. La bufera è nell’aria: tra l’entrata in guerra dell’Italia e il blindarsi della Fortezza Europa sotto gli stendardi del Reich.
Dell’attività di poeta, sempre reattiva nei confronti dei traumi storici e psichici, ci restano di quel periodo i quindici componimenti della plaquette A che valse? (Versi 1938-1942): nel pubblicarli presso l’editore Scheiwiller come una strenna per gli amici in trecento copie numerate, Zanzotto scelse nel 1970 un titolo leopardiano per dar voce alla dolorosa ironia con cui guardare alla propria giovinezza esistenziale e poetica. Il paesaggio era già “regressione dall’oggi”,[1] alla vigilia di un’apocalisse. Il mondo intero stava per dissolversi e l’insieme di scoppi o di revulsioni da quel momento in poi non sarebbe più cessato, nella discontinuità solo apparente fra Auschwitz e Hiroshima da un lato e le mutazioni antropologiche dall’altro.
In una tesi di laurea coraggiosamente dedicata a un contemporaneo (Deledda era morta da soli sei anni, nel 1936) ci attenderemmo di trovare gli incunaboli di Zanzotto critico, quello dei saggi raccolti in Fantasie di avvicinamento e in Aure e disincanti. Tuttavia, a una prima lettura, la distanza dall’oggetto, la modalità discorsivo-dimostrativa della scrittura, il ricorso alle categorie storico-letterarie e agli –ismi tradizionali oltre che il nome di Grazia Deledda, del tutto assente nelle successive letture di Zanzotto, sembrano marcare l’ estraneità di questo giovane laureando dal se stesso più maturo. Tanto che appare pertinente estendere a Il problema critico dell’arte di Grazia Deledda, suo primo esercizio di lettura, il quesito distanziante che l’autore rivolgeva nel 1970 ai propri primi versi scritti prima della catastrofe: a che valse?
Il genere “tesi di laurea”, come si sa, esige il confronto con la critica e la disamina del tragitto intellettuale e dei testi dell’autore considerato. In questo modo opera anche il laureando Zanzotto, con le categorie storiche ed estetiche del primo Novecento: dopo aver riscostruito la storia della ricezione e il “ mondo spirituale” dell’ autrice, nella parte centrale della tesi ne attraversa tutti i libri, non omettendo una serie di giudizi di valore. La partitura è dunque convenzionalmente cronologica: gli inizi, i primi romanzi del periodo veristico, il tragitto dal romanzo regionalistico al romanzo psicologico, la maturità.
Guardando meglio, tuttavia, ci si accorge di una serie di fenomeni assai promettenti, attivi nella lettura di tutti i testi deleddiani, forieri di futuro e riassumibili in tre punti: 1)la larghissima messe di riferimenti comparativi alla letteratura europea; 2)l’attenzione costante per la corporeità e per il sottosuolo della psiche; 3) la precoce presenza delle due stelle polari dell’infanzia e del paesaggio.
II. Per quanto riguarda il primo punto, su tutti i modelli stranieri prevalgono di gran lunga i francesi e i russi: gli eroi deleddiani, dominati da una colpa misteriosa, secondo Zanzotto agiscono in un universo che “ha un conto da saldare con Dio” e questo ne spiega il successo in terra di Francia là dove “il problema del male come originato dalla caduta era stato, da Pascal a Baudelaire, continuamente agitato” (p.9). Del resto, Zanzotto nota acutamente come il tema oscuro della colpa abbia – fin dalle opere giovanili di Deledda – un suo corrispettivo formale nella struttura narrativa con “l’impaludarsi dell’azione drammatica nella monotonia della realtà quotidiana (…) o addirittura nella mancanza di una conclusione”. Già nelle prime novelle deleddiane si rileva infatti una “realtà fluente, tagliata da un punto a un altro, quasi a caso; fatti che nell’accadere non presentano quel tessuto logico di cause e di effetti, come nel romanzo classico”: di modo che l’unità dell’opera sembra scaturire “da un ordine poetico-epico più che, appunto, logico.” (p. 12). Questo prevalere del caso sulla logica è un dato di grande rilievo narratologico, che oggi diremmo consustanziale o preparatorio alle poetiche del modernismo, messo in luce da Zanzotto un attimo prima di ridimensionarlo: poiché Deledda gli pare anche “lontanissima da coloro che portano alle massime espressioni queste forme d’arte e di visione della vita: un Proust o, con intenzioni anche critiche, Bontempelli, Huxley, Gide” (pp. 9-10). E se fra i grandi narratori russi, oltre a Tolstoj e a Gogol’, domina indiscussa in Deledda la presenza di Dostoevskij, anche quel modello è assunto prima per analogia e subito dopo per differenza: “manca ancora nella Deledda quanto di infernale, di torvo, di disumano si trova nell’opera del grande russo”. (p. 14)
Riguardo al secondo punto, cioè l’attenzione costante per il “sottosuolo” psichico e per il mondo delle pulsioni, nella lettura di Zanzotto Dostoevskij (non solo come “fonte” ma quale strumento interpretativo della potenza del desiderio, sempre all’opera nell’autrice sarda) si ibrida già, sia pure per negazione, con Freud.
Ella oscilla tra lo spiegare il fatto artistico come un “bisogno fisico” e invece il dargli quel sommo, autonomo valore che ha. (…) Così ancora in Cosima parlando di sé stessa; «Scrive per un bisogno fisico, come le altre adolescenti corrono per i viali dei giardini e vanno a un luogo loro proibito» oppure «scrivono fin da allora per un bisogno istintivo» .(…) E nella novella Magda (in La regina delle tenebre) dopo un intimo sconvolgimento di indole erotica, la protagonista «si sentì artista, sentì che racchiudeva nell’anima una potenza formidabile, il muto riflesso della natura e delle cose». Freud anticipato? No certo. È inutile volere da lei delle teorie sull’arte: queste sono le due esperienze personali candidamente riferiteci. Una prova in più questa della istintività dell’arte deleddiana: per lei l’arte era davvero una attività irriflessa. (p. 7)
Analogamente, la forza della passione che spinge l’eroe a trasgredire le regole della società, della famiglia e della tradizione, raffigurata così frequentemente dalla presenza simbolica del vento nei romanzi di Deledda[2], è descritta da Zanzotto per comparazione con il linguaggio dei grandi simbolisti europei:
Ella non ha mai la forza dei simbolisti francesi e fiamminghi che mediante opportuni accorgimenti s’inducono a vedere e sentire questa identità tra concreto ed astratto (Rimbaud: “Elle est retrouvée –quoi? L’ éternité- c’est le mère allé-avec le soleil”) ella si accontenta di denunciarci la cosa di bel principio tralasciando ogni preparazione. E su questa affermazione incongruente costruisce a volte la vicenda del romanzo. Ma bisognerà invece rispondere affermativamente alla seconda domanda, se ciò che la D. abbia creato un suo simbolismo che sia poesia. Ella ottiene un effetto chiaramente simbolico col presentarsi come già vedemmo in “Marianna Sirta” ed anche in “Canne al vento” i personaggi e le cose in un certo modo particolare in una certa luce per cui improvvisamente noi li vediamo come simboli, li sentiamo significazioni anche senza che ciò sia denunciato (p. 59).
L’acquisizione deleddiana “irriflessa” delle leggi psichiche del profondo, così come il confronto con gli scrittori europei, si articola insomma nei rilievi di Zanzotto in due momenti: prima per somiglianza e poi contrastivamente. Il movimento costante della tesi su Deledda si direbbe consista dunque in una sorta di stop and go: grazie al quale si riconosce alla narratrice sarda la forza disvelante e visionaria dei grandi scrittori che hanno fondato la coscienza della modernità (da Baudelaire a Rimbaud, da Dostoevskij a Proust) solo grazie alla funzione “salvacondotto” dell’attenuazione che ne limita la portata entro coordinate istintive, inconsapevoli, arretrate o provinciali.
III. La terza fra le costanti “promettenti” della tesi riguarda il paesaggio e l’infanzia, cioè due tra i nuclei tematici ossessivamente più presenti nell’intera scrittura di Zanzotto maturo. Significativamente in queste zone del suo elaborato, egli entra in polemica con Croce e con l’idea, diffusa nella critica crociana, che la lettura di un testo debba basarsi sulla distinzione del non estetico dall’autentica poesia di un autore:
Ci fu un tempo in cui ci si affannò a mostrare che il problema se la Deledda abbia o no interpretato la Sardegna ha ben poco a che vedere con la sua arte: infatti la descrizione della realtà sarda sarebbe problema interessante più per la geografia, la storia o la folkloristica che l’arte. Interprete massimo il Croce. (p. 14)
Per Zanzotto, invece, il dato concreto della perifericità insulare e del paesaggio specifico è figura indispensabile della scrittura deleddiana, valorizzata proprio in quanto capace di dar conto, più di ogni trattato etnografico, della vita periferica, materiale e simbolica, e della cultura sarda:
Verissimo tutto ciò: ma si deve riconoscere che prescindendo dalla ‘sardità’ dell’animo deleddiano, non si arriverà mai a capirne l’arte. D’altra parte poi non è vero affatto che la Sardegna si debba ‘conoscere’ solo attraverso la ‘storia’ e la ‘geografia’. Noi conosciamo l’essenza dell’italianità attraverso le opere dei grandi italiani, così la più vera e profonda manifestazione dell’anima sarda si avrà per l’appunto nell’arte della sarda Deledda. E non è proprio quest’anima sarda che noi cerchiamo di conoscere della Sardegna, come quella che ne ha creato la particolare forma di vita, di storia, di civiltà? Nessun trattato di storia o di folkloristica sarda mi farà capire la Sardegna come un romanzo della Deledda. Ma ciò naturalmente interesserebbe poco il crociano puro, che pretende di librarsi, nei suoi giudizi, al di sopra della storia e della realtà. (14)
L’ultima fase della scrittura di Deledda è altresì valorizzata per la comparsa di un genere ibrido come l’autobiografia che permette l’irruzione della tematica dell’infanzia. In questa zona conclusiva della tesi, in cui il giovane laureando (senza aver ancora ovviamente acquisito la nozione saussuriana del segno o la teoria lacaniana del significante) si concede le incursioni più originali, relative alla geologia della psiche umana e al suo intimo legame con il linguaggio, tema cardinale della scrittura di Zanzotto nei decenni avvenire.
Ma negli ultimi tempi ella comincia ad interessarsi di fanciulli e di animali, di esseri cioè che vivono al di qua di questo mondo profondamente umano.(…). Tutta questa letteratura infantile o infantileggiante che ama le cantilene, i balbettii, le espressioni falsamente candide o coreograficamente ingenue non deve esser confusa con altra di più solide basi anche se pure non del tutto scevra della stessa malattia. Non si può considerare del tutto decadente, per il solo fatto che analizza e rivive l’anima infantile. Letteratura non solo di bambini, dissi, ma anche di animali. Per questa forma ricordo i bellissimi racconti di Jack London o di Colette, le poesie per il proprio cane di Francis Jammes, il Peter Pan di Barrie e certi racconti della Lagerlof in cui vivono insieme fanciulli ed animali, Il libro della giungla di Kipling o il Cucciolo della Rawlings o perché no? Le avventure di Pinocchio. (p. 80)
Tirando le somme: la tesi di Zanzotto va contestualizzata e le esigenze dimostrative e consequenziali dell’elaborato determinano l’andamento piano e tradizionale dell’argomentazione, lontanissimo dal procedere, come in Fantasie di avvicinamento, per scavi o prospezioni, e per accumulo, a sbalzi-sussulti. Tuttavia, anche qui i testi indagati nella tesi sono portati a “galleggiare” nella doppiezza che li rende vivi. [3] Il moto di stop and go con il quale si riconosce alla narratrice sarda la forza visionaria dei moderni grazie al lasciapassare di sminuimenti e attenuazioni, ne costituisce un esempio sul piano della retorica discorsiva. Le stesse coordinate istintive, inconsapevoli, arretrate o provinciali che caratterizzerebbero nel bene e nel male la scrittura di Deledda a ben guardare sono percepite da Zanzotto come intimamente bifide e come veicoli di possibile identificazione. E questo probabilmente perché, in Deledda come sarà in Zanzotto, “la via verso la modernità è certo bloccata, ma bloccato risulta anche qualsiasi tentativo di ritorno indietro”.[4] Il paesaggio periferico e premoderno non costituisce dunque solo il polo positivo arcaico e mitico, fuori dal tempo delle mutazioni: le interconnessioni abbaglianti del circuito infanzia, inconscio, linguaggio, paesaggio, periferia, fatte le debite differenze, sono sia nel laureando che nell’oggetto del suo studio più simmetriche di quanto non appaia al primo sguardo.
Si può dunque, in conclusione, azzardare una risposta al quesito a che valse’? che abbiamo voluto lasciar aleggiare, in analogia con il titolo delle coeve poesie giovanili, intorno al senso odierno di una tesi ancora non consapevole dei traumi avvenire. Insomma, valse: perché il ventenne Zanzotto, nella tragedia che incombe su tutti i personaggi deleddiani misura già a suo modo, ricorrendo a Rimbaud e a Dostoevskij, a Freud e perfino a Wagner(p 49 e 58 ), l’esperienza ulcerante della modernità e il rapporto tra inconscio e storia[5].
Note
[1] Luigi Milone, Per una storia del linguaggio poetico di Andra Zanzotto in “Studi novecenteschi”, IV, nn. 8-9, 1974, p. 208.
[2] Stefano Brugnolo, Perché tira tanto vento nei romanzi di Grazia Deledda, in Grazia Deledda e la solitudine del segreto, Atti del Convegno nazionale di studi, Sassari, 10-12 ottobre 2007, a c. di Marco Manotta e A. M. Morace, Isre edizioni, Nuoro, 2010, p. . 53.
[3] Pier Vincenzo Mengaldo, Profili di critici del Novecento, Bollati Boringhieri, Torino, 1998, p. 71.
[4] Stefano Brugnolo, Perché tira tanto vento nei romanzi di Grazia Deledda, cit., p. 65.
[5] Franco Fortini, Zanzotto 2, in Breve secondo Novecento, in Id. Saggi ed epigrammi, a. c. di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2003, p. 1191
______________________________________________________________________
Documento ripreso | pubblicato il 22 gennaio 2016
______________________________________________________________________
Documento ripreso | pubblicato il 22 gennaio 2016
↧
CON IONESCO CONTRO OGNI FORMA DI FANATISMO
“In nome della religione, si tortura, si perseguita, si costruiscono pire. Sotto il manto delle ideologie, si massacra, si tortura e si uccide. In nome della giustizia si punisce. In nome dell'amore per il proprio Paese o per la propria razza si odiano altri Paesi, li si disprezza, li si massacra. In nome dell'uguaglianza e della fratellanza si sopprime e si tortura. Fini e mezzi non hanno nulla in comune, i mezzi vanno ben oltre i fini. Ideologie e religione, sono gli alibi dei malvagi.”
Eugène Ionesco
↧
UN RACCONTO SICILIANO DI DANILO DOLCI
La patata
di Danilo Dolci
Le mignatte[1] viene uno a venderle da Canicattí che le prende nelle fontane. Ma noi andiamo a comperarle a Palermo. Ne abbiamo mandate a pigliare un centinaio, perché non è che si attaccano tutte: muoiono tre o quattro al giorno, magari senza metterle. Si mettono dentro una bottiglia di vetro con l’acqua. Gli cambiamo l’acqua ogni mattina, specialmente come ora d’estate. C’è il vento caldo e muoiono le mignatte col caldo. Quando muoiono tutte, dopo due mesi, si manda a prendere l’altre. Cento lire l’una costano, e noi che andiamo maneggiando sangue, le affittiamo poi a centocinquanta lire l’una.
…Dipende dalle malattie. Bronchite, si mettono nelle spalle o nel petto, quando c’è il gruppo,[2] ai bambini, si attaccano e si gettano perché è malattia infettiva, è sangue avvelenato, non si possono attaccare più. Si possono mettere due volte, tre volte. Certe volte muore la mignatta quando il sangue è avvelenato, muore in un momento. Per la meningite in testa si attaccano dietro le orecchie; per una caduta alla gamba, al braccio, si possono attaccare lo stesso. Un colpo di sole: pure dietro le orecchie. Certo le mignatte sono meglio delle iniezioni, meglio di tutto. Pure per la polmonite e la bronchite ai bambini si mettono, magari nati in quella giornata, o da otto giorni. In questi paesi, Valledolmo, Alia, e in tutti i paesi, tutti vengono: avendo le malattie, vengono tutti, ricchi e poveri. In ogni paese siamo due o tre a fare questo lavoro, se il paese è piccolo; se no di più.
…La mignatta ci tira il sangue e ci passa. Sono belle. Quando la mignatta è gonfia, piena di sangue, si munge con le mani e ci va fuori tutto il sangue. La mignatta si ubriaca col vino pure, e getta sangue. Si mette qua per esempio il vino nel piatto, ci si mette il muso, e tutto il sangue che tira lo getta dentro nel vino. Poi la laviamo, dopo munta, e la mettiamo ancora nell’acqua fresca.
…Pure per il tifo si mettono dentro le orecchie. Ma queste si tagliano nel mezzo e si gettano, per metterle fuori uso. Per rompere la pelle, morsicano e poi tirano il sangue. Quando poi sono piene, cadono da sole; e subito appena si levano si mungono. Perché non si munge, il sangue si quaglia[3] dentro la pancia e muoiono: e il guadagno sta nell’adoperarle tante volte. Muoiono se non si mungono, e perché il sangue è male e perché fanno mala digestione che è troppo: diventano grosse che diventano boccettine, che tanto si fanno grosse che fa paura a mungerle; ce n’è chi a maneggiare quel sangue si sconcertano.
…Certe volte si mettono anche sei sette sanguette insieme. A uno che per il caldo gli stava venendo a meningite, ce ne abbiamo messo più di venti: è rimasto un po’ sordo, ma non gli è venuta la meningite. Dipende le malattie. Quando ci viene la paralisi, per levarci il sangue gagliardo, ce ne si mettono assai. Quando c’è l’aia per una pedata di una mula che trebbia, qualche calcio, ci si mette mignatte assai. Anche per la cardía al cuore.[4] Quando non c’è più mignatte chiamiamo il barbiere che ci buca il polso: pigliano la vena e il sangue dove piglia piglia, esce fuori con furia. Dal dottore vanno poco perché costa di più: invece al barbiere ci si dà una piccolezza, ci si dà cento lire o un regalo. Invece al dottore, cinquecento lire, mille lire una visita.
…Quando una donna ha partorito e ha febbre, ci si mette le mignatte nella pancia. Pure quando la donna ha il latte impietrato,[5] pure ci si mette sui seni le mignatte. Anche a parti delicate, e quando hanno vene uscite, emorroidi, pure ci si mettono. Anche per mali di denti. Sono cose ereditarie che la nonna insegna alla figlia. Una vede e si imparano che la nonna dice: − Si fa così, si fa così… − L’altro giorno una aveva caduto l’ombellico, e l’ho guarita: girando tre volte col dito l’ombellico, girando la persona per far girare tre volte l’ombellico.
…Sono capace pure di stagliare[6] i vermi. Si fanno i massaggi e si dice l’orazione:
Lune è santo
santo santò,
marte è santo
santo santò,
mercole è santo
santo santò,
giovedì è santo
santo santò,
venerdì è santo,
santo santò,
sabato è santo
santo santò.
La domenica di Pasqua
lu verme in terra casca.
Taglia la testa
taglia la cuda
lassala libera
la creatura.
santo santò,
marte è santo
santo santò,
mercole è santo
santo santò,
giovedì è santo
santo santò,
venerdì è santo,
santo santò,
sabato è santo
santo santò.
La domenica di Pasqua
lu verme in terra casca.
Taglia la testa
taglia la cuda
lassala libera
la creatura.
…E i vermi passano in un momento.
…Per il latte aggruppato:[7] quando una lava con l’acqua fredda, aggruppa il latte ai bambini, perché ci fa male il latte freddo ai bambini. Allora ci si dice:
…Per il latte aggruppato:[7] quando una lava con l’acqua fredda, aggruppa il latte ai bambini, perché ci fa male il latte freddo ai bambini. Allora ci si dice:
San Martino d’ognisarria
incontrai un uomo e una donna
aggruppate con gruppo di corda
e acqua media sciogli doglia
e vattene via. Io ti staglio
in nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
incontrai un uomo e una donna
aggruppate con gruppo di corda
e acqua media sciogli doglia
e vattene via. Io ti staglio
in nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
…
E si dice un credo al cuore di Gesù, che ne stagli questo male; e un Salve Regina alla Madonna d’Altomare, che ne staglia questo male: per tre volte. E subito ci passa e subito levano[8] di piangere. Delle volte vengono di notte, che gridano forte e ci si fa il massaggio dicendo le orazioni e ci passa subito.
…I dottori queste cose non le sanno e manco le credono. Quando viene la mietitura agli uomini il polso ci si fa gonfio, perché con la falce si sforzano e allora ci si fa il massaggio col grasso di volpe. Pure il malocchio[9] si fa passare: si mette il sale in testa e si dice le orazioni.
…La sera la famiglia ogni tanto si ferma in campagna nei pagliari.[10] Certi, nei pagliari, ci abitano tutto l’anno, come al feudo.[11] Turrumè, Túdia, Vicarietto, La Niculiddia, Berboncando, Susafa, Mattarieddu, Belice, Polizzello, tutte masserie di pagliari, tutti qui vicino nella provincia di Palermo.
…Poi ci sono i pagliari che uno per esempio ci ha una salma[12] di terra e non può avere i soldi di fare una casa in campagna, e si fa un pagliaro per starci. Gli uomini aiutano al padrone e le donne e i bambini cogliono spighe. L’anno scorso R. con la moglie si trovavano lontano che coglievano spighe, e i due bambini erano vicino al pagliaro. C’era una bottiglia di vetro nel pagliaro. Il sole era caldo e la bottiglia tanto era riscaldata dal sole che accese la paglia. La mamma come vide accendersi il pagliaro, accorse per andare a salvare il bambino. Mentre che la madre doveva prendere e riparare il bambino nel pagliaro si bruciò tutta la faccia e i capelli e tutte le braccia si bruciò; ci aveva delle robe dentro e si bruciarono tutte e restarono nudi. E il bambino c’è rimasto dentro, che il fuoco li mangiava e lei non ha potuto far niente e gridava fuori e piangeva e corsero tutti i campieri e il marito. E piangevamo anche noi. Ci hanno lasciato il figlio per le spighe. Poi c’è andata la legge, per le perizie, per constatare il fatto.
…I pagliari bruciano spesso e ci muore dentro qualcuno. Per esempio M., qualche anno fa, lavoravano in campagna. Mentre che lavoravano videro il tempo cattivo e si ricoverarono, due muli e una cavalla e due fratelli, Calogero e Rosolino. Passò una giovane che visto il tempo cattivo si voleva ritirare lì dentro e ci dissero che lì largo non ce n’era. Quello se ne andò, e si riparò in una casa vicina. Come si mise a piovere e tuonava e lampeggiava, quello si salvò la vita e vide svampare il pagliaio che si bruciava con i due fratelli e i tre animali. E corse per volerci dare aiuto, e come arrivò là vide che non si poteva dare aiuto che bruciava tutto, e lo venne a dichiarare in paese.
…I dottori queste cose non le sanno e manco le credono. Quando viene la mietitura agli uomini il polso ci si fa gonfio, perché con la falce si sforzano e allora ci si fa il massaggio col grasso di volpe. Pure il malocchio[9] si fa passare: si mette il sale in testa e si dice le orazioni.
…La sera la famiglia ogni tanto si ferma in campagna nei pagliari.[10] Certi, nei pagliari, ci abitano tutto l’anno, come al feudo.[11] Turrumè, Túdia, Vicarietto, La Niculiddia, Berboncando, Susafa, Mattarieddu, Belice, Polizzello, tutte masserie di pagliari, tutti qui vicino nella provincia di Palermo.
…Poi ci sono i pagliari che uno per esempio ci ha una salma[12] di terra e non può avere i soldi di fare una casa in campagna, e si fa un pagliaro per starci. Gli uomini aiutano al padrone e le donne e i bambini cogliono spighe. L’anno scorso R. con la moglie si trovavano lontano che coglievano spighe, e i due bambini erano vicino al pagliaro. C’era una bottiglia di vetro nel pagliaro. Il sole era caldo e la bottiglia tanto era riscaldata dal sole che accese la paglia. La mamma come vide accendersi il pagliaro, accorse per andare a salvare il bambino. Mentre che la madre doveva prendere e riparare il bambino nel pagliaro si bruciò tutta la faccia e i capelli e tutte le braccia si bruciò; ci aveva delle robe dentro e si bruciarono tutte e restarono nudi. E il bambino c’è rimasto dentro, che il fuoco li mangiava e lei non ha potuto far niente e gridava fuori e piangeva e corsero tutti i campieri e il marito. E piangevamo anche noi. Ci hanno lasciato il figlio per le spighe. Poi c’è andata la legge, per le perizie, per constatare il fatto.
…I pagliari bruciano spesso e ci muore dentro qualcuno. Per esempio M., qualche anno fa, lavoravano in campagna. Mentre che lavoravano videro il tempo cattivo e si ricoverarono, due muli e una cavalla e due fratelli, Calogero e Rosolino. Passò una giovane che visto il tempo cattivo si voleva ritirare lì dentro e ci dissero che lì largo non ce n’era. Quello se ne andò, e si riparò in una casa vicina. Come si mise a piovere e tuonava e lampeggiava, quello si salvò la vita e vide svampare il pagliaio che si bruciava con i due fratelli e i tre animali. E corse per volerci dare aiuto, e come arrivò là vide che non si poteva dare aiuto che bruciava tutto, e lo venne a dichiarare in paese.
♦
[1] La mignatta o sanguisuga (Hirūdo Medicinālis) è un animaletto vermiforme che vive nelle acque stagnanti. Usato in medicina, molto più nel passato che ne presente, per succhiare il sangue degli animali domestici e dell’uomo, in determinate forme di malattia.
[2] «Grup« o «crup»: laringite.
[3] Si rapprende.
[4] Vi sono espressioni in questo discorso che sarebbe inutile cercare di spiegare con termini razionali, perché di fatto non significano nulla. Come quella della «cardía al cuore», che vorrebbe dire all’incirca «malattia di cuore al cuore! o qualcosa del genere; ed altre più avanti.
[5] Quando una donna non riesce ad allattare il proprio bambino si dice che ha il latte «impietrato», cioè fermo.
[6] Togliere (nel senso di far stare quieti).
[7] Raggrumato.
[8] Smettono.
[9] Il «malocchio», per chi non lo sapesse, non è una malattia; è la jettatura, cioè un’operazione malefica che si crede fatta col guardare invidiosamente. La credenza nel malocchio riflette una forma di superstizione antichissima.
[10] Pagliai.
[11] In Sicilia si designano ancora col nome di «feudi» le grandi proprietà terriere indivise, i latifondi.
[12] Misura di superficie, pari ad are 174,72.
[2] «Grup« o «crup»: laringite.
[3] Si rapprende.
[4] Vi sono espressioni in questo discorso che sarebbe inutile cercare di spiegare con termini razionali, perché di fatto non significano nulla. Come quella della «cardía al cuore», che vorrebbe dire all’incirca «malattia di cuore al cuore! o qualcosa del genere; ed altre più avanti.
[5] Quando una donna non riesce ad allattare il proprio bambino si dice che ha il latte «impietrato», cioè fermo.
[6] Togliere (nel senso di far stare quieti).
[7] Raggrumato.
[8] Smettono.
[9] Il «malocchio», per chi non lo sapesse, non è una malattia; è la jettatura, cioè un’operazione malefica che si crede fatta col guardare invidiosamente. La credenza nel malocchio riflette una forma di superstizione antichissima.
[10] Pagliai.
[11] In Sicilia si designano ancora col nome di «feudi» le grandi proprietà terriere indivise, i latifondi.
[12] Misura di superficie, pari ad are 174,72.
© Danilo Dolci, La patata in Racconti Siciliani, Torino, Einaudi, 1963
↧

































