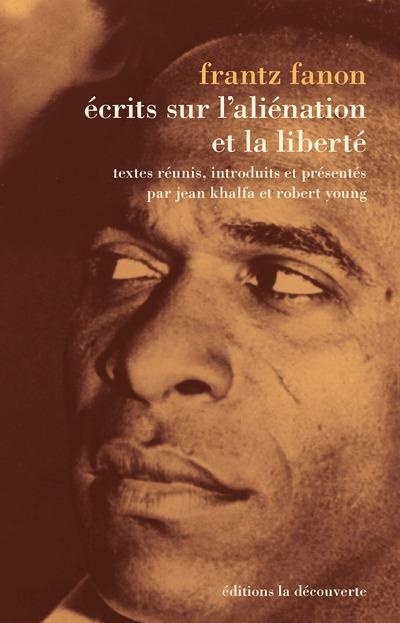Pasolini intervista E. Pound
Ezra Pound, il poeta fascista
di Augusto Benemeglio 1.Il grande fabbro della poesia moderna Ezra Pound , nato il 30 ottobre del 1885 nel profondo e provinciale Far West (Idaho) e morto il 4 luglio 1972 in una città irreale come Venezia , è stato il più internazionale , inevitabile, imbarazzante poeta del Novecento. E’ il poeta “fascista”, il poeta “traditore”, il poeta “pazzo” , che visse 13 anni della sua lunga vita rinchiuso nel manicomio criminale di Saint Elizabeth’s di Washington ; ma è anche il “grande fabbro” della poesia moderna , poeta “imagista” , che sposa le idee filosofiche di Hulme e spoglia i versi da ogni sovrastruttura retorica e sentimentale ; l’ideatore di una nuova poesia fondata essenzialmente sull’elemento visivo.
E poi sarà tante altre cose: il poeta della speranza di un rinascimento culturale americano, che pubblica i sonetti di Cavalcanti e fa conferenze a Londra sul poeta fiorentino stilnovista; il poeta “vorticista”, che esplora la complessità psichica dell’immagine poetica, ne complica l’espressione cercando effetti di simultaneità e di spazialità, (siamo nell’epoca delle innovazioni dell’arte, di Braque,Picasso , Matisse, Kandisnsky, Marinetti, etc) . L’immagine – dirà Pound – non è un’idea, è un nodo, un grappolo radiante, un
vortice. Ed ecco il “Vorticismo “ che , diversamente dall’ imagismo, che è statico, è il movimento racchiuso nell’immagine stessa . “Voi mi parlate di Marinetti? Ma Marinetti è solo un cadavere!”.
2. I Cantos E’ il poeta che postula la necessità dell’impersonalità della poesia ricorrendo alla tecnica delle “maschere”, maschere che non occultano, ma anzi disvelano. Infatti , nel suo viaggio cinquantennale attraverso il suo interminabile poema dei “ Cantos” , un’immensa enciclopedia poetica del sapere del nostro tempo , uno dei monumenti della poesia contemporanea in cui l’autore racconta la storia del mondo e di se stesso , ossia il suo inferno, il suo purgatorio, il suo paradiso , Pound è insieme Dante ( il suo inarrivabile modello , di cui si innamora fin giovanissimo, anche grazie a Henry Wadsworth Longfellow, lontano parente della madre, che aveva effettuato la prima traduzione in americano della “Divina Commedia” e fondato il Circolo Dante, nel 1867) e Virgilio, guida e viaggiatore, giudice e peccatore , spettatore e protagonista.
I
Cantos– dice Montale – contengono tutto lo scibile di un mondo in disfacimento e in essi il senso del
carpet domina su quello d’una costruzione ,di un avvicinamento a un centro… I troni nel paradiso di Dante sono assegnati alle anime delle persone responsabili di buon governo, i troni dei “Cantos” rappresentano uno sforzo per uscire dall’egoismo e per dare la definizione di un ordine possibile o comunque concepibile sulla terra”. In quel suo poema che rifà la storia dell’umanità, in cui le epoche e le civiltà più remote e diverse si sovrappongono e s’intrecciano , così come l’impasto di lingue e stili diversi , toni lirici e toni saggistici, il balenare di immagini pure e definitive in un apparente accumulo di dati materici , qualcuno ci vede una miniera di splendidi frammenti lirici, una scarica elettrica di versi di straordinaria intensità e innocenza lirica , versi talora delicati e rigorosi nella loro libertà. E per quanto sia forse arbitraria e spesso inafferrabile la struttura complessa del suo poema , – dicono alcuni studiosi – essa ha un’importanza notevole , ed esercita un fascino immanente. Dopo di lui la poesia di lingua inglese non è più stata la stessa, – dirà Auden, – è uno dei maggiori innovatori dell’arte novecentesca. Le avanguardie novecentesche devono molto a
Zio Ezra , gli devono il coraggio di uno sguardo sempre volto al “nuovo” (
Make it new era il suo motto) , ma anche l’esempio di come conservare il meglio delle tradizione del passato, occidentale e orientale . Si può dire che non ci sia autore di versi che non abbia imparato qualcosa da lui , come nessuno scrittore di racconti è privo di debiti nei confronti di James Joyce , che fu una delle tante scoperte di quel formidabile cacciatore di geni che era Pound . Fu lui che fece pubblicare l’
Ulysses a Sylvia Beach , a Parigi, e lo difese quando lo accusarono di pornografia; fu lui che scoprì Eliot e “La terra desolata” , di cui fece anche uno spietato “editing” di riduzione che varrà , in seguito, al poeta americano , il nobel per la letteratura; fu lui che insegnò a Hemingway ciò che si deve scrivere e ciò che non si deve scrivere.
3.La radice di ogni male è l’usura Ma cosa ci vuol dire Pound con questo vertiginoso poema i cui procedimenti stilistici si fanno via via sempre più ardui ed ellittici , con tecniche espressive fatte quasi interamente di citazioni e ideogrammi cinesi che rendono assai problematica non solo la comprensione del testo , ma la sua stessa lettura? Pound dice che la poesia per essere davvero nuova e rivoluzionaria deve essere totale , la poesia è anche storia, società , politica, economia . La poesia diventa giustizia internazionale contro la corruttela del mondo finanziario, dei traffici bancari, dell’usura. Ecco l’intuizione! La radice di ogni male , di ogni decadenza, di ogni corruzione è annidata nella pratica dell’usura , e quindi nell’istituzione quattrocentesca delle banche e dei banchieri, e quindi negli ebrei che la praticano da sempre. E per rimanere fedele a questa idea ispiratrice singolare quanto maniacale , al suo ruolo di poeta e di educatore della poesia , ruolo a cui si sentiva vocato e che s’era scelto fin dall’inizio dei suoi precocissimi studi classici ( “Già a quindici anni, -scrive in
How I began , – sapevo esattamente ciò che avrei voluto fare… Decisi che a trent’anni avrei saputo tutto sulla poesia , più di ogni altra persona al mondo; avrei saputo distinguere il contenuto dinamico dal guscio , e riconoscere ovunque la poesia, in qualunque lingua fosse stata scritta” ), Pound commette una serie di errori grossolani , dolorosi e tragici. Un uomo gentile , un sognatore che studiò le lingue classiche , le letterature romanze, Dante, Cavalcanti e Villon , e poi Confucio , il cinese e il giapponese , un uomo di cultura , di larghe vedute , un poeta inquieto e combattivo , errante , ma non reietto , diventerà , via via , in una sorta di drammatica escalation , antisemita, fascista, traditore, pazzo.
4. Fuochi d’artificio stravinskjiani Ma altri affermano che zio Ezra non era affatto pazzo ( quello di farlo ritenere infermo di mente fu un espediente del suo avvocato per sottrarlo alla condanna a morte) , e le sue poesie non sono quelle di un pazzo , altrimenti lo sarebbero i tre quarti degli scrittori contemporanei . Ma forse Pound non era neanche quel gran poeta che si vuol far intendere . Per carità, dice Montale, ottima persona , buona , generosa ,che accoglieva e sfamava giovani aspiranti scrittori che lo venivano a trovare a Rapallo ,nella sua torre d’avorio e ”ombelico del mondo”, dov’era la sua casa, organizzava stagioni di concerti di musica rara per la sua compagna violinista Olga Rudge ( si era improvvisato critico musicale a Venezia, ventitreenne, per sbarcare il lunario, ma poi aveva scoperto che la musica ce l’aveva dentro, in modo prodigioso, e la studiò davvero e fino in fondo, fino a divenire un raffinato compositore) , ed era sempre dignitoso, cortese , umano , grande giocatore di tennis e quasi altrettanto professionale scopritore di geni che non sempre si dimostrarono tali. Per il resto – dice sempre Montale – era uno che si era divertito a giocare con le parole , che aveva ridotto i fatti della storia ( cinese, giapponese, italiana) ad altrettanti stravinskjiani fuochi d’artificio , o a quadri cubisti di Braque e Picasso, a costruzioni ideogrammatiche, a esperimenti su teorie dell’inconscio collettivo. E questo fu – forse – il sospetto che turbò sempre qualcuno tra i suoi migliori amici , letterati e artisti , parliamo di Eliot ,Cummings, Hemingway, Williams, Lowell, Elizabeth Bishop , Cyril Conolly, Ginsberg, Ungaretti, Sheri Martinelli, Bukowsky , Frost , Palazzeschi, Saba , Ungaretti , Picasso, Bogart, Caproni, Luzi, Moravia, Rebora, Pasolini , Fernanda Pivano , tutti coloro che si mobilitarono per chiederne la liberazione .
5. Mary de Rachewiltz E la Corte Suprema, su mozione del giudice Thurman Arnold , dopo ben 13 anni , lasciò cadere l’accusa di tradimento e fece uscire dal manicomio (siamo nell’aprile del 1958 ) il più famoso imputato e ricoverato d’America sotto custodia della moglie Doroty Shakespear, che lo aveva conosciuto nei salotti di Londra cinquant’anni prima , nell’agosto del 1908 , e se ne era subito innamorata. ”Pound ha imparato a vivere fuori del suo corpo. Lo vedo come una persona duplice , tenuto insieme dalla carne… Può anche languire la fame , ma il suo spirito riuscirebbe sempre a perseguire la più alta delle arti, la poesia. Per lei si può anche morire, mi ha detto un giorno”. Si erano sposati nel 1914 e negli anni ’20 erano andati a vivere a Parigi ( la Parigi di Hemingway, Joyce, Eliot, Satie, Picasso, Tzara, Cocteau) , dove Ezra avrà una relazione anche con la violinista Olga Rudge, da cui nel 1925 , quando si saranno ormai stabiliti a Rapallo, in un
menage a troi, nascerà la figlia Mary.
Ed è proprio dalla figlia , ormai contessa Mary de Rachewiltz , (ha sposato il nobile egittologo Boris de Rachewiltz) , nel castello di Brunnenburg , vicino Merano , che il poeta andrà a vivere subito dopo essere stato liberato ( luglio del 1958). Con la figlia , che sarà devota custode , traduttrice ed esegeta della poesia del padre , rimarrà per circa tre anni , poi andrà a Roma e infine si stabilirà definitivamente fra Venezia e Sant’Ambrogio di Rapallo , dove , ormai ultrasettantenne , continuerà a scrivere. Ma le sue vecchie certezze lo avevano ormai abbandonato da tempo. E sebbene continuasse a lavorare a “I Canti”, sapeva che erano stati il suo fallimento , sia come artista sia come uomo. Si pentì di molte delle sue azioni passate, tanto che in un’intervista con Allen Ginsberg del 1967 si scusò di quello “sciocco e provinciale pregiudizio dell’antisemitismo”. Distrutto da quei durissimi anni di sofferenze sia morali sia fisiche trascorsi in manicomio , “anni immedicabili” , dice Fernanda Pivano , che ne raccoglie il dolore in un ritratto commosso e nostalgico, “ sembra davvero che su quest’uomo il sole sia tramontato” , ben presto Ezra si ammalò e si chiuse in un silenzio quasi completo. Gli ultimi dieci anni li trascorse con Olga Rudge , la celebre violinista per la quale aveva scritto diverse opere musicali. Vivevano fra Venezia e Sant’Ambrogio, vicino Rapallo , in una spartana casetta immersa nel paesaggio ligure che domina “i Canti Pisani”, da molti ritenuto il suo capolavoro.
6. Ciò che tu sai amare rimane / non sarà strappato da te. Li compose , mentalmente , in una gabbia di ferro, costruita appositamente per lui nel cortile della prigione militare di Metato, presso Pisa, dove lo avevano rinchiuso , in isolamento , dopo essere stato prelevato da due partigiani e consegnato, su sua richiesta, al comando americano. L’Alta corte di Giustizia degli Stati Uniti l’aveva ufficialmente accusato di tradimento per aver diffuso durante la guerra propaganda antiamericana da Radio Roma. Su di lui era stata messa anche una taglia di mezzo milione di lire. Nella gabbia non c’erano sedie o brande, giaceva sul cemento, avvolto nelle coperte , bruciato dal sole, bagnato dalla pioggia; chiuso in gabbia , dove vento e pioggia sono “parte del processo” , e solo la luna gli è sorella . forse la stessa luna a cui anche l’amato Leopardi aveva affidato il proprio dolore , traduce Confucio , l’unica cosa che ha portato con sé, e compone buona parte dei Pisan Cantos, il suo Inferno, il confronto tra sofferenza individuale e sofferenza storica, in attesa di una condanna a morte ( viene trasferito nella
death row, cella dei condannati a morte) in cui come un proiettore che si sia incantato la memoria continua a mandare la stessa immagine, ecco Omero, le Muse e John Donne, – Nessun uomo è un isola, intero da solo, – ecco Ernest Hemingway , con la sua campana, – “Ogni morte di uomo mi diminuisce perché sono parte dell’uomo/ e così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana, / essa suona per te”
7. La bellezza dell’erba Immaginate – scrive Montale – come si possa radiografare il pensiero di un condannato a morte dieci minuti prima dell’esecuzione capitale, e supponete che il condannato sia un uomo della statura di Pound e avrete i Canti Pisani: un poema che è una fulminea ricapitolazione del mondo senza alcun legame di tempo e di spazio . Migliaia di personaggi, fitto intarsio di citazioni in ogni lingua , ideogrammi cinesi, allusioni a tutto ciò che per cinquant’anni ha alimentato , nella storia, nella filosofia, nella medicina, nell’economia o nell’arte il pensiero moderno , non senza salti vertiginosi nel mondo del mito e della preistoria . Poesia – pittura a spicchi , ai limiti del non figurativo , mosaico fatto a pezzi e poi ricomposto senza che le tessere siano per nulla accostate. Chiuso nella
death row, Pound afferra spicchi di fotogrammi , spiragli di esistenza, pezzi di cielo , zaffate e suoni improvvisi, un gatto che attraversa il rettangolo del suo campo visivo, una piccola cavalletta verde senza una zampina. ”Le cose belle sono difficili da capire veramente”. Prova a capire la difficile bellezza dell’erba che cresce sotto la tenda infernale della morte, la bellezza del gesto pietoso, o delle nuvole, o della polvere sul fondo d’una vasca, la bellezza della propria sofferenza:
Ciò che sai amare rimane, /il resto è scoria.
E’ tutto qui il simbolo dei canti pisani ed è anche il simbolo di come la poesia vinca ogni barriera ideologica. E anche quando verrà internato nel manicomio criminale di Saint Elizabeth , Pound non smetterà di essere ombelico del mondo dell’arte ; come davanti ad un Prometeo incatenato sfileranno in quella stanza artisti, giornalisti, critici, amici di tutto il mondo.
8. Morì sradicato Ma ormai è stanco, i sogni cozzano l’uno contro l’altro e si frantumano.
Ho perso il mio centro/ a combattere il mondo.
Come aveva previsto ( era stato sempre una specie di chiaroveggente, anche nei confronti di se stesso) e come aveva lungamente desiderato morì a Venezia , la città che aveva intensamente amato , il giorno dei santi , due giorni dopo aver compiuto gli ottantasette anni. Si era preparato prima della confessione , “querulo come le allodole sopra le celle dei condannati a morte”. Morì da sradicato, qual era sempre stato . Il solito Montale disse che in Pound lo sradicamento fu quasi un’involontaria autodistruzione. E lui stesso ammise che era abituato a sentirsi un estraneo. “Per me sentirmi a casa significa essere straniero in un posto o nell’altro”. Non era riuscito ad arrivare alla meta prefissata – il centoventesimo canto. Si era fermato al centosedicesimo, che aveva tutta l’aria di un congedo anticipato: “ un po’ di lume come un lume di paglia, per ricondurre allo splendore”. E in qualche modo chiude il cerchio con la sua prima raccolta di poesie,
A lume spento. E privo di candele, il vecchio zio Ezra se ne era andato ancora pieno di candore , dopo una vita intera passata a risalire le correnti , come un salmone , e fare il grande periplo che spinge le stelle alla nostra riva. dopo aver varcato le colonne d’ercole , le sbarre di Lucifero e chiarità di diamante dei cieli della Nord Carolina . Ezra se ne era andato sereno , coll’ultimo giorno di lettura e in mano la chiave di liuto e del mondo. Forse aveva ricordato i suoi grandi errori, come quello di paragonare Mussolini a Thomas Jefferson, uno dei padri della sua patria americana.
9. Il suo incontro con Mussolini Il Duce lo aveva ricevuto, dopo tante insistenze, a Palazzo Venezia, il 30 gennaio 1933, dapprima incuriosito da questo strano poeta americano che parlava un italiano trecentesco, Voi siete degno di grande ammirazione, Duce. Siete la guida di un popolo “immaturo” così come la intende Confucio . So che voi seguite , con magnifico intuito, le dottrine di Confucio . Con il Fascismo avete eliminato la disoccupazione lottato contro l’inflazione , migliorato il tenore di vita delle classi sociali medio-basse . Ho letto della battaglia del grano e delle bonifiche delle paludi . Voi, Duce, avete restituito all’Italia il senso della giustizia economica , che è alla base di uno Stato moderno, e quella dignità umana che era ciclicamente apparsa nei momenti più alti della storia dell’uomo e che ora rende il vostro meraviglioso paese degno del suo passato , e lo pone all’avanguardia di tutte le nazioni civili. Mussolini lo guardava perplesso, mentre il poeta si infervorava sempre di più.
Dovete, però, tener conto, Duce, delle teorie economiche di Gesell e Douglas , che sono basilari per uno Stato moderno e che ho riassunto nei miei “Cantos” , che vi dono con gioia e onore . Sono teorie fondate su una forte critica al sistema capitalistico usuraio e guerrafondaio , che io condivido al massimo grado. Il maggiore Douglas ha scoperto la “grande falla” dei grandi Stati di oggi , consistente in un potere economico interamente affidato ai grandi gruppi bancari che applicando un sistema usuraio (basato cioè sui prestiti a interesse) impoverirebbero le popolazioni , abbattendo il potere d’acquisto dei salari e provocando la paralisi del mercato. Vi farò avere , al più presto, un mio piano per una lega internazionale che sostituisca la Società delle Nazioni, “baracca di bari”.
10. Una mente nebbiosa Il Duce rimase perplesso di fronte a questo
bohemien americano che parlava un italiano trecentesco e sembrava vivere in un mondo tutto suo. Formalmente lo ascoltò, lo approvò, scrollando il mascellone , prese il libro con dedica , gli strinse la mano, e lo congedò . Poi non volle mai più riceverlo. E sul famoso “piano internazionale” , che il poeta aveva depositato un paio di anni dopo negli Uffici di Palazzo Venezia, fece scrivere una nota, ad uso interno: “ Si tratta di un progetto strampalato concepito da una mente nebbiosa , sprovvista di ogni senso della realtà. “
Ci si chiede come sia stato possibile che un uomo di tale statura intellettuale, – un uomo di grandissima cultura, che aveva conosciuto la vita democratica di Londra e l’esistenza libera di Parigi, un “chiaroveggente” a cui bastava un niente , anche quando gli venivano dati i più nudi dettagli , per riuscire a penetrare l’intenzione centrale di un autore, di una persona , di un fatto ,- avesse fatto un simile macroscopico tragico errore, perpetuato fino all’ultimo, fino allo sfacelo della guerra , fino alla Repubblica di Salò? Dire ai microfoni della radio , situato all’ultimo piano del MinCulPop , in via Veneto, nella trasmissione di “
Uncle Ez”, – che veniva ricevuta in tutta Europa e anche oltre oceano,- che la guerra non era stata cagionata da un capriccio di Mussolini, né di Hitler, ma dalla usurocrazia per trarne profitti. “Questa guerra fa parte della guerra millenaria tra usurai e contadini , fra l’usurocrazia e chiunque faccia una giornata di lavoro onesto con le braccia o con l’intelletto, questa è la guerra dell’usura contro l’umanità; ovvero degli ebrei contro l’Europa.
11. Non vive la vita reale, come tutti i poeti In realtà Pound non fa altro che rimaner chiuso nella sua torre d’avorio di Rapallo , e ne esce solo per entrare nella gabbia di Pisa, e poi nella stanza di un manicomio criminale. Non vive mai la vita reale, come tutti i poeti .( La vita la si vive o la si scrive, disse Pirandello) . Il fatto è – scrive Contini – che tutto cospira a farci credere che l’Italia di Pound non sia mai esistita, o al massimo fosse un paese archeologico produttore di una lingua morta, qualcosa di profondamente etnico.… Se vogliamo il cosiddetto tradimento di Pound anticipa la “Grande Disobbedienza” che scoppierà in modo massiccio durante la guerra del Vietnam, quale ne fosse il quasi irrilevante segno, destra o sinistra. Ezra – scrive Montale – difese allora non l’Italia reale , della quale s’infischiava , ma la cornice dei suoi sogni ad occhi aperti . Antiquario senza saperlo, custode del museo del suo cuore , egli leggeva le nostre vecchie cronache per cercarvi qualche episodio eccitante, qualche parola peregrina.
A Rapallo, qualche tempo dopo il suo ricovero nel manicomio di St. Elizabeth, (siamo nella primavera del 1948) un migliaio di cittadini , con a capo il Sindaco, firmano una dichiarazione con cui si afferma che Pound non aveva mai svolto attività fasciste, ma esclusivamente artistiche-culturali; che non aveva mai usufruito di privilegi da parte dei fascisti , e non aveva mai compiuto atti di antisemtismo. Era vero, ma gruppi e movimenti di estrema destra non cesseranno mai di strumentalizzare la figura di Pound per farne un paladino delle loro ideologie ( vds. i cosiddetti ”Gruppi di Casa Pound”).
12. Al tramonto E sul finire della sua vita, Ezra , per quanto spento, assente, ormai ridotto ad un ectoplasma , ebbe barlumi di coscienza di tutti i suoi errori, dei suoi fallimenti, delle sue amare sconfitte, dei suoi rimorsi di uomo e di poeta. Sapeva che ormai la bellezza era per sempre perduta “ per mancanza di energia nella mano che scrive” . Così lo ricorda Fernanda Pivano, in un giorno trascorso assieme a lui , e ad Allan Ginsberg , una gita da Sant’Ambrogio a Portofino , alla fine del 1967. “Il poeta era indifferente, muto , curvo, con una sciarpa al collo , che gli aveva messo Olga Rudge, e un bastone… Non aveva mai parlato, se non a monosillabi, ma ogni tantomi lanciava uno di quei suoi sguardi penetranti come lame, che mi ricordavano quelli del St Elizabeth…
Al tramonto ritornammo a Sant’Ambrogio; Olga lo accolse sorridendo e mi chiese sottovoce alle sue spalle se tutto era andato bene. Sì, tutto era andato bene, dissi”. Bene non era andato però il destino di questo genio falcidiato dalla vita , che aveva provato a capire come la bellezza sia legata – indissolubilmente – alla sofferenza , e la sua sofferenza era diventata la sofferenza della storia , e com’era ancora così pieno di rimorsi! Nell’ultimo frammento dei “Cantos” scrive: “Mi perdonino gli dèi per ciò che ho fatto./ Cerchino coloro che amo di perdonarmi ciò che ho fatto”.
Augusto Benemeglio Roma, 16 gennaio 2016 Testo ripreso da
https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/